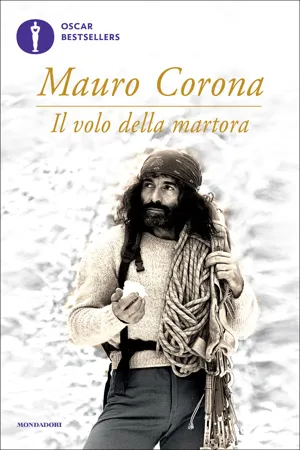Fino ai giorni tragici del Vajont, nell’ottobre del ’63, non avevo ancora posseduto un paio di scarpe. Le nostre calzature di bambini dei monti erano gli scufòns. Venivano confezionati a mano dalle donne, trapuntando uno sull’altro diversi strati di tessuti per formare la suola. La tomaia invece era in velluto nero, rinforzato all’interno da robusta tela e con un fiorellino dai colori sgargianti ricamato sulla punta. Il tipo di fiore variava a seconda dei paesi, in modo da poter riconoscere la provenienza.
Gli scufòns erano strumenti da corsa molto pratici. Veloci da calzare perché privi di legacci, si logoravano però molto presto. La nonna faceva fatica a rifornire tutti i nipoti perché li demolivamo in pochi giorni di continue scorribande per boschi e rocce. Giungeva allora in suo aiuto una religiosissima zia sordomuta, nubile, pia e altruista al punto da essere ritenuta, in paese, una santa. Questa zia, la notte che il monte Toc precipitò nell’acqua del Vajont, mi offrì l’opportunità di compiere, a tredici anni, un gesto di coraggio di cui ancor oggi vado fiero. Al boato tremendo della frana che cadeva, eravamo fuggiti tutti come lepri. Io scappai con la nonna e, tenendo un mio fratello per mano e l’altro piccolo sulla schiena, mi rifugiai su un colle. Mio padre era in giro da una settimana a caccia sulle montagne. La vecchia zia sordomuta restò sola: non si era accorta di nulla. Dai prati dove ci eravamo riparati, nessuno voleva rischiare di tornare giù per metterla in salvo. Io volevo bene a quella brava donna: era lei che ci curava, che ci lavava i vestiti, che ci accudiva insomma, perché nostra madre s’era perduta da tempo in città lontane. Senza esitare tornai nella casa che ancora vibrava per lo spostamento d’aria e, col terrore che mi paralizzava, riuscii a tirar fuori la vecchia da quella pericolosa situazione.
Era lei l’esperta fabbricatrice di scufòns della famiglia. Nelle lunghe sere invernali, accanto al fuoco, preparava le suole di pezza, trapuntando per ore e ore con ago e filo, senza mai levare il capo dal lavoro. Oppure, con la piccola macchina da cucire Singer a manovella posta sulla panca del camino, costruiva le tomaie ritagliandole da un bel velluto nero e liscio su cui il fiore colorato risaltava in maniera vivacissima. Così facendo si portava avanti col lavoro poiché sapeva che a primavera ci saremmo scatenati in corse forsennate, distruggendo molte paia di quegli umili calzari. D’inverno mettevamo le galosce di legno che mio nonno costruiva ad arte, da abile artigiano qual era. La neve veniva giù piano piano, fitta e quieta, e noi guardavamo in silenzio fuori dalla finestra i lenti fiocchi che scendevano. In mezzo ad essi scorrevano lontani i ricordi dell’estate, mentre i colpi dell’attrezzo sul ceppo, ritmati dalla mano sapiente del nonno, rompevano il magico silenzio dell’inverno.
Di galosce ne avevamo anche un paio speciale con la suola opportunamente piallata e liscia. Venivano usate a mo’ di pattini in rischiose discese sulle ripide stradine gelate del paese. Avevamo raggiunto, in questo sport, un equilibrio da far invidia ai funamboli del circo, che in seguito mi aiutò non poco nelle arrampicate su roccia.
Erano queste, fino all’ottobre del ’63, le nostre uniche calzature.
A essere sincero, un paio di scarpe le avevo avute, qualche anno prima. Vicino al paese c’era una discarica, anzi, in giro ce n’era più di una perché allora la gente non era ancora animata dalla fiamma dell’ecologia e buttava qua e là, un po’ dove capitava, il poco scarto prodotto dal vivere quotidiano. Noi ragazzi rovistavamo spesso in questi immondezzai poiché, con un po’ di fortuna, ci si poteva imbattere in qualcosa di utile. E poi, cosa più importante, andavamo a caccia dei tubi di conserva vuoti avendo scoperto che, schiacciando con forza l’imboccatura rotonda, usciva ancora qualche centimetro di sugo. Forse è proprio frequentando quei luoghi da pantegane che ho sviluppato gli anticorpi necessari a non crepare d’infezione, quegli stessi che oggi aiutano ancora la mia salute.
Fu appunto in una discarica che un giorno d’estate trovai il mio primo paio di scarpe. Ne individuai subito una, ma la seconda mi fece penare non poco prima di lasciarsi appaiare alla sorella. Erano due scarponcini a punta quadrata color marroncino chiaro, con una fibbia sul bordo esterno e privi di stringhe.
A quello sinistro mancava l’intera suola mentre l’altro era completamente scucito da un lato.
Li portai a casa e li feci vedere, entusiasta, a mio nonno che valutò di poterli recuperare e si mise subito all’opera. Era abile il vecchio, e con le mani sapeva fare di tutto. Si procurò da un calzolaio del paese una suola usata e con dei chiodini piccoli piccoli la fissò allo scarponcino mentre io seguivo impaziente il lavoro.
Poi, usando del filo passato nel sapone e forando la suola con la subia, la cucì tutt’attorno. Tagliò quindi con il coltello la parte che debordava e uno scarponcino fu pronto. Il nonno riparò anche l’altro, provvedendo a cucire lo strappo che sembrava una bocca ghignante.
Il giorno successivo al fortunato ritrovamento gli scarponcini erano a posto e li provai. Mi stavano un po’ grandi ma, mettendo due paia di calze grosse, mi andavano abbastanza di misura. Ero raggiante. Il vecchio li aveva unti col grasso di maiale che tenevamo sempre appeso sotto al soffitto, così da farli sembrare proprio nuovi.
Ma la gioia di possedere un paio di scarpe vere, di quelle che vedevo nelle vetrine di Longarone quando andavo con mio padre a vendere i galli forcelli o le pelli delle volpi, doveva durare poco. Verso sera me ne stavo orgoglioso sulla piazzetta del paese assieme agli altri ragazzi compagni di giochi, quando una donna sui quarant’anni, dopo avermi osservato, si avvicinò. Calò lo sguardo per un attimo sui miei piedi poi, col tono sicuro e sprezzante di chi è senza pietà, sbottò:
«Quelle scarpe sono mie.»
Sentii la vergogna e l’umiliazione cambiare il colore del mio viso e cercai di salvarmi come può farlo un bambino di undici anni.
«Io non so niente» risposi «le ho trovate nel Rio di Valdenere che le avevano buttate via.»
«Lo so» ribattè la donna, seccata «le ho buttate via io stessa, e tu dovevi lasciarle dove erano.»
A quell’età non conoscevo ancora la malvagità gratuita perciò mi prese una paura folle di aver combinato qualcosa di grosso.
«Se vuoi te le ritorno» dissi intimorito e umiliato mentre un odio feroce mi suggeriva di scagliarmi contro quella carogna.
«Si, adesso me le ridai,» rispose la vigliacca fiera della sua forza «e subito, altrimenti chiamo i carabinieri.»
A quelle parole pensai al nonno e me lo immaginai mentre veniva portato in prigione. Senza fiatare tolsi dai piedi gli scarponcini, lentamente, sperando che intanto qualche adulto intervenisse in mio aiuto. Ma in quel momento sulla piazza c’erano solo bambini. Consegnai allora quelle scarpe tanto desiderate nelle mani della megera che se ne andò soddisfatta avvertendo:
«La prossima volta lasciale dove sono, capito?»
Tornai a casa in calze soffocando le lacrime perché, mi avevano insegnato che non bisogna mai piangere. Mio padre durò non poca fatica a frenare l’ira del nonno che, armato di manéra, era partito per andare a punire la malvagia.
Non ho mai saputo se la donna buttò via di nuovo le scarpe o se le tenne per sé, visto che erano tornate come nuove. Qualche anno dopo accaddero i fatti del Vajont e di scarpe ne circolarono fin troppe. Ce n’erano talmente tante che qualcuno ne scaricò un intero camioncino in una forra perché rischiava di essere scoperto mentre le stava rubando per rivenderle.
Noi due fratelli fummo portati al collegio Don Bosco di Pordenone dove restammo ospiti tre anni e dove si provvide a sgrezzarci un po’. In quel periodo avevamo calzature ottime ma mancavano i prati per volarci sopra. Fra quelle mura però imparai molte cose e mi fu insegnato l’amore per la lettura, per i libri, per l’arte. Sarò grato fin che vivo ai preti del Don Bosco, anche se oggi va di moda rinnegare gli antichi maestri e disprezzare l’opera dei sacerdoti.
Adesso le ditte produttrici di scarpe, zaini e corde mi regalano tutti i materiali che voglio, purché faccia delle foto pubblicitarie con i loro prodotti. Ma ormai gli entusiasmi sono passati, e sogni non ne faccio più. Anzi sento che presto non avrò più bisogno di niente per scalare le montagne: tornerò a camminare scalzo per sentire il contatto con la terra, finché questa non si aprirà per accogliermi con sé.
Siamo alle soglie del terzo millennio, e molto tempo è trascorso dal triste episodio delle scarpe sottratte. Incontro quasi tutti i giorni quella donna bieca, ormai invecchiata: la mia bottega di scultura si trova di fronte alla chiesa e la vedo che va sempre a Messa.
Forse lei non ricorderà neppure quel lontano gesto di inutile malvagità.
O forse va a Messa proprio per farselo perdonare dal buon Dio. Lui, nella sua grande misericordia, sicuramente lo ha già fatto. Io, nonostante l’azione benefica che produce sull’animo la lima del tempo, non ci sono ancora riuscito.
Scende il vento dell’estate dalla cresta affilata e accarezza dolcemente la montagna misteriosa. Lui sta seduto sul colle, sotto quella montagna, tra le erbe che già emanano odori d’autunno. La sua casa è a pochi passi, anch’essa nascosta dall’erba del tempo. Sul prato un bottiglione. Ogni tanto tira un sorso e si gira a guardare i camosci. Alzando il braccio li indica porgendomi il binocolo. Sono quindici camosci che pascolano tranquilli sul costone di Cerenton. Camosci belli, grandi, con le corna lunghe e sottili come si trovano solo quassù, sulle Alpi Carniche, oppure in Abruzzo. Un tempo li cacciava ed era diventato il più bravo di tutti.
Aveva incominciato a cacciare da ragazzino, assieme ai vecchi e taciturni maestri di allora, che ogni tanto ama ricordare con nostalgia e ammirazione. Rimasto orfano di entrambi i genitori appena nato, aveva dovuto imparare subito a difendersi per sopravvivere. I burberi cacciatori di camosci se lo tiravano dietro nelle battute, usandolo come cane da ricerca. Il suo compito era quello di stanare la selvaggina; aggirandola e facendola fuggire con urla e colpi di fucile, la spingeva astutamente verso le poste ove i colpitori aspettavano guardinghi e silenziosi.
Fegato, polmoni e cuore della bestia venivano mangiati subito, sul posto, dagli affamati cacciatori. Il resto si portava a casa per sfamare le famiglie.
E venne il giorno in cui anche lui uccise il suo primo camoscio e, come impone il rito, dovette bere il sangue della bestia abbattuta. Piano piano, anno dopo anno, imparò i trucchi del mestiere e come spesso succede ai creativi ne inventò di suoi per catturare le prede. Gli piaceva stare nei boschi e tra le rocce vivendo di ciò che la natura offriva.
Anche oggi che il suo volto s’è spento nella tristezza e le gambe lo spostano di malavoglia, se insisto un po’ mi porta a raccogliere infinite qualità di erbe commestibili e funghi dai colori sospetti, a me sconosciuti, che si rivelano squisiti.
Quando il sole scioglie la neve e i primi tepori risvegliano la vita, si siede, nella luce dell’alba, vicino al grande faggio. Da quel posto, sulla curva della strada, nel punto esatto dove in primavera fiorisce un maggiociondolo, ascolta il canto d’amore dei galli forcelli che s’azzuffano sulle nevi del Borgà e ricorda, guardando le cime, i tempi in cui andava a cacciare quelle splendide bestie dalle creste rosso sangue e la coda ritorta a forma di lira.
Aprile e maggio erano i mesi buoni. In quei mesi vagava nei boschi camminando tutta la notte. Doveva trovarsi sul posto ai primi chiarori dell’alba pronto a colpire il maschio che a quell’ora cerca l’amore della compagna.
Cucinati con qualche accorgimento, i galli erano buoni da mangiare, ma il loro valore era nel trofeo della coda. Da Bolzano o da Dobbiaco, a fine stagione, arrivavano al villaggio pittoreschi personaggi ad acquistare code che fissavano sui cappelli quando partecipavano alle feste in costume dei loro paesi. Una bella coda di gallo vecchio, con cinque penne storte, poteva rendere l’equivalente di centomila lire d’oggi.
Per quanti anni è vissuto in questo modo? Molti dice, ma allora era giovane e oggi è convinto che non serva a nulla ricordare quei tempi.
Poi la necessità, il miraggio del guadagno, l’illusione di un amore, lo portarono a visitare la Svizzera. Lì ebbe una famiglia, dei figli, conobbe forse un periodo felice che dai suoi mugugni però si indovina molto breve.
Infine il ritorno al paese. Solo.
La gente che non sa, ma che mangia bene tutti i giorni, fa presto a criticare il comportamento altrui. Ma vi sono legami genetici che vanno oltre la forza della paternità o dell’amore per una donna. Sono quelli che il chiodo degli avvenimenti incide sul nostro DNA. Non è vero che il DNA si eredita, il DNA lo si costruisce nel periodo della prima infanzia. Uno può ereditare dai genitori la linea dei tratti somatici ma quella del cuore si modifica a seconda del destino. Un bambino che nasce da genitori allegri e ottimisti dovrebbe, in teoria, assomigliare ad essi. Ma se questo bambino vive la sua infanzia nel dolore, nella miseria, nelle privazioni, nei patimenti, e se per di più è orfano, non sarà mai allegro. Diventerà triste. E così rimarrà per il resto dei suoi giorni perché il suo codice genetico è stato graffiato dall’unghia della tristezza e se metterà al mondo dei figli saranno anch’essi tristi, in origine. Ma quei figli, crescendo, scolpiranno il loro codice in relazione al modo con cui verranno trattati dalla sorte e cambieranno a loro volta la prima scrittura genetica ricevuta dai genitori.
Il richiamo che fece tornare l’amico era quello dei boschi, delle acque, degli inverni ovattati, dei bivacchi accanto al fuoco sotto i landri rocciosi del Bosco Nero o del Col Alto, assieme al ricordo dei vecchi cacciatori che lo avevano iniziato. E tornò col pensiero alle notti inquietanti quando tredicenne aspe...