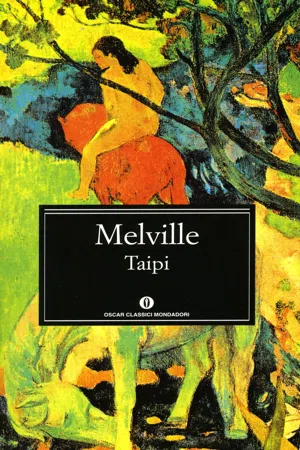
- 336 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
La cronaca di quattro mesi trascorsi dall'autore giovanissimo nell'isola di Nukeheva nell'arcipelago delle Marchesi; un breve soggiorno in un "paradiso terrestre" a stretto contatto con le tribù guerriere dei Typee. Il racconto commosso dell'incontro fra la vita indigena e la poco illuminata opera dei civilizzatori.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Print ISBN
9788804247470eBook ISBN
9788852055430Introduzione
Torni il dolce ozio senza speme o pianto;
sudin le querce i mèl, corrino i fiumi
nettare e latte, i dolor sien cacciati,
ardan di dolce amore i cor beati.
Lorenzo il Magnifico,
Selve d’amore, II, 117.
Selve d’amore, II, 117.
Tramonto del buon selvaggio
Ogni libro ha un destino iscritto nel suo paragrafo iniziale.
È l’idea germinale, la declinazione originaria. Le frasi e le pagine che seguono costituiscono lo sviluppo di questa sorta di “cantami, o Diva”. Nessun libro sfugge alla logica della favola, e al di là di essa del mito.
Di più: il primo libro di uno scrittore contiene in nuce tutti i libri che architetterà più tardi.
Non fa eccezione Taipi, non fa eccezione Melville. E poco importa se il suo nome è pressoché sinonimo di un libro solo, Moby Dick o la balena: al punto che gli altri, precedenti e successivi, frutto di quarantacinque anni di testarda attività amanuense, quasi sempre passano per appunti, progetti, schemi, riduzioni, ripetizioni di quell’opera fondamentale. Che però tale è diventata, nella collocazione critica di Melville, soltanto in tempi relativamente a noi vicini, in pratica dopo la Prima guerra mondiale, in seguito alla pubblicazione delle biografie e degli studi di Weaver, Mather e altri nel centenario della nascita dello scrittore avvenuta nel 1819. Non va infatti dimenticato che Moby Dick al suo apparire (1850) non suscitò certo l’entusiasmo dei contemporanei, critici e pubblico, e nei necrologi che uscirono in morte di Melville (1891) invano si cercherebbe un accenno alla Balena. Per il pubblico, e per buona parte della critica, infatti, Melville era e restava l’autore di Taipi e di Omoo, cioè il presunto narratore di “avventure esotiche” nelle terre e nei mari del Sud.
La biografia di uno scrittore ha ben poca importanza; anzi, meglio sarebbe non saper nulla di lui, della sua vita, della sua origine, della sua sorte. Solo la pigrizia indotta nel lettore dalla critica che spiega, classifica, traspone a un altro livello semantico, storicizza, media, predetermina giudizi di valore, fa dei dati biografici, sempre e comunque esterni al libro, un punto di riferimento, un sostegno immaginario e fittizio. Diseducato, il fruitore ben difficilmente è un lettorattore; per lo più è, e s’accontenta di esserlo, un semplice lettore, passivo ricettore incapace di effettiva partecipazione. Ma nel caso di Taipi, e poiché scrivere un’introduzione significa in qualche modo accettare, pur contestandolo, il “gioco della critica”, alcuni dati biografici appaiono illuminanti. In primo luogo, il costante rifiuto di Melville a ridursi, nella considerazione propria e altrui, allo stereotipo dello scrittore di avventure, collocato accanto a R.H. Dana o a Fenimore Cooper, i due bestseller dell’epoca. Dopo un periodo di continua pubblicazione, durato un decennio, o poco più dal 1846 al 1857, Melville, si legge nelle storie della letteratura, «sembrò chiudersi in se stesso», lavorando «solo per sé» (come se qualsiasi scrittore che si rispetti facesse altro!), optando per un mezzo espressivo «assai meno diretto e diffuso» della narrativa, vale a dire la versificazione. Non gli importava dunque il successo, non teneva più a rivolgersi a un vasto pubblico? Ma è un atteggiamento che il critico di rado, e il lettore mai (non, insisto, il lettorattore), sono disposti a tollerare. Se ne sentono insultati, derisi, esclusi. È o non è, la letteratura a stampa, lo specchio stesso della democrazia intesa come livellamento? E perché il critico-lettore dovrebbe compiere lo sforzo di salire fin lassù, sulle vette irrespirabili, laddove è tanto più comodo e “giusto” costringere o persuadere con allettamenti soprattutto economici l’autore a scendere in basso? Il testo illeggibile, o per lo meno arduo, o che non risponde alle “legittime aspettative”, è dunque guardato con sospetto. E vadano al diavolo i Melville che non se ne danno per intesi. Sono occorsi così settant’anni perché Melville diventasse “il padre di Moby Dick” e si tenesse conto almeno delle sue allegorie, sia pure disconoscendo la forma in cui erano calate (e lo comprovano, tra l’altro, le vivaci diatribe tra i suoi traduttori, evidentemente incerti, al di là delle caratteristiche personali dell’interpretazione, sul modo con cui mettersi in sintonia con questa scrittura di ardua penetrazione); e perché sull’onda della scoperta di questo grande libro rinascesse l’interesse per l’opera – tutta quanta, questa volta, e spesso in maniera indiscriminata – dello scrittore americano.
La quale opera, come ho detto, è in un certo senso implicita nelle prime battute del Taipi. Sapore di mare, odore di terre lontane, promessa di avventure, certo; ma già, nell’ironia del dettato, il preannuncio di una visione ben diversa, di una catastrofe, d’un grande rifiuto, di una contestazione di fondo. Avventura minata dal verme implacabile del dubbio. E i mari del Sud come una mela marcia.
L’idea di avventura è recente; ed è romantica. Se ne possono, è vero, individuare gli antecedenti nella Cerca e nella Conquista. Ma la prima è un viaggio terreno verso una meta ultraterrena; il contenuto del Santo Graal è un liquore metafisico. Né lo è da meno la riduzione al cristianesimo-civiltà del “selvaggio”. C’è insomma uno scopo, una giustificazione, laddove il Romanticismo è la messa in opera di organismi ideali capaci di autodeterminazione, che hanno dunque in se stessi la propria ragion d’essere: organismi postkantiani, che decretano impossibile la metafisica e che si affermano quale che sia il prezzo che dovranno essi stessi pagare e che imporranno ad altri di pagare. Ciò non toglie che gli oggetti così formati continuino ad avere sostanza mitica; ma è loro tolto l’elemento mito-religioso. La favola, insomma, diventa genere letterario, non rimanda più ad altro. Il Romanticismo ha posto in essere, accanto ai soggetti d’obbligo della tradizione, altri protagonisti: l’Io, l’Interiorità, il Sentimento, il Sogno, l’Arte, il Popolo… E, proprio perché essi escludono da sé ogni giustificazione, proprio perché sono figli di una teologia decapitata come i re dalla Rivoluzione (logía, scomparso theos), ecco che saranno in perenne conflitto con l’alterità cui pretendono di voltare le spalle. Insomma, il Romanticismo è la proclamata (ancorché impossibile, e dunque velleitaria) negazione del mito, nel senso che all’origine tradizionale si vuole contrapporre un’altra fondazione: umana, tale il presupposto, e perciò concreta, pratica (in Marx, la storia che ha il volto economico della lotta di classe).
Il modello, tuttavia, resta lo stesso. La storia-favola non può uscire dai propri panni. La Cerca e la Conquista avevano affermato l’esistenza di un mondo puro: nell’aldilà o nell’ingenuità della selva. E in fin dei conti, erano tutt’uno: bastava conferire un senso e un simbolo alla miseria umana per saperla redenta. Il selvaggio aveva solo bisogno del Verbo; ma già possedeva la Parola. Doveva essere “rivelato a se stesso”, ecco tutto. Lo dice, chiaro e tondo, Garcilaso de la Vega el Inca, autore dei Commentari Reali degli Incas (Lisbona, 1609; Milano, 1977-82), né va dimenticato che la “Leggenda Nera” dei conquistadores è stata elaborata e diffusa proprio dai missionari. I sudditi degli Incas peruviani erano “cristiani inconsapevoli”: credevano in un dio unico, il Pachacámac, ma ignoravano l’Avvento. E compito della Conquista avrebbe dovuto essere di informarli che il Figlio di Dio si era fatto uomo, inaugurando il Nuovo Eone. Mancare a questo compito, e scambiare la Conquista per rapina e mera sottomissione, senza la luce della Verità, era un crimine e un peccato. Donde, appunto, la “Leggenda Nera”.
Gli oggetti-idee del Romanticismo sono invece, fin dall’inizio, e dichiaratamente, in conflitto con l’Altro. Non più accettato, l’Altro è necessariamente condannato alla distruzione. Solo così si opera la redenzione postmitologica (ma non certo postmitica) sulla terra. La sottomissione del selvaggio è l’indispensabile premessa della reductio ad unum industriale. E lo si proclama con tutti i generi letterari e artistici: romanzo, teatro, versificazione, saggio sociologico o filosofico; e dipinti e musiche magniloquenti, monumenti alle glorie del passato e alle immancabili del futuro. Ma si proclama anche qual è l’effetto devastante che ha il Nuovo Mito, l’assudditamento del mondo secondo la visione del tempo lineare, in nome della negazione della ciclicità del Mito Antico, lo svolgimento del gomitolo cosmico nei termini della prospettiva, verso il punto ideale della Fine della Storia (o della Preistoria secondo Marx). Lo si proclama, ma non se ne traggono le conseguenze della “coscienza inquieta”. Anzi, per lo più se ne afferma l’indispensabilità.
Il Nuovo Mito intanto distrugge e livella; porterà benessere e consapevolezza? Può darsi. Ma Melville non ci crede.
Collocato in questa temperie, Melville non può fare ancora sua l’idea dello scientismo come ratio salutare; né può dunque porsi al di fuori se non come narratore: non può farsi antropologo ed etnologo. Non sa mediare. La strada che gli si apre spontaneamente davanti è quella della denuncia. Il buon selvaggio, comincia a proclamare Melville, è un’illusione. In seguito, a partire almeno da Moby Dick, sosterrà che l’esistenza umana è tutta una maledizione.
Il mare, il viaggio, l’antenato
L’avventura postromantica è dunque fine a se stessa. Il viaggio è rivelazione, non però di una verità, bensì appunto dell’iter umano. Nessun angelo salvatore ci attende più sulla soglia finale. Ma nel 1846, all’età di ventisette anni, ancora incerto circa le sue vere intenzioni, forse restio a cedere alla voce che gli parla, in Taipi Melville non sa distinguere chiaramente tra verità e “verità”, tra corrispondenza delle idee con le cose e menzogna costitutiva della poesia intesa come un ri-velare che è in pari tempo, e anzi in primo luogo, un rimascherare ed escamotare. Melville ancora non sa discernere esattamente tra logico-discorsività e Dichtung, e ne vien fuori quel curioso ed efficace ibrido che è Taipi, incerto tra “saggio” e “racconto disteso” (uso i due termini solo per comodità, e consapevole del loro implicito riduzionismo). Non osa darsi del tutto a quelle forze che affrancano dal vero, cede ancora alle istanze che invocano l’“immediatezza” e la “sincerità” dell’arte.
Né poteva essere altrimenti, a ben guardare. Un decennio dopo, ritirandosi e chiudendosi vieppiù in se stesso, come gli rimproverano le storie della letteratura, Melville non fece che rifiutare, definitivamente ed esplicitamente, la diatriba, infuriante al tempo suo come oggi, tra laudatores temporis acti e progressisti. La coscienza americana si era scissa tra i due corni del dilemma già al tempo della Rivoluzione, dopo due secoli di fiducia nell’utopia (che non era ancora progressista) e di speranza nella sostanza redentrice del Nuovo Mondo. L’American dream aveva cessato di essere dogma già con il tardo Illuminismo. Il concetto della land of opportunities caro ai Franklin e ai Paine era crollato miseramente sotto le spallate dei pionieri della seconda e terza ondata: non più accordo e pacificazione con il cosmo, in precedenza apparso illimitato, e con i selvaggi che lo abitavano, bensì le rudi leggi della sottomissione e dello sfruttamento. Tant’è che la comunione con la natura in Thoreau era, appunto, scritta, recitata: esortazione, non più immediato sentimento. Anche per effetto dei fermenti del Romanticismo europeo, la coscienza americana era ormai percorsa da dubbi e brividi pessimistici, e Hawthorne in The Blithedale Romance (Il romanzo di Valgioiosa, 1852) opponeva una critica spietata al modello dell’“utopia comunitaria” elaborato anni prima a Brook Farm in un clima di socialismo foureriano: la liberazione generale, equivalente mondano della Redenzione, e soprattutto l’emancipazione femminile, non sono possibili e anzi i tentativi stessi di realizzarli generano sgomento perché impongono, e invano, un prezzo esorbitante.
Con questo, non si vuole affatto dire che tutta l’America fosse in preda al dubbio. Al contrario: si ha a che fare, semmai, con una schisi personale e collettiva. Melville non sapeva resistere al richiamo dell’avventura, della “pessima educazione” occidentale; e lo deprecava, lo negava, lo scavava a fondo, andava dietro lo specchio, scoprendovi un deposito di antichissimi scheletri. E, collettivamente, sempre più netto si faceva il distacco tra “anime belle” e nuova barbarie. Nel nostro secolo, le prime sarebbero divenute la legione degli espatriati, della Lost Generation e, più modestamente, degli easy riders. Ma se ciò avveniva, era perché il cosmo si era rimpicciolito, facendosi troppo angusto per le brame di conquista, dal momento che il tempo si era contratto al punto da diventare moneta: e non c’era più posto, in esso, per l’immobilità della selva.
Nel pieno della mischia, Melville non sapeva sottrarsi a un eccesso di pathos, non poteva fare a meno di proporre la sua visione dei Mari del Sud come interpretazione, come nuova figura del vero. Che cosa dice, in sostanza, Taipi? Dice che il presunto mondo incontaminato, descritto dai navigatori sei-settecenteschi, è menzognero. Un’altra è la verità: l’isola del resoconto romanzato di un breve soggiorno alle Marchesi è un paese guasto, dove la corruzione non è però soltanto della civiltà, ma è della natura umana. Insomma, cancellate le illusioni degli esploratori alla John Smith, l’elisabettiano che vedeva attuabile, in terra americana, un Nuovo Eden, una felice corrispondenza tra macrocosmo e microcosmo grazie all’opera (e alla preghiera) di un altro Popolo Eletto; deluse le illusioni di un Cook circa la beatitudine degli “indigeni”, Melville – e con lui la scrittura del Romanticismo non soltanto americano – torna a una visione “manieristica” riletta in chiave industriale: l’Inferno è la struttura portante del Cosmo. E del resto, la concezione dell’umanità come insieme di “vermi”, sia pure contenenti una farfalla immortale, vermi destinati al disfacimento, disfatti già in vita, degradati e irredimibili vermi, destinati alla colliquazione e al ciclo impietoso della rinascita puramente materiale in altre, insondabili forme, non ha mai cessato – né può – di aver corso nelle culture del sacro teologizzato o controteologico, dell’orrore per la carne, forse soprattutto in ambito cristiano. Né poteva bastare a esorcizzarla, nell’Ottocento, la visione di un ordine nuovo, inteso ad alterare profondamente il rapporto del sacro con il profano. Le speranze riposte nella scienza, per il baleniere-navigatore erano contraddette dall’evidenza del massacro (e si leggano, in Moby Dick, le pagine sullo squartamento dei cetacei catturati), come oggi lo sono dall’evidenza che il massacro tecnologico aleggia sui nostri capi. È possibile cancellare la religione della morte?
Ecco quindi che l’avventura acquista quasi inevitabilmente l’amarissimo sapore della discesa degli inferi. Vero, gli indigeni dei Mari del Sud sono vessati da amministratori indegni, per lo più corrotti, e da missionari che nulla sanno della loro cultura e tuttavia sono ben decisi a importare e imporre in essa e a essa concezioni, come quella di peccato, del tutto estranee a un mondo che conosce il tabù ma non la proibizione, che non ha certo una visione “ciceroniana” delle cose, che non è stato mai prima alle prese con codici e pandette. Ma ciò non toglie che quegli indigeni siano cannibali, e Melville non sa certo rendersi conto del significato segreto di tale pratica, impermeabile per una coscienza imbevuta di spiriti “umanitari”, che nulla sa del tabù e invece soffre per il peso da un lato, e l’insufficienza dall’altro, delle proibizioni; e agli occhi di Melville, che dopotutto applica anch’egli metri di misura occidentali, bianchi, quegli indigeni sono (inutilmente, gratuitamente) crudeli, sono dediti al saccheggio e alla guerra; per lui, che se ne viene armato di un cristianesimo che gli sta nelle ossa sotto forma di principi (cioè di precetti, cioè di leggi) come quello dell’amore universale, sono a conti fatti detestabili perché tengono prigionieri il protagonista e il suo compagno di fuga per ragioni ignote ai due, ma che probabilmente, anzi senz’ombra di dubbio, attengono a oscure superstizioni. No, la luce della ragione non ha investito ancora quei selvaggi. E del resto, la luce della ragione non investe mai l’uomo; e i principi cristiani sono flatus vocis. Sì, la selva è un universo di buio e tenebrore; e d’altro canto, a che varrebbe portarvi la luce (cosa del resto impossibile, mera “dichiarazione di principi”), quando questa non preserva dalla ripetizione, non inaugura nulla di nuovo, non può redimere l’irredimibile, non salva dal rischio dell’inconscio e dal prevalere, ancora e sempre, del rigor mortis?
La morale civile, id est la missione colonizzatrice, si propone di ordinare il mondo confuso, l’irto caos della selvaggeria. Ma, per farlo, deve reprimere, deve opporre alla violenza primigenia una violenza programmata, quella del potere “legale” che proclama “mia è la vendetta”. Perché il principio della cultura occidentale, comunque laica, consiste nel grammaticalizzare il mondo, nel ridurre ogni cosa al senso comune, se si vuole alla professionalità, ovvero alla produttività (che è quanto dire: tempo ridotto a moneta, tempo commerciabile, tempo sfruttabile); e vuole imporre questo passaggio dalla ciclità alla linearità a un mondo che non ha percorso il suo processo, che è fuori dalla sua storia che è poi tutta la storia: un mondo che in precedenza ignorava queste parole, cui non si era affacciata l’idea di industria, né tanto meno quella di economia.
Ma come attuare il cielo in terra, come mondanizzarlo? E, soprattutto, come fare per convincere un’etnia che non distingue sacro da profano a far propria la scissione? Come persuaderla o obbligarla a saltare quella che in Occidente vien detta fase di sviluppo storico? Si tratta, è chiaro, di realizzare il fatto mettendo in azione l’idea, uscendo cioè dal crepuscolo de...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Introduzione
- Nota biobibliografica
- CAPITOLO I
- CAPITOLO II
- CAPITOLO III
- CAPITOLO IV
- CAPITOLO V
- CAPITOLO VI
- CAPITOLO VII
- CAPITOLO VIII
- CAPITOLO IX
- CAPITOLO X
- CAPITOLO XI
- CAPITOLO XII
- CAPITOLO XIII
- CAPITOLO XIV
- CAPITOLO XV
- CAPITOLO XVI
- CAPITOLO XVII
- CAPITOLO XVIII
- CAPITOLO XIX
- CAPITOLO XX
- CAPITOLO XXI
- CAPITOLO XXII
- CAPITOLO XXIII
- CAPITOLO XXIV
- CAPITOLO XXV
- CAPITOLO XXVI
- CAPITOLO XXVII
- CAPITOLO XXVIII
- CAPITOLO XXIX
- CAPITOLO XXX
- CAPITOLO XXXI
- CAPITOLO XXXII
- CAPITOLO XXXIII
- CAPITOLO XXXIV
- LA STORIA DI TOBY
- Copyright