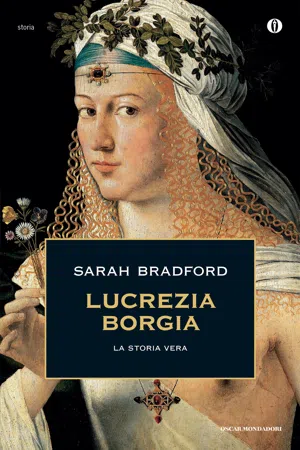Un elenco conservato nell’archivio di Modena specifica i nomi di quanti accompagnarono Lucrezia nel lungo e faticoso viaggio verso nord. Cavalcava il suo mulo oppure un ginnetto bianco, e quando era stanca viaggiava in una bella portantina fornitale dal padre. Era accompagnata da vecchi amici e parenti, Geronima Borgia, Adriana Mila e le sue dame, ciascuna con la propria cameriera personale. Le guidava la bella Angela Borgia, nota come Doña Angela; c’erano Elisabetha senese e sua figlia, Elisabetha perusina (perugina), Catherina spagnola, Alexandra, Geronima (che in seguitò sposò il medico favorito di Lucrezia, Lodovico Bonaccioli), Nicola (che si sposò con un membro della famiglia aristocratica ferrarese dei Trotti), Camilla, Catherinella negra (una schiava nera prediletta), quattro cameriere, la napoletana con due figlie, Samaritana e Camilla greca e due ancille, e una certa «Madonna Joanna» (forse Juana de Mocada, sposata a un nipote di Alessandro) con quattro domestici personali. Una donna di nome Drusilla, che si ritiene fosse amante di Cesare, non è citata nell’elenco dell’archivio, e neanche in quello fornito dal cronista ferrarese Zambotti. L’unica prova della presenza di Drusilla è un epigramma del poeta Fausto Evangelista Maddaleni intitolato «Sulla tristezza di Cesare per la partenza di Lucrezia Borgia e di Drusilla».1 Il biografo di Cesare, Gustavo Sacerdoti, ipotizza che questa Drusilla potesse essere la madre dei suoi due figli illegittimi, Girolamo e Camilla, i quali seguirono Lucrezia a Ferrara.
Ippolito era tornato a Roma, invece il cardinale di Cosenza aveva ordine di accompagnare Lucrezia addirittura sino a Gubbio. Tre vescovi viaggiavano con il suo seguito, uno dei quali, il vescovo di Venosa, era il medico favorito di Alessandro. Sempre del gruppo faceva parte il maggiordomo di Lucrezia (che recava la spada e il berretto inviati ad Alfonso dal papa); «Messer Christoforo» Piccimini, suo segretario; il «bacilliere», titolo oscuro che indica un laureato probabilmente incaricato di leggere per lei durante il viaggio o forse anche di comporre graziosi discorsi; il suo maestro di cerimonie; due cappellani (che forse erano anche cantori di cappella); il suo mastro delle stalle; «Vincentio guardaroba» (probabilmente lo stesso Vincenzo Giordano delle sue lettere da Nepi); Sancio, il suo scalco (amministratore); il suo mastro di cavallo; e Baldassarre, il suo coppiere. Sempre del gruppo faceva parte l’uomo incaricato dei coltelli; il «credenciero», responsabile del suo piatto; il portatore del sottocoppa; il portinaio; «Martin che legge il libro»; dieci paggi; dieci stallieri; l’uomo incaricato della sua cappella; il fabbricante di candele; lo «spenditore», che sovrintendeva alle spese della cucina; il sarto; il credenziere («repostero»); il cantiniere; due cuochi; Alonso, l’orefice; ragazzi di stalla; cocchieri; il fabbro; il sellaio, «mastro Alvisi da Cremona»; e Navarrico, lo scagnozzo spagnolo dei Borgia che nel 1494 fungeva da messaggero fidato nella corrispondenza con il Vaticano il quale rimase con Lucrezia a Ferrara. Solo per questo seguito, viaggiava con centocinquanta carri e muli, e cinquanta mulattieri.
La accompagnavano anche otto scudieri al servizio del papa, quasi tutti spagnoli, e un gruppo di baroni romani (non ancora spodestati da Alessandro) tra cui Francesco Colonna di Palestrina e sua moglie, Giuliano Orsini di Stabia, Guillen Ramón, nipote del papa e capitano della guardia papalina, e Ranuccio degli Ottoni cui di lì a poco Alessandro avrebbe sottratto una proprietà a Macerata in favore del piccolo Giovanni Borgia. Inoltre c’erano quattro ambasciatori romani; otto nobili romani; oltre trenta gentiluomini di Cesare, tra cui l’ardimentoso Yves d’Alègre, Ugo de Moncada, braccio destro di Cesare, Juan Castellar, Remolins, Juan Marrades e molti eccellenti aristocratici italiani come il genovese Ottaviano Fregoso (presente tra i personaggi del Cortegiano di Castiglione) accompagnati da trenta trombettieri, sei buffoni e «Nicolò il musico». Sanudo valutava che il corteggio Borgia fosse costituito da 753 persone, 426 cavalli e 234 muli.
Il gruppo ferrarese, forte di cinquecento persone e guidato da Ferrante e Sigismondo d’Este comprendeva molti intimi degli Este, come Annibale Bentivoglio che era sposato con Lucrezia, la figlia illegittima del duca Ercole; Ercole d’Este, figlio di Sigismondo, fratello del duca; Niccolò da Correggio, la cui madre era un’Este (come la madre di Lodovico Pico della Mirandola); Uguccione dei Contrari, l’eminente aristocratico ferrarese sposato a Diana d’Este, figlia del Sigismondo più anziano; e molti nobili con cui Lucrezia in seguito strinse amicizia e che entrarono a far parte della sua nuova vita, signori ferraresi e locali, legati agli Este non solo da rapporti di parentela ma dalla regalia di terre e palazzi in città, cariche e servizi militari. Al gruppo appartenevano inoltre i due inviati ferraresi Gian Luca Pozzi e Gherardo Saraceni.
Ippolito d’Este, che Cesare e Lucrezia avevano conosciuto quando era un giovane cardinale, era rimasto a Roma. Figlio terzogenito di Ercole e sua moglie, la duchessa Eleonora d’Aragona, maggiore di appena un anno di Lucrezia, era il più intelligente dei fratelli d’Este, e il più spietato. Come Cesare, era stato destinato già in tenera età alla Chiesa: a soli tre anni gli fu attribuita in commendam l’abbazia di Casalnovo, un esordio precoce anche per quell’epoca. A sette anni, grazie a sua zia Beatrice d’Aragona, regina di Ungheria, gli fu conferito il ricco arcivescovato di Esztergom in Ungheria, con una rendita annuale di 50 mila ducati. Nel 1493 Alessandro lo nominò cardinale in absentia in Ungheria, in seguito trascorse qualche tempo con Ludovico Sforza a Milano, dove ottenne l’arcivescovato, del valore di 5 mila ducati l’anno. Svolgeva anche funzione di governatore della città in assenza di Ludovico, ma trascorreva la maggior parte del tempo a cacciare e festeggiare fuori città. Come Cesare era palesemente inadatto per la vita ecclesiastica, e al pari suo preferiva l’esercizio delle armi e l’intrigo politico ai doveri sacerdotali. Suo padre Ercole aveva spesso occasione di rimproverarlo perché indossava l’armatura anziché gli abiti sacerdotali, e in generale per la sua condotta sconveniente. Nel 1493 aveva ordinato al prelato quindicenne di comportarsi in modo tale da essere considerato un cardinale saggio e prudente, e di dare prova di virtù e di costanza, qualità richieste a un religioso del suo rango.2 La notizia che Ippolito aveva ordinato un’armatura completa bianca da un artigiano milanese per combattere in favore di Ludovico nel 1499 aveva fatto inorridire suo padre, che gli ordinò di desistere da quelle propensioni guerresche e di sforzarsi di vivere come un buon arcivescovo e un reverendo cardinale.3 Orgoglioso, insolente e voluttuoso, ma dotato di grande fascino personale e della passione di famiglia per la musica, a Ferrara Ippolito si sarebbe dimostrato un buon amico e consigliere per Lucrezia.
Ferrante d’Este, il secondogenito di Ercole ed Eleonora, era nato a Napoli nel 1477, e aveva avuto per padrino Giuliano della Rovere. Nel 1493 era stato inviato dal padre a prendere servizio con Carlo VIII di Francia alla corte francese, e vi fu mandato con un sontuoso equipaggiamento, quattro nobili compagni e ottanta cavalli. Ercole, desideroso che il figlio facesse buona impressione, gli disse di regalare profumi e «cose odorifere» al re e alla regina e a importanti personaggi della corte e inviò da lui un cortigiano recante grani di muschio e due becchi di civetta; ma Ferrante, fatuo, pigro e dissoluto, deluse ben presto il padre dimostrandosi non abbastanza diligente nel servire il re francese, e preferendo piuttosto la ricerca di svaghi e divertimenti. Il padre, ansioso, gli scrisse dichiarandosi certo del suo grande talento, del suo senso del dovere e delle sue possibilità di successo.4 Ma Ercole viziava suo figlio. Gli aveva inviato più volte del denaro, ricevendone in cambio rapporti sulla corte francese. Quando tuttavia nel corso dell’anno Carlo VIII invase l’Italia, invece di seguire entusiasticamente l’esercito francese a Napoli Ferrante preferì rimanere a Roma a spassarsela. Adduceva la scusa di non potersi permettere di andare, perché Carlo non gli aveva pagato l’appannaggio. Ercole, furioso, inviò un suo segretario a Napoli a parlare con il re e gli fornì una lettera di credito per 500 ducati. Mandò anche una lettera severa al figlio, per rimproverarlo della sua condotta negligente e svogliata. Ercole gli ricordava che se fosse partito al seguito del re, com’era suo dovere, avrebbe ricevuto il suo appannaggio in tempi più brevi. Invece aveva preferito prendersi una vacanza a Roma dissipando il proprio denaro. Se avesse perso il favore del re a causa della sua mancanza di solerzia se ne sarebbe pentito, e inoltre avrebbe potuto aspettarsi dal padre soltanto una cattiva accoglienza e un trattamento rude.5
A seguito di questa intimazione, Ferrante seguì l’esercito francese a Napoli e si diede da fare per entrare nelle grazie del re, ottenendo un buon rapporto dal segretario ducale. Ercole gli scrisse elogiandolo per la sua nuova diligente condotta, esortandolo a continuare a dimostrarsi assiduo, pronto e disponibile nel servire il re. Mentre Alfonso d’Este rimaneva con Ludovico Sforza, che era entrato nella Lega contro i francesi, Ferrante fu costretto a seguire Carlo in modo che Ercole potesse barcamenarsi tra i due schieramenti. Combatté a fianco del re nella battaglia di Fornovo e tornò in Italia solo due anni dopo, nel 1497. Ottenne allora una condotta da Venezia per la guerra contro Pisa, ma come sempre si dichiarò insoddisfatto del trattamento lamentandosi per la mancanza di denaro; minacciò di abbandonare il servizio per Venezia ottenendo per tutta risposta un’altra lettera adirata del padre. Nonostante ogni evidenza, Ercole continuava a credere nel fascino di Ferrante e nel suo promettente futuro alla corte francese: nel 1499 lo portò a Milano con sé e Alfonso a conoscere Luigi XII. Ferrante deluse in modo marchiano le aspettative paterne: alla corte di Francia aveva accumulato una tale montagna di debiti che il povero Bartolommeo de’ Cavalleri, ambasciatore di Ercole per le trattative matrimoniali con i Borgia, non riuscì a ottenere credito e fu costretto a chiedere fondi al duca. Quanto a Luigi XII, si fece un’opinione poco lusinghiera di Ferrante, che definì perspicace ma pigro e irresponsabile. (Sigismondo d’Este, il figlio minore di Ercole, nato nel settembre 1480, il meno problematico e ambizioso di tutti, svolse un ruolo affatto secondario nella vita ferrarese. Come Alfonso e Ferrante aveva contratto la sifilide nel 1496-1497, ma mentre gli altri fratelli a quanto pare si erano ripresi lui ne rimase incapacitato al punto che a poco a poco non poté più condurre una vita normale.)
Tornando al grande corteo nuziale, il viaggio procedeva con estrema lentezza, poiché il ritmo era stabilito da Lucrezia che trovava oltremodo spossanti il terribile clima invernale e le cattive condizioni delle strade. Gli inviati ferraresi Pozzi e Saraceni, incaricati da Ercole di condurre la sposa a Ferrara entro la data prevista, erano disperati. Una settimana dopo essere partiti da Roma, riferivano a Ercole da Foligno:
Benché da Narni scrivessimo alla Eccellenza Vostra che veniressimo da Terni a Spoleti e da Spoleti qui a giornate continuate: nondimeno ritrovandosse la Illustre Duchessa e le sue done multo affaticate a Spoleti, deliberò riposarse un giorno integro a Spoleti e un altro qui, in modo che non partemo da qui se non domane; et non arrivaremo ad Urbino prima che marti dì proximo, che serà a li 18 del presente, perché doman andaremo a Nocera, sabato a Gualdo, dominica ad l’Ugubio, luni a Caglio, marti ad Urbino, dove dimoraremo anchora uno giorno integro, cioè tuto’l mercoledì; e de lie se andarà a Pesaro a li 20, poi de citade in citade secundo che per le altre è stato scripto alla Eccellenza vostra. Ma siamo certi che la predicta duchessa se riposarà multi dì integri in multe de dicte citade, talmente che senza dubio non arrivaremo prima a Ferrara che a l’ultimo del presente mese o primo del futuro; et forsi al secundo o terzo.
Avvertirono Ercole che forse avrebbe dovuto rimandare di un giorno o due il grande ricevimento a Ferrara, e gli chiesero di informarli riguardo al da farsi. «La causa che mi muove a credere quanto di sopra è perché la Illustre madonna Lucrezia è de complexione delicata e non assueta al cavalcare; e mancho sono le done sue; et cognoscemo che la non voria essere sbattuta né conquasata dal viagio quando la giungerà a Ferrara.»6
Ovunque andasse, Lucrezia veniva ricevuta con enormi acclamazioni e manifestazioni di giubilo. Alle porte di Foligno, la cittadina in cui era stata per breve tempo governatrice in absentia, c’era un trofeo che raffigurava la romana Lucrezia con lo stiletto in mano e versi che dichiaravano come ella avesse aperto la strada alla più giovane fanciulla, di gran lunga superiore a lei per castità, modestia, prudenza e costanza. Accanto alla piazza c’era un carro trionfale preceduto da un cupido e con sopra Paride con in mano la mela d’oro per le Esperidi: dichiarò di aver dato la mela a Venere, ma poiché Lucrezia era così superiore in bellezza, saggezza e ricchezza alle tre dee, l’aveva ritirata in suo favore. Per finire, al centro della piazza le era andata incontro una galea armata con turchi nei loro abiti tipici; in piedi sulla prua della galea uno di essi declamò dei versi, dicendo che il loro grande re sapeva quanto fosse potente Lucrezia in Italia e come potesse essere una buona mediatrice di pace, e quindi le offriva il territorio cristiano che possedeva. «Non siamo curati de havere le parole de dicti versi perché non sono de quelli del Petrarcha» commentò un inviato «ne anche la representatione de questa nave ni pare essere de grande importantia ni multo al proposito.» Entrambi gli inviati rimasero invece colpiti dalla comparsa, sei chilometri fuori Foligno, di tutto il clan dei Baglioni di Perugia convenuto per rendere onore a Lucrezia, senza dubbio, anche se non se ne fece parola, più per timore di Cesare che per rispetto di lei.
Lucrezia, riferivano gli inviati, continuava a preferire la via d’acqua da Bologna a Ferrara per evitare i disagi che incontravano cavalcando lungo le strade. Il papa era così preoccupato per la sua salute «che ogni dì e ogni hora vole intendere de li progressi soi; e è necessario che lei di sua mano da ogni terra scriva a Sua Santità del suo ben stare, che confirma quanto è stato scripto a vostra eccellenza altre volte, che Sua Santità la ami più che alcuna altra persona del sangue suo».7
Il 18 giunsero a Urbino, dopo essere state accolti a tre chilometri da Gubbio da Elisabetta, duchessa di Urbino, che Lucrezia aveva conosciuto ai tempi del suo matrimonio con Giovanni Sforza, e presero alloggio al palazzo arrivandovi a lume di torcia. Le insegne del papa, del re di Francia, dei Borgia e degli Este unite, e lo stemma di Lucrezia erano esposti ovunque. A Urbino Lucrezia e il gruppo degli estensi furono alloggiati nello splendido palazzo Ducale dei Montefeltro, mentre il duca Guidobaldo e la sua duchessa si fermarono fuori città.
Elisabetta Gonzaga da Montefeltro, duchessa di Urbino (1471-1520), era una delle donne più celebri del suo tempo. Era sorella di Francesco Gonzaga e cognata di Isabella d’Este, per cui nutriva grande amicizia, ed era molto stimata per la santità dimostrata nel sopportare un matrimonio in bianco con Guidobaldo il quale, oltre a essere sessualmente impotente, per buona parte della vita fu inabilitato da quella che veniva descritta come «gotta» ma era probabilmente artrite reumatoide, a causa della quale sin da giovane aveva il corpo deforme. Secondo l’archivista Luzio, nonostante l’impotenza (che fu tenuta segreta fino al 1502) Guidobaldo aveva forti pulsioni erotiche, e costringeva quindi Elisabetta in un continuo stato di tensione. Elisabetta è la protagonista del Cortegiano, che descrive un raffinato simposio alla sua corte, presumibilmente durato quattro giorni nell’anno 1507. Aveva a fianco come sempre la sua fedele compagna, la spiritosa e allegra Emilia Pia, figlia di Marco Pio da Carpi, sposata a un fratello illegittimo di Guidobaldo.
Elisabetta Gonzaga non aveva molte ragioni per amare i Borgia, sia per il modo in cui Alessandro aveva trattato Guidobaldo, suo capitano nella guerra contro gli Orsini, quando aveva rifiutato di riscattarlo e lo aveva lasciato a languire in cattività, sia, ancor più di recente, per l’oltraggioso comportamento di Cesare che appena un anno prima aveva rapito una delle sue protette, Dorotea Malatesta, moglie di Giovanni Battista Caracciolo, un capitano di fanteria napoletano al servizio di Venezia. L’incidente aveva provocato grande scalpore. Dorotea, che aveva ventitré anni ed era figlia naturale di Roberto Malatesta da Rimini, era stata allevata a Urbino alla corte di Elisabetta, dove avevano celebrato il suo matrimonio per procura. Era in viaggio per raggiungere il marito sotto la protezione dei veneziani e con una scorta armata fornita da Cesare su richiesta di Venezia, ma fu assalita proprio quando il suo corteggio entrò in territorio veneziano. Tutti accusarono Cesare che, arrogante e falso come sempre, scaricò la responsabilità su un suo capitano, Diego Ramires, il quale a suo dire aveva avuto una relazione con Dorotea durante il carnevale a Urbino. Fu tempestato di lettere di protesta provenienti da Venezia, dal papa, dal re di Francia, e persino da Francesco Gonzaga a nome della sorella. Ma Cesare non punì Ramires né restituì Dorotea, ed esistono notizie attestanti che tenne la giovane con sé. Alla fine del dicembre 1502 Sanudo riferiva che quando il duca Valentino aveva lasciato Imola aveva con sé la moglie del capitano di fanteria. Le scappatelle di Cesare non facilitavano certo i rapporti di Lucrezia con la duchessa di Urbino....