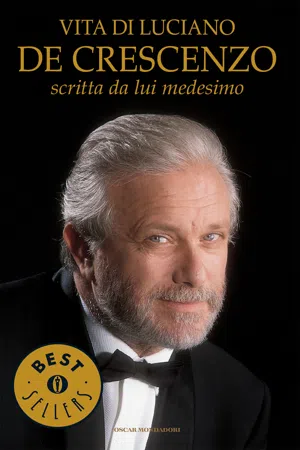Di primi amori ne ho avuti quattro, uno per ogni età: ho avuto il primo amore da bambino, poi quello da adolescente, poi da giovanotto e infine da adulto. Quanto a quello da vecchio, spero che non si faccia attendere troppo.
Se penso di aver avuto quattro primi amori, e non quattro amori diversi (numerabili dall’uno al quattro), è perché credo di essermi innamorato sempre della stessa persona, di una ragazza cioè un po’ bizzarra, che ogni volta ha voluto indossare un nome e un aspetto diversi, come la dea Tetide quando non voleva farsi possedere da Peleo. E così una volta mi si è presentata davanti con i capelli rossi, un’altra con gli occhi verdi, e poi ancora con i capelli neri e infine, l’ultima volta, con le labbra rosa come i coralli dei cammei di Torre del Greco. Io invece (e di questo sono sicuro) non sono mai stato lo stesso uomo: il Luciano che a nove anni s’innamorò perdutamente di Lilly non aveva nulla in comune, nome e cognome a parte, con tutti i Luciani che vennero dopo e che si innamorarono rispettivamente a 19, 29 e 51 anni. Questa pertanto non è la storia di un uomo e di quattro donne, ma di una donna e di quattro uomini, tutti innamorati di lei.
Un giorno John Keats, un poeta inglese dell’Ottocento, morto a soli 25 anni, scoprì su un’urna greca una rappresentazione dell’Amore Eterno. Si trattava di due giovani, un ragazzo e una ragazza, che si rincorrevano da posizioni diametralmente opposte. Data la rotondità dell’urna e la simmetria del disegno, non si poteva stabilire chi dei due stesse inseguendo l’altro. Era chiaro però che tutti e due sentivano il bisogno contemporaneo sia della fuga che dell’inseguimento. «Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter»1 sospira il poeta e poi conclude: «Bold Lover, never, never canst thou kiss… for ever wilt thou love, and she be fair».2
A questo punto, per capire chi è colei che sta fuggendo da me (o che mi sta rincorrendo), per sapere come è fatta quella che Keats chiama «la sposa inviolata del silenzio», proverò a raccontare quel che finora mi è successo con lei.
Lilly
Ho già detto che m’innamorai per la prima volta a nove anni: lei ne aveva uno meno di me. Abitavamo nello stesso palazzo, quello di via Marino Turchi 31 a Santa Lucia, io al terzo e lei al quinto piano. L’incontro avvenne sul terrazzo comune. Lilly aveva i capelli rossi, le lentiggini e le treccine (aveva anche una mamma egiziana, ma questo lo venni a sapere solo in un secondo momento). Per un po’ non accadde nulla: io fermo in un angolo a guardare, e lei a girare intorno sui pattini come se non ci fossi. Poi tutto a un tratto si accorse di me e, ogni volta che mi passava accanto, smetteva di spingere sui pattini e procedeva per una decina di metri, immobile, come una figura egizia, allineando il viso alle spalle e mettendo i piedi uno sul prolungamento dell’altro. Guardarmi non mi guardava, ma a ogni passaggio progressivamente mi si avvicinava, e più mi sfiorava, più sentivo il mio cuore sussultare come un assolo di batteria; più giri inanellava, più il mio amore per lei diventava eterno.
In pochi giorni diventammo inseparabili e io cominciai a comportarmi come se fossi il fidanzato ufficiale. Le stavo sempre vicino ed ero geloso se qualche altro ragazzino le rivolgeva la parola. Non so bene spiegare i motivi della mia infatuazione, ma Lilly era troppo diversa da qualsiasi altra bambina avessi conosciuto prima di allora per non restarne affascinato. Probabilmente alla base di questa diversità c’era l’influenza della madre, che era sì egiziana, ma di origine inglese. Anche le abitudini della sua famiglia per me erano sconvolgenti: tanto per dirne una, a casa sua, lei e il fratello potevano parlare quando e come volevano, cosa che invece a me e a mia sorella veniva negata del tutto, a meno che non avessimo avuto la febbre con temperatura superiore ai 38 gradi.
Un giorno Lilly mi disse: «Domani festeggio il mio compleanno, vieni su alle quattro in punto».
«Il tuo compleanno!» risposi io stupitissimo. «E fate una festa?»
«Sì. Perché, tu non la fai la festa quando viene il tuo compleanno?»
«Mai: i miei, in un anno, mi fanno solo due regali, uno all’onomastico e uno alla Befana.»
«E a Natale?»
«Mi dicono Buon Natale.»
«D’accordo, ma sotto l’albero che cosa ti fanno trovare?»
«Niente: e poi noi non facciamo l’albero, facciamo il presepe!»
«E non ti fanno un regalino?»
«No, però mangiamo di più e mi danno il permesso di vedere i fuochi.»
La festa di Lilly fu eccezionale: tutti i ragazzini erano seduti a tavola e venivano serviti come persone grandi. Per la prima volta in vita mia bevvi la cioccolata (fino a quel giorno avevo ignorato che la cioccolata si potesse anche bere). I posti erano tutti assegnati: ognuno di noi aveva un cartoncino col proprio nome e accanto al cartoncino un pacchetto colorato con un regalo personale. Alla fine del ricevimento spensero le luci e arrivò la torta con le candeline accese. Rimasi senza fiato: il fuoco a tavola! Oggi non credo che esista un solo bambino che si possa meravigliare per una torta con le candeline, ma a quei tempi era diverso. Solo dopo la guerra alcune tradizioni anglosassoni, come l’albero di Natale e la canzone Jingle Bells, sarebbero diventate comuni.
Il nostro, ovviamente, fu un fidanzamento senza sesso, anche se un giorno, come si dice in gergo, «ci provai».
«Leviamoci i calzoncini e le mutandine,» le dissi «e così ci guardiamo!»
«Levateli prima tu» rispose lei.
Io subito, senza starci troppo a pensare, me li tolsi, ma lei serissima, dopo avermi osservato con calma, non volle fare altrettanto. Da quella volta imparai a spogliarmi solo per secondo.
Improvvisamente però Lilly divenne misteriosa: la sua famiglia cominciò a trasferirsi da una pensione all’altra e si cambiò di cognome. All’inizio, io non capii il perché di tutti questi sotterfugi, poi qualcuno mi spiegò che erano ebrei e che sarebbe stato pericoloso per loro avere un recapito conosciuto. Lilly partì per l’America, all’improvviso, senza neanche venirmi a salutare. Piansi a dirotto: Hitler e Mussolini avevano distrutto il mio primo sogno d’amore.
Giselle
Napoli, Vomero, Liceo Jacopo Sannazaro, ottobre 1947: io stavo in terza liceo e lei in prima. Aveva sedici anni. La vedevo arrivare ogni giorno con i libri stretti da una cinghia marrone, sempre ben vestita e perfino truccata. Il martedì invece la incontravo in palestra alle dieci e trenta precise: lei usciva e io entravo. Il primo problema fu quello di non arrossire: anche se la scorgevo a cento metri di distanza, mi si scatenava dentro una tempesta di fuoco, e più cercavo di sembrare indifferente, più mi sentivo avvampare come un tizzone. Poi pian pianino, non so nemmeno io come, mi ci abituai. Non erano tanto gli occhi verdi a sconvolgermi, quanto le punte del seno che riuscivo a indovinare, nude secondo me, al di sotto della tuta.
Un giorno che mi sentivo più forte del solito mi feci coraggio e l’abbordai.
«Come ti chiami?»
«Giselle e abito in via dei Mille.» Poi, subito dopo aggiunse: «Quelli del Vomero sono tutti cafoni!».
«Ma io non sono del Vomero.»
«E di dove sei?»
«Sono di via dei Mille.»
«Ah, meno male!» sospirò lei. «Avevo paura che fossi anche tu del Vomero. Così la mattina possiamo darci appuntamento a piazza Amedeo e prendere insieme la funicolare.»
Io non ero affatto di via dei Mille, ma dopo quello che lei aveva detto dei vomeresi, come facevo a confessarle che da più di un anno mi ero trasferito al Vomero? Sì, d’accordo, avrei potuto dirle che ero originario di Santa Lucia, ma poi, va’ a sapere cosa ne pensava di quelli di Santa Lucia. La verità è che il mio amore era un pochino razzista, tanto è vero che aveva anche l’erre moscia.
Il secondo problema fu trovare i soldi per la funicolare: in pratica due lire al giorno (una per salire e una per scendere) e in più qualche altro soldino per offrirle, che so, un gelato o dei cioccolatini. Ogni mattina mi alzavo un’ora prima per farmi trovare, fresco come una rosa, all’appuntamento di piazza Amedeo. La prima discesa me la facevo a piedi: venivo giù di corsa, come un proiettile, lungo la calata San Francesco: dieci minuti, massimo dodici, ed ero a via dei Mille. Il vero dramma era il ritorno, quando, dopo averla accompagnata fin sotto casa, dovevo risalire 1128 gradini per raggiungere il Vomero, ma ero giovane, in salute e per giunta innamorato.
Mettere insieme venti lire a settimana nel ’47 era un’impresa. I primi a finire sulla bancarella degli usati furono i testi del ginnasio, poi prese il volo un Giulio Verne avuto in regalo da zio Luigi, e infine i miei adoratissimi Salgari. Con il Ciclo dei corsari mi pagai due settimane di funicolare e con Minnehaha la Scotennatrice (rilegatura in rosso e titoli in oro) tre giorni. A dicembre cominciai a non farcela più: le dissi che potevo accompagnarla solo all’andata, perché all’una dovevo andare da un amico, al Vomero, a fare i compiti. Un brutto giorno, infine, mi resi conto che non avevo più nulla da vendere e mi arresi.
«Senti Gisella…» cominciai a dirle con voce affranta.
«Giselle, prego» mi corresse lei.
«Giselle, debbo darti una brutta notizia: mio padre ha deciso di trasferirsi al Vomero.»
«E con questo? Anche se ti trasferisci, resti sempre uno di via dei Mille.»
E così mi salvai.
Il primo bacio ce lo demmo nello stanzino degli attrezzi sportivi. Era un martedì e c’era ginnastica: io avevo anticipato la discesa in palestra e lei si era trattenuta un po’ più del necessario. La baciai con impeto tra giavellotti, clave e «cavalli» in similpelle, ma non ebbi il coraggio di toccarle il seno. Eppure Dio solo sa quanto mi sarebbe piaciuto!
Un giorno, durante la lezione di latino, il professor Valenza ci parlò dei ruderi di Baia e di un tempio dove, a suo dire, era ancora possibile sentire la voce del dio Mercurio sotto forma di eco. Essendo Baia a soli ventidue chilometri da Napoli, venne subito organizzata una gita scolastica per la domenica successiva, alla quale, con mia infinita gioia, avrebbe partecipato anche la prima E, la classe di Giselle.
Una volta nel tempio, nessuno fu capace di sentire Mercurio, anche perché tutti si misero a gridare contemporaneamente, e più di tutti il professore che avrebbe voluto il più totale silenzio per farci ascoltare l’eco: solo io e Giselle ubbidimmo ai suoi ordini, tutti gli altri urlavano come ossessi. La verità è che noi eravamo assenti: pigiati nella ressa, sballottolati da ogni parte, badavamo solo a tenerci per mano e ad ascoltare i nostri cuori. A me di sentire Mercurio non importava assolutamente nulla, l’unica cosa che andavo cercando con gli occhi era un angolo buio, una cameretta segreta, un anfratto qualsiasi dove poterle dare un bacio.
Nel primo pomeriggio ci trasferimmo a Bacoli a visitare le «Stanze di Agrippina» e, mentre tutti giocavano a nascondarella, io e Giselle ce la squagliammo e ci avviammo verso il mare. Il professor Valenza ci vide ma non fece nulla per fermarci. Che Dio gliene renda merito!
Ci sdraiammo, uno accanto all’altra, su una spiaggetta piena di sassi. Era inverno, la zona era deserta e ci potemmo scambiare con calma tutti quei baci e quelle carezze che avevo sognato negli ultimi due mesi. Io stavo con la schiena a terra e lei mi si coricò addosso per coprirmi di affetto (o forse per non sporcarsi). Sentii subito un acuto dolore dietro la schiena: era una piccola pietra che mi premeva giusto in mezzo alle scapole. Non dissi nulla per non rovinare il momento magico. ...