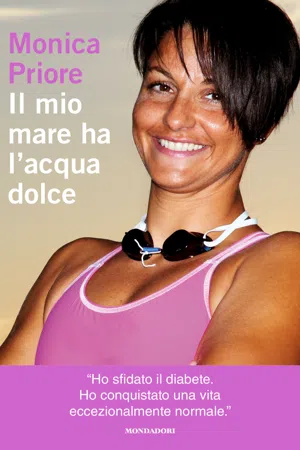![]()
Sono nata nel 1976, ma la mia storia inizia nel 1981. Dei miei primi anni ho ricordi sbiaditi e soleggiati, come credo ogni bambino felice. Avevo tutto ciò che si può desiderare a quell’età: una mamma, un papà, un fratello quasi coetaneo con cui giocare e, attorno, l’abbraccio forte e saldo di una grande famiglia. Mia madre aveva la bellezza di sei fratelli, tutti maschi e tutti innamorati di lei. Ciascuno ha almeno due figli: d’estate, quando ci ritrovavamo per le vacanze a Torre Lapillo, vicino a Porto Cesareo, sulla strada per la spiaggia ci scambiavano per una colonia, invece eravamo tutti cugini. La nonna Coca si prendeva cura di tutti, imbastendo tavolate della domenica oggi impensabili, perché siamo diventati decisamente troppi per una cuoca sola: allora invece fioccavano le orecchiette e i maccheroncini al ragù, le polpette e quintali di pane da intingere nel sugo, tutto rigorosamente fatto in casa, secondo la tradizione pugliese.
Ho imparato a nuotare grazie ai miei genitori. Il papà un giorno prese me ed Enzo e ci portò agli scogli, dove c’era l’acqua alta, inseguito dalla mamma che lo minacciava: «Umberto, se succede qualcosa ai bambini...».
E fu così che Umberto, convinto che l’uomo sia un animale acquatico, ci ha presi e buttati in mare: io avevo quattro anni, mio fratello tre e, senza grandi alternative, abbiamo imparato a stare a galla. Tempo qualche giorno, facevamo avanti e indietro tra mamma e papà, appostati uno vicino a uno scoglio e l’altra poco più in là.
Poi tutto è cambiato. Non ho perso niente, ma ho dovuto imparare a convivere con un ospite indesiderato: il diabete, precisamente il diabete mellito di tipo 1.
Dopo dieci giorni di vacanza fu chiaro che non stavo bene: dimagrivo a vista d’occhio, avevo sempre sete, di notte mi alzavo continuamente per fare pipì. Il pediatra ipotizzò che si trattasse di una cistite, però, per sicurezza, mi prescrisse alcune analisi. La mattina dopo andammo in ambulatorio, per il primo di una serie interminabile di prelievi. Il giorno dopo si scoprì che era tutto da rifare: la provetta si era rotta. Poche ore e venne fuori che avevo un valore glicemico di 340 mg/dl.
Qualche anno fa la mia prima nipotina, Sara, quando ho ripreso conoscenza dopo una crisi ipoglicemica mi ha chiesto: «Zia Mo, cosa ti è successo?».
Sono rimasta interdetta: come si spiega a un bambino di sei anni tutta una routine fatta di controlli glicemici, punture di insulina, rischi di ipoglicemie e iperglicemie? Sara però mi guardava con due occhioni sgranati per lo spavento, identici a quelli di mio fratello. Dovevo inventarmi qualcosa, così le ho detto: «Lo sai che per far camminare le macchine ci vuole la benzina, vero?».
«Sì.»
«Ecco, anche il corpo umano ha bisogno di benzina, e questa benzina sono gli zuccheri. La zia non aveva zuccheri a sufficienza e il suo corpo si è momentaneamente spento.»
Sara ha capito, e io ho trovato un modo semplice per chiarire a chi non lo sa in che cosa consiste la mia forma di diabete.
Funziona così: il mio organismo attacca e distrugge le cellule beta del pancreas, che producono insulina, l’ormone che regola il livello glicemico nel sangue e permette lo sfruttamento delle riserve di zucchero del corpo da parte delle cellule. Se l’insulina è in eccesso rispetto al quantitativo di zuccheri presenti nel sangue, gli zuccheri calano; se scendono sotto il livello di guardia si rischia una crisi ipoglicemica, annunciata da un gran circo di sintomi che bisogna imparare a riconoscere: sudorazione, tremore alle mani, annebbiamento della vista, spossatezza, giramenti di testa; nei casi gravi – quando anche l’attività cerebrale risente del calo – convulsioni, perdita del controllo delle braccia e delle gambe, incapacità di parlare, quindi di chiedere aiuto. Ma non è certo tutto qui! Il livello di zuccheri nel sangue può anche salire troppo, provocando una crisi di iperglicemia, che presenta a sua volta altri sintomi e altre complicanze.
Un diabetico deve essere attento a ogni sintomo, deve essere costante nei controlli (oggi ne faccio una dozzina al giorno) e nel mantenere uno stile di vita salutare, mangiando in maniera regolata e facendo attività sportiva. Lo stile di vita è la terapia: non si può derogare, se non rarissimamente e sotto controllo. Più di ogni altra cosa, però, un diabetico non può mai concedersi il lusso che desidera di più: dimenticarsi del diabete. Innanzitutto perché la sua malattia è semisconosciuta. Quasi nessuno ha familiarità con i microinfusori: ai campionati di nuoto una volta mi hanno chiesto se grazie a quell’apparecchio andassi più veloce. Quasi nessuno penserebbe che un bambino sul punto di svenire è diabetico, quasi nessuno saprebbe come intervenire se assistesse a una crisi ipoglicemica grave. Dei 3.800.000 diabetici che ci sono in Italia, solo il 5 per cento è del tipo 1. Gli altri sono del tipo 2, il cosiddetto “diabete alimentare”, quello noto, che si manifesta dopo i quarant’anni e si porta via la capacità dell’organismo di regolare la quantità di zuccheri nel sangue.
I miei genitori, come la stragrande maggioranza della popolazione, del diabete infantile non avevano mai sentito parlare. Pensavano che fosse una malattia che viene agli anziani in sovrappeso.
Io, a cinque anni, non avevo idea di cosa mi stesse succedendo.
In famiglia quell’esperienza è custodita come un segreto di cui siamo al corrente in pochi eletti: non se ne parla mai. Forse perché chi deve sapere c’era, forse perché rivangare quelle giornate fa riaffiorare il dolore. Le poche cose che ho sentito raccontare dai miei genitori sono aneddoti, uno su un medico arrogante e scorbutico, tanti su infermiere affettuose e premurose, un altro su una piccola colluttazione che papà ha avuto con due ragazzi incontrati sulla strada per tornare al mare. Credo che questi due sventurati abbiano pagato sia il loro bullismo sia la maleducazione del medico che citavo prima.
Ho poche e confuse immagini dei cinquanta chilometri fatti in auto in un silenzio surreale e in un’atmosfera cupa per andare dalla casa al mare sino all’ospedale. Ricordo invece l’ingresso al reparto di Diabetologia del “Di Summa”. Mi ha accolto sulla porta un uomo alto, con un camice bianco, il dottor Antonio Marinazzo, il primario. L’ho guardato un po’ intimorita, lui mi ha sorriso e accompagnata in quella che per alcuni giorni sarebbe stata la mia stanza. Un medico ha effettuato il controllo glicemico, un’infermiera mi ha somministrato l’insulina. Hanno mostrato a mia madre come farmi le iniezioni.
Non avevo mai visto la mia mamma avere paura, forse è per questo che stavo zitta e mi facevo sforacchiare in silenzio, ribellandomi solo quando la misura era colma da un pezzo. Una mattina una dottoressa non riusciva a trovare la vena, ha cominciato a spostare l’ago di qua e di là, senza ottenere risultati. Guardavo la mamma: era inerme quanto me. Non mi ribellavo perché sapevo che c’era un buon motivo: la mamma non avrebbe avuto paura, altrimenti; non avrebbe permesso che mi facessero tutto questo, altrimenti. Ho cominciato a piangere solo quando non ho più retto al dolore. Ha cominciato a piangere anche la mamma. La dottoressa ha desistito e ci ha lasciate sole, abbracciate e disorientate.
Ero l’unica bambina in un reparto di adulti. Ora so che è stata la mia fortuna: in Pediatria non sapevano come gestire il mio caso ed è grazie a questo che ho conosciuto il dottor Marinazzo, l’uomo che mi ha seguita con l’amore di un padre fino a quindici anni fa e che ha supportato me e tutta la mia famiglia nell’affrontare la situazione.
Allora, però, desideravo con tutta me stessa andare via di lì il prima possibile. Mi sentivo un’aliena: sola, diversa dagli altri bambini e diversa da tutti quegli adulti. Per anni ho pensato a me come all’unica bambina al mondo con il diabete e mi sono chiesta perché: perché solo io.
Quel primo ricovero è durato tre giorni, ma mi sono sembrati un’eternità, nonostante gli infermieri cercassero di aiutarmi a passare il tempo dandomi qualche incarico: mi facevano consegnare il cibo agli altri malati o preparare i batuffoli di ovatta che il giorno seguente sarebbero serviti per i prelievi. Quando parlo di quei momenti con mia madre, tuttora cerco di convincerla che sono rimasta in ospedale almeno una settimana, ma lei è inflessibile: «Monica, te lo giuro: sei stata in ospedale solo tre giorni».
La mamma è rimasta accanto a me notte e giorno: cercava in tutti i modi di tirarmi su il morale, mi leggeva le storie, mi parlava per ore. Papà andava e veniva non appena poteva lasciare l’ufficio: quando lo vedevo comparire sulla porta sapevo che avremmo giocato a carte, il patto era che dovessi vincere sempre io. Poi c’erano le visite, numerose, di amici e parenti, che entravano nella stanza con un sorriso tirato e chiedevano alla mamma: «Cosa dicono i medici?», come se potesse esserci qualche novità. Come se da un momento all’altro potessi alzarmi perfettamente guarita da quel letto troppo lungo per me e dimenticare tutto. Detestavo suscitare compassione, venire osservata come una condannata a morte, o come minimo a una mezza vita. Volevo andare via, volevo che tutto finisse, che tutto tornasse come prima.
Sono tornata in quel reparto decine di volte, semplicemente per un controllo in giornata, un prelievo, un’iniezione, o per un ricovero più lungo. Conservo, come se fosse ieri, le sensazioni. Tutto il resto è mescolato, una sorta di film proiettato a velocità doppia nel quale le giornate si confondono l’una con l’altra, gli anni si accavallano, i confini tra “dentro” e “fuori” dall’ospedale si fanno più labili di quanto siano realmente stati.
So che soffrivo, di solitudine più che altro, ma cercavo di nasconderlo. Non volevo causare altro dolore. Mi sentivo in colpa. I miei genitori cercavano di mostrarsi allegri ma io capivo che sotto sotto erano tristi. I ritmi di tutta la famiglia ruotavano attorno ai miei e mi sentivo di peso. Qualcosa era chiaramente cambiato, ed era cambiato per sempre.
È stato allora che il senso di inadeguatezza ha messo radici dentro di me. Perché avevo il diabete? Perché all’improvviso ero costretta a sottopormi alle visite mediche, ai prelievi, a tre iniezioni al giorno di una sostanza chiamata “insulina”?
Ho cominciato da subito a minimizzare, a cercare di negare la malattia fino all’esasperazione. Per anni sono arrivata letteralmente a crollare pur di fare finta di niente: se chiunque, mio fratello, mia mamma, ma anche qualche amico o parente, coglieva i primi sintomi di una crisi ipoglicemica e mi chiedeva: «Monica, come stai?», rispondevo sempre, di getto «bene, grazie». Sarebbe bastato chiedere un bicchiere di succo di frutta per evitarmi l’ennesima crisi. Ma non volevo dare fastidio, non volevo creare problemi. Volevo semplicemente essere come apparivo: indistinguibile da una copia di me senza il diabete.
![]()
A settembre sono tornata all’asilo. Enzo per solidarietà portava una merenda identica alla mia: pane e pomodoro. Certe mattine fortunate invece potevamo deliziarci con le frittelle della nonna Coca, un po’ dell’impasto del suo pane schiacciato e fritto.
La mamma e il papà avevano il terrore che io soffrissi nel confronto con gli altri bambini: nessuno dei miei compagni doveva fare una puntura prima di andare all’asilo, nessuno doveva evitare i dolci. Per fortuna di biscotti e merendine non sentivo tutta questa mancanza e nessuno sembrò far caso al fatto che qualcosa nella mia vita era cambiato. Né allora, né negli anni successivi: alle elementari ho avuto in dono una maestra, Rita, sensibile e delicata, abilissima nel cogliere i sintomi delle mie crisi e nel gestirli, in collaborazione con la mia compagna di banco, Roberta. Ricordo che la maestra Rita lo decise il primo giorno: la merenda doveva essere uguale per tutti, guarda caso pane e pomodoro, e le ore in palestra ridotte al minimo, perché temeva che mi stancassi troppo.
Parentesi
Oggi è dimostrato che l’esercizio fisico è una medicina importante, che aiuta a gestire un enorme numero di condizioni, tra le quali il diabete. Non presenta controindicazioni e ha “effetti collaterali” positivi, come il sentirsi soddisfatti di sé.
Purtroppo le ipoglicemie mi capitavano di frequente, così la mamma accompagnava me ed Enzo a scuola, faceva la spesa alla velocità della luce e si precipitava di corsa a casa, nel terrore di aver mancato la telefonata che la avvisava di un mio malessere. L’hanno chiamata spesso, anche se di solito bastava un bicchiere d’acqua con una bustina di zucchero a farmi riprendere. La vedevo arrivare con il respiro corto e il cuore in gola. Mi sentivo mancare per la crisi ma più di tutto soffrivo per la mia mamma, la mia ombra pallida ma sorridente, per la maestra, che aveva dovuto interrompere la lezione, per i miei compagni, che venivano condizionati dal mio diabete.
Desideravo che la malattia scomparisse, o almeno di poterla nascondere. Tutti i miei sforzi per fare finta di niente e negare i sintomi delle crisi erano vani. Peggio: erano controproducenti. Comportandomi così non facevo che peggiorare la situazione, finendo per svenire o aver bisogno di soccorsi più seri e impegnativi invece di risolvere tutto con un bicchiere di succo di frutta, come se si trattasse di un qualsiasi disturbo passeggero.
Banalmente, far finta di niente non era possibile. Facevo di tutto per non sentirmi diversa, ma ero diversa. Oggi, a trentotto anni, riconquistata la razionalità, vedo le cose nella loro reale dimensione: sono Monica, Monica ha il diabete, e allora? Io non sono certo il mio diabete!
Al tempo, vedevo solo i miei compagni di classe partire per le gite, mentre io rimanevo a casa: la maestra e i miei temevano che potessi sentirmi poco bene. In terza elementare la maestra Rita si inventò di chiedere alla mamma di accompagnarci: in questo modo avrei potuto partecipare anch’io. Sono andata alla gita, come gli altri, ma ero comunque diversa: ero l’unica con adulto al seguito, l’unica che non poteva godere nemmeno di quel piccolo scampolo di indipendenza.
Poi c’era il dolore. Detestavo il momento prima di pranzo, in cui la mamma doveva farmi il controllo glicemico e l’iniezione di insulina. Per il controllo allora si usavano le lancette, delle stanghette di metallo con una punta che faceva un male cane. Sono decisamente nata nell’epoca sbagliata per la diabetologia: oggi, con i pungidito e i nuovi glucometri, è tutto più facile e indolore. Allora, prima di ogni pasto e due ore dopo, mi toccava questa fortuna. A volte mi nascondevo in camera, altre scappavo intorno al tavolo urlando: «Fa male, non voglio farlo!». In una maniera o nell’altra la mamma riusciva a convincermi e a quel punto – siccome io non volevo saperne di imparare a controllarmi la glicemia da sola – ci schieravamo nella “posizione d’attacco”: io dietro, per non vedere l’ago che si avvicinava, la mamma davanti, con il braccio a bloccare il mio. Dopo di che, partiva la “mossa del cobra”: con uno scatto rapidissimo la mamma mi bucava il dito prescelto. Sistematicamente io, anche se non vedevo niente, percepivo l’arrivo della lancetta e mi ritraevo proprio mentre l’ago era vicino al dito: oltre al buco, finivo per graffiarmi.
Scappavo in camera mentre la mamma apriva il frigo, prendeva la fiala di insulina e, facendola rotolare avanti e indietro tra le mani, la scaldava prima di trasferirla nella siringa. La fede che portava al dito urtava contro il vetro della boccettina, producendo un ritmico e singolare “tac tac tac” che segnava l’inizio di tre o quattro minuti lunghissimi durante i quali Enzo non fiatava, papà teneva lo sguardo fisso sul telegiornale e la nonna si sedeva in un angolo a piangere per il dispiacere.
Il ticchettio della fede sulla boccetta di insulina si faceva sempre più acuto man mano che la mamma raggiungeva la sua camera, e si interrompeva quando l’insulina veniva posata sulla cassettiera. Siringhe, ovatta e disinfettante erano in una scatola circolare di metallo che un tempo credo avesse contenuto dei biscotti al burro.
Prima, dopo e durante la puntura urlavo: non per il dolore ma per l’odio che provavo nei confronti di questa malattia. Subito dopo sprofondavo nel senso di colpa: mia madre era mortificata a causa mia, la nonna era addolorata a causa mia, mio padre era annichilito a causa mia.
Mio padre si sentiva responsabile, impotente; continuava senza sosta a chiedersi: “Perché a lei?”. Se avevo una crisi non riusciva nemmeno ad avvicinarsi, figuriamoci intervenire. Un pomeriggio, avrò avuto diciassette anni, eravamo in casa io e lui. Dopo pranzo avevo l’abitudine di fare il riposino. Verso le quattro e mezzo, non vedendomi comparire, si è preoccupato: mi ha trovata in camera in un bagno di sudore. È corso a prendermi un bicchiere di aranciata ma io, già in uno stadio avanzato della crisi, mi sono rifiutata di berlo. In quelle condizioni chi ha il diabete perde l’uso della ragione: ho urlato a mio padre che non volevo niente, che stavo benissimo. Quando ha insistito l’ho cacciato, dicendogli che era colpa sua, se avevo il diabete. Non è vero, ovviamente. Lui sapeva che non era vero, sapeva che in quei momenti non ero io a parlare, ma non resse l’urto, uscì di casa e andò a recuperare la mamma in chiesa, avvisandola che stavo male. Solo alla sera, dopo aver fatto una passeggiata da solo, riuscì a tranquillizzarsi. Io non ricordavo niente dell’accaduto. Ricordo ancora, invece, la sofferenza per avergli urlato quelle cose, per averlo allontanato facendo leva sulla sua fragilità.
Parentesi
I gradi delle crisi ipoglicemiche sono tre: lieve (i sintomi sono solo di origine nervosa e il diabetico è in grado di gestire la situazione da solo, ingerendo cibi che contengono glucosio o carboidrati semplici); moderato (ai sintomi nervosi se ne aggiungono altri, come stato confusionale, irritabilità o difficoltà a coordinarsi, ma il diabetico rimane in grado di autogestirsi); grave (la coscienza è alterata e il diabetico ha bisogno di un aiuto esterno per superare la crisi).
Non è semplice stare vicino a una persona con il diabete di tipo 1, soprattutto se queste crisi – come nel mio caso – si presentano spesso.
Mia madre riusciva a passare sopra ...