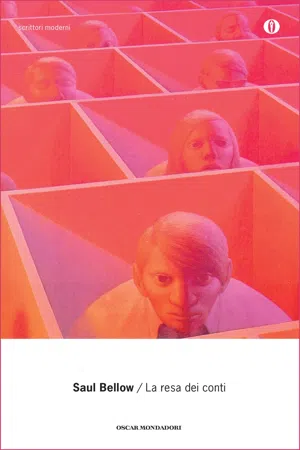Quando si trattava di nascondere le proprie preoccupazioni Tommy Wilhelm non era da meno di chiunque altro. Così, almeno, credeva lui, e c’era un certo numero di fatti a dargli ragione. Un tempo aveva fatto l’attore – no, non proprio l’attore, la comparsa – e sapeva che cosa volesse dire recitare. Inoltre fumava il sigaro, e quando un uomo fuma il sigaro e porta il cappello ha un vantaggio sugli altri: è più difficile capire di che umore sia. Scese dal ventitreesimo piano alla saletta del mezzanino per ritirare la posta prima di colazione, e credeva – sperava – di avere l’aria abbastanza a posto: di uno che se la passa bene. Doveva limitarsi a sperarlo, perché non poteva aggiungere molto allo sforzo che stava facendo. Al quattordicesimo piano si aspettava che suo padre entrasse nell’ascensore; spesso si incontravano a quell’ora, mentre andavano a fare colazione. Se si preoccupava del suo aspetto era soprattutto per amore del vecchio padre. Ma non ci fu fermata al quattordicesimo e l’ascensore continuò a scendere. Poi la porta dolcemente si aprì e il grande, irregolare tappeto rosso scuro che ricopriva il salone avanzò sinuoso verso i piedi di Wilhelm. Il salone era buio, sonnolento. Tende francesi che sembravano vele chiudevano fuori il sole, ma tre finestre alte e strette erano aperte e nell’aria azzurra Wilhelm vide un piccione in procinto di posarsi sulla grossa catena che sosteneva la pensilina del cinema proprio sotto al salone dell’albergo. Per un attimo udì le ali battere con forza.
Quasi tutti gli ospiti dell’Hotel Gloriana erano anziani. A Broadway, fra la Settantesima e la Novantanovesima Strada, vive gran parte della vasta popolazione dei vecchi di New York. A meno che il tempo sia troppo freddo o umido, essi occupano tutte le panchine sparse negli esigui giardini pubblici chiusi da cancellate e lungo le grate della sotterranea, dalla Verdi Square alla Columbia University, gremiscono i negozi e i caffè, i grandi magazzini, le sale da tè, le pasticcerie, i saloni di bellezza, le biblioteche e i club. Al Gloriana, tra questa gente vecchia, Wilhelm si sentiva fuori posto. Era relativamente giovane, sui quarantacinque, grosso e biondo, con spalle larghe; aveva una schiena forte e ampia, anche se già un po’ curva e ispessita. Dopo colazione i vecchi clienti si sedevano sulle poltrone e sui sofà di cuoio verde del salone e si mettevano a spettegolare e a guardare i giornali: non avevano altro da fare che ammazzare il tempo. Ma Wilhelm era abituato a una vita attiva e gli piaceva uscire al mattino a far qualcosa. E da diversi mesi, poiché non aveva un lavoro, si teneva alto il morale alzandosi presto; scendeva, già sbarbato, alle otto in punto. Comprava sigari e giornali e beveva una Coca-Cola o due prima di andare a colazione col padre. E dopo colazione, fuori, fuori, fuori per le sue occupazioni. Uscire era diventata di per sé la sua principale occupazione. Ma si era reso conto che non poteva continuare così ancora per molto, e quel giorno aveva paura. Sentiva che le sue abitudini stavano per cambiare e che un terribile guaio da lungo tempo presagito ma rimasto finora informe stava per arrivare. Prima di sera avrebbe saputo.
Tuttavia seguì la routine quotidiana, e attraversò il salone.
Rubin, l’uomo al banco dei giornali, aveva gli occhi deboli. Forse non erano proprio deboli, ma erano privi d’espressione, con palpebre striate che si ripiegavano agli angoli. Vestiva bene. Non sembrava necessario – stava quasi sempre dietro quel banco – ma vestiva molto bene. Indossava un elegante abito marrone; i polsini della camicia sfregavano contro i peli delle sue piccole mani. Portava una cravatta colorata marca “Contessa Mara”. Quando Wilhelm si avvicinò, Rubin non lo vi-de; stava guardando con espressione sognante l’Hotel Ansonia, visibile dal suo angolo, a diversi isolati di distanza. L’Ansonia, il grande punto di riferimento del quartiere, fu costruito da Stanford White. Sembra un palazzo barocco di Praga o di Monaco ingrandito cento volte, con torri, cupole, enormi protuberanze e globi di metallo diventato verde per le intemperie, fregi e festoni di ferro battuto. Le nere antenne della televisione sono fittamente piantate sulle sue tonde sommità. Secondo il tempo che fa può sembrare di marmo o d’acqua marina, nero come l’ardesia nella nebbia, bianco come il tufo nel sole. Quel mattino era l’immagine di se stesso riflesso in acqua profonda, bianco e nuvoloso in alto, con distorsioni cavernose in basso. Insieme, i due uomini lo guardarono.
Poi Rubin disse: «Quel vecchio gentiluomo del suo papà è già dentro che fa colazione».
«Davvero? Prima di me, stamani?»
«È straordinaria la sua camicia» disse Rubin. «Dove l’ha presa, da Sacks?»
«No, è di Jack Fagman, Chicago.»
Anche quando era giù di morale, Wilhelm riusciva a corrugare la fronte in quel suo modo simpatico. Alcuni movimenti lenti e silenziosi del suo viso erano molto attraenti. Indietreggiò di un passo, come per staccarsi da se stesso e guardarsi meglio la camicia. La sua occhiata fu comica, un commento al proprio disordine. Gli piaceva vestirsi bene ma, non appena l’aveva indossato, ogni capo di vestiario sembrava andar per conto suo. Wilhelm, ridendo, ansimò un poco; aveva denti piccoli; le guance, quando rideva e sbuffava, si arrotondavano, e allora sembrava molto più giovane della sua età. Ai vecchi tempi, quando faceva il primo anno di università e portava una giacca di procione e un basco sulla grossa testa bionda, il padre gli diceva sempre che, pur grande e grosso com’era, nemmeno una tigre avrebbe resistito al suo fascino. Ancora oggi Wilhelm aveva molto fascino.
«Mi piace questo color tortora» disse con i suoi modi cordiali, da bravo ragazzo. «Non è lavabile. La si deve mandare in tintoria, e non ha mai quel buon odore di bucato. Ma è una bella camicia. È costata sedici o diciotto dollari.»
Quella camicia non l’aveva comprata Wilhelm: era un regalo del suo principale; il suo ex principale, col quale aveva litigato. Ma non c’era ragione di raccontare a Rubin tutta la storia. Sebbene Rubin forse la sapesse già, perché era il genere d’uomo che sapeva sempre tutto. Anche Wilhelm del resto sapeva molte cose di Rubin; sapeva della moglie di Rubin e degli affari di Rubin e della salute di Rubin. Ma non si potevano toccare quegli argomenti e il peso delle cose non dette lasciava poco di cui parlare.
«Ha proprio un’ottima cera, stamani» disse Rubin.
E Wilhelm, compiaciuto, «Sì? Dice davvero?». Non poteva crederci. Si vide riflesso nell’armadio a specchi pieno di scatole di sigari, tra i nobili stemmi, la carta damascata e i dorati ritratti in rilievo di uomini famosi, García, Edoardo VII, Ciro il Grande. Anche tenendo conto dell’oscurità e della deformazione dello specchio non aveva affatto una buona cera, pensò. Una larga ruga che pareva una parentesi e finiva tra le sopracciglia era scritta sulla sua fronte, e c’erano delle macchie marroni sulla sua pelle bionda. Cominciò a essere quasi divertito dall’ombra di quegli occhi stupiti, preoccupati, agognanti, da quelle narici e quelle labbra. Ippopotamo biondo! – era così che si vedeva. Vedeva una grossa faccia rotonda, una bocca fiorente, rossa e larga, denti corti e smussati. E il cappello, anche; e anche il sigaro. Avrei dovuto lavorare sodo tutta la vita, rifletté. Un buon lavoro duro e onesto che ti stanca e ti fa dormire di notte. Avrei consumato tutte le mie energie e mi sarei sentito meglio. Io dovevo distinguermi, invece.
Di sforzi ne aveva fatti, e parecchi, ma non era come lavorare duro, no? E se da giovane aveva preso una strada sbagliata lo doveva proprio a quella sua faccia. All’inizio degli anni Trenta, perché era un gran bel ragazzo, per breve tempo qualcuno gli aveva messo in testa che avrebbe potuto diventare un divo, e Wilhelm era andato a Hollywood. Laggiù, per sette anni, caparbiamente, aveva cercato di diventare un attore del cinema. Le sue illusioni e le sue ambizioni erano crollate molto prima di quel termine, ma per orgoglio e forse anche per pigrizia era rimasto in California. Alla fine si era volto ad altre cose, ma quei sette anni di ostinazione e d’insuccesso lo avevano in un certo qual modo reso inadatto al commercio e agli affari, e a quel punto era troppo tardi per diventare un professionista. Era maturato troppo adagio, e aveva perso terreno, e così non era riuscito a liberarsi della sua energia ed era convinto che proprio quell’energia lo avesse danneggiato più di ogni altra cosa.
«Non l’ho vista al tavolo da gioco, ieri sera» disse Rubin.
«Non ho potuto. Com’è andata?»
Da qualche settimana Wilhelm giocava a gin rummy quasi ogni sera, ma il giorno prima si era accorto che non poteva permettersi di perdere ancora. Non aveva mai vinto. Nemmeno una volta. E anche se le perdite erano piccole non erano mai vincite, no? Erano sempre perdite. Era stanco di perdere e stanco della compagnia, e così se n’era andato al cinema da solo.
«Oh» disse Rubin, «uno spasso. Carl ha fatto la figura dello stupido mettendosi a urlare contro i ragazzi. Ma stavolta il dottor Tamkin non gliel’ha lasciata passare. Gliene ha detto la ragione psicologica.»
«E che ragione era?»
Rubin disse: «Oh, non saprei ripeterla. Chi ci riuscirebbe? Sa come parla difficile il dottor Tamkin. Non lo chieda a me. Vuole il “Tribune”? Non guarda le quotazioni di chiusura?».
«Non c’è bisogno. So com’erano ieri alle tre» disse Wilhelm. «Ma è meglio che prenda il giornale lo stesso.» Sembrò che non potesse fare a meno di alzare una spalla per infilare la mano nella tasca della giacca. Ricordava che là, fra tubetti di pillole e mozziconi di sigarette e striscioline di cellophane, quei nastrini rossi dei pacchetti che talvolta adoperava per nettarsi i denti, ci dovevano essere degli spiccioli.
«Non va tanto bene, allora» disse Rubin. Voleva essere una battuta amabile, scherzosa, ma la sua voce era priva d’espressione e i suoi occhi, lenti e accecati dalle palpebre, si volsero altrove. Non voleva ascoltare. Per lui era lo stesso. Forse lo sapeva già. Era una di quelle persone che sanno sempre tutto.
No, non andava bene. Wilhelm aveva tre ordini di lardo alla Borsa Merci. Lui e il dottor Tamkin avevano comprato quel lardo quattro giorni prima a 12,96, e il prezzo aveva immediatamente cominciato a scendere e stava ancora scendendo. Nella posta di quella mattina doveva esserci sicuramente una ulteriore richiesta di copertura. Ne arrivava una ogni giorno.
Era stato lo psicologo, il dottor Tamkin, a convincerlo. Tamkin viveva al Gloriana ed era assiduo al tavolo da gioco. Aveva spiegato a Wilhelm che si poteva speculare sulle merci in una delle succursali di una buona agenzia di Wall Street senza fare l’intero deposito cauzionale legalmente richiesto. Dipendeva dall’agente della succursale. Se uno era conosciuto – e tutti gli agenti di cambio conoscevano Tamkin – poteva fare degli acquisti a breve giro. Bisognava soltanto aprire un piccolo conto.
«Tutto il segreto di questo genere di speculazione» gli aveva detto Tamkin «sta nella prontezza. Si deve agire in fretta, comprare e vendere, vendere e ricomprare. Ma svelti! Andare allo sportello e farli telegrafare a Chicago proprio nell’attimo giusto. Colpire e tornare a colpire! Poi tirarsi fuori il giorno stesso. In un baleno ti trovi per le mani quindici, ventimila dollari di soia, caffè, grano, pelli, frumento e cotone.» Era chiaro che il dottore capiva bene il mercato. Altrimenti non avrebbe potuto farlo apparire così semplice. «La gente perde perché è avida e non sa ritirarsi quando il mercato è in rialzo. Tutti giocano d’azzardo, ma io lo faccio scientificamente. Non tiro a indovinare. Si deve guadagnare qualche punto e uscire. Santo cielo!» disse il dottor Tamkin con i suoi occhi sporgenti, la testa calva, il labbro pendente. «Si è mai chiesto quanti quattrini si fa la gente con la Borsa?»
Wilhelm, passando rapidamente da un’espressione cupa e attenta alla risata ansante che gli trasformava completamente la faccia, aveva detto: «Come no? Cosa crede? E chi non sa come sono andate le cose dopo il ’28-’29? Chi non ha letto il resoconto della commissione d’inchiesta Fulbright? C’è denaro dappertutto. Tutti lo fanno a palate. Il denaro è… è…».
«E lei può starsene tranquillo mentre succedono queste cose?» disse il dottor Tamkin. «Io no, confesso che non ci riesco. Penso a tutta la gente che si fa una fortuna solo perché ha qualche dollaro da investire. Non hanno giudizio, non hanno capacità, hanno soltanto dei soldi che gli avanzano, e il denaro fa denaro. Solo a pensarci, mi viene addosso un’agitazione, mi sento rodere in un modo! Non sono nemmeno riuscito a esercitare la mia professione. Con tutto questo denaro intorno, uno non vuol passare da stupido mentre tutti gli altri fanno quattrini. Conosco dei tizi che guadagnano dai cinque ai diecimila dollari alla settimana senza far niente. Conosco un tale all’Hotel Pierre. Per lui è roba da nulla, ma pasteggia sempre con un’intera cassa di champagne Mumm. Ne conosco un altro al Central Park South… Ma a che serve parlarne? Loro fanno i milioni. E hanno degli avvocati in gamba che li salvano dalle tasse con mille scappatoie.»
«Io invece mi faccio sempre pescare» disse Wilhelm. «Mia moglie si è rifiutata di firmare una dichiarazione di reddito comune. Dopo un anno abbastanza buono mi hanno messo nella categoria del trentadue per cento e mi hanno spogliato nudo. E tutte le mie annate cattive?»
«È un governo d’affaristi» disse il dottor Tamkin. «Può star sicuro che quelli che guadagnano cinquemila dollari alla settimana…»
«Io non ho bisogno di tanto» disse Wilhelm. «Ah, se potessi avere soltanto un piccolo reddito fisso! Non molto. Io non chiedo molto, ma di quel poco ne ho proprio bisogno. Le sarei molto grato se volesse insegnarmi il sistema.»
«Certo. Io lo faccio regolarmente. Le porterò le mie ricevute, se lo desidera. E sa una cosa? Approvo il suo atteggiamento. Non vuole farsi prendere dalla febbre dell’oro, vero? Questo genere d’attività è sempre accompagnato da sentimenti ostili e da cupidigia. Dovrebbe vedere come si riduce la gente. Vanno in Borsa con l’animo pieno d’istinti omicidi.»
«Com’è che diceva un tale che ho conosciuto?» replicò Wilhelm. «Un uomo vale quanto le cose che ama.»
«Proprio così» disse Tamkin. «Non c’è bisogno di farlo in quel modo. C’è anche un modo calmo e razionale, un avvicinamento psicologico.»
Il padre di Wilhelm, il vecchio dottor Adler, viveva in un mondo interamente diverso da quello del figlio, ma una volta lo aveva messo in guardia contro il dottor Tamkin. Con un tono piuttosto casuale – era un vecchio molto soave – gli aveva detto: «Wilky, forse tu dai troppo ascolto a quel Tamkin. Parlare con lui è interessante, non lo metto in dubbio. Mi sembra un uomo piuttosto ordinario, ma certo è molto persuasivo. Comunque non so fino a che punto ci si possa fidare di lui».
Che suo padre gli parlasse con un simile distacco di una cosa così importante per lui sul piano economico aveva molto amareggiato Wilhelm. Il dottor Adler ci teneva a sembrare affabile. Affabile! Suo figlio, il suo unico figlio maschio, non poteva confidarsi con lui, aprirgli il proprio cuore. Non mi rivolgerei a Tamkin, pensò, se potessi rivolgermi a lui. Almeno Tamkin mi capisce e cerca di darmi una mano, mentre papà non vuole essere disturbato.
Il vecchio dottor Adler si era ritirato dalla professione, aveva una rendita considerevole e gli sarebbe stato facile aiutare il figlio. Poco tempo prima Wilhelm gli aveva detto: «Papà… sto attraversando un momento critico. Mi dispiace dirtelo. Capisci bene che preferirei darti delle buone notizie. Ma purtroppo è così, papà. Che cos’altro dovrei dire? È così».
Un altro padre avrebbe forse apprezzato una confessione tanto difficile… La confessione di un uomo sfortunato, stanco, debole, e fallito. Wilhelm aveva cercato di imitare i modi del vecchio, aveva parlato da signore, a voce bassa, con buon gusto. Non aveva permesso alla sua voce di tremare; non aveva fatto gesti stupidi. Ma il dottore non aveva risposto. Si era limitato ad annuire. Come se gli avessero detto che Seattle era vicina a Puget Sound, o che i Giants e i Dodgers avrebbero giocato una partita notturna; tanto poco era cambiata la sua espressione di bel vecchio sano e soddisfatto. Si comportava col figlio come una v...