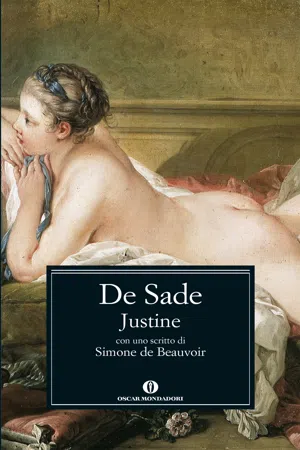Sarebbe il capolavoro della filosofia rendere evidenti i mezzi adoperati dalla provvidenza per raggiungere i propri fini sull’uomo, e trarne piani di condotta che indichino, a questo sventurato individuo bipede, come procedere nello spinoso cammino della vita, se vuol prevenire i capricci bizzarri di quella fatalità cui si danno venti nomi diversi, ma che ancora non si è giunti né a conoscere né a definire.
Se, nonostante il rispetto per le nostre convenzioni sociali e l’accettazione delle dighe da esse imposte, ci è accaduto di non incontrare che rovi, mentre i malvagi non raccoglievano che rose, uomini con un patrimonio di virtù poco sperimentate potranno, tenendo conto di osservazioni simili, calcolar vantaggioso l’abbandonarsi alla corrente anziché resisterle. Diranno che la virtù, per bella che sia, diventa il peggior partito quando è troppo debole per lottare contro il vizio, e che in un secolo interamente corrotto la cosa più sicura è fare come fanno tutti. D’altra parte, chi è più istruito, se così si può dire, e abusa dei lumi acquisiti, dirà con l’angelo Jesrad di Zadig che non c’è male da cui non nasca un bene, e dunque è lecito abbandonarsi al male, poiché di fatto il male è uno tra i modi per produrre il bene. Aggiungerà: al piano generale è indifferente che il tale o il talaltro sia buono invece che cattivo; dunque se la sventura perseguita la virtù, se la prosperità si accompagna al crimine e crimine e virtù sono uguali dal punto di vista della Natura, è infinitamente più saggio prender partito tra i malvagi che prosperano, piuttosto che tra i virtuosi votati alla rovina. È importante prevenire questi pericolosi sofismi di una falsa filosofia. Essenziale è rendere evidente l’efficacia degli esempi di virtù sventurata nel ricondurre al bene un’anima corrotta, in cui restino tuttavia alcuni buoni principi; efficacia non inferiore a quella del mostrare, sulla strada della virtù, le palme più brillanti e le ricompense più lusinghiere. Senza dubbio, è crudele dipingere da una parte un cumulo di sventure che opprimano una donna dolce, sensibile, fedele alla virtù, dall’altra la profusione delle fortune per coloro che quella donna schiaccino o mortifichino. Tuttavia se ne consegue un bene, chi mai proverà rimorso per avere presentato il quadro di tali fatalità? E a chi potrà rincrescere di aver stabilito un fatto da cui risulta, per il saggio che legge con profitto, la così utile lezione del soggiacere agli ordini della provvidenza, e l’avvertimento fatale che spesso, per ricondurci ai nostri doveri, il cielo maltratta accanto a noi l’essere che meglio ci sembri aver assolto ai proprî?
Questi sentimenti orienteranno il nostro lavoro. In considerazione di ciò, chiediamo venia al lettore dei sistemi errati posti in bocca a molti nostri personaggi, e delle situazioni talvolta scabrose che, per amor di verità, abbiamo dovuto mettergli sotto gli occhi.
La contessa di Lorsange era una tra quelle sacerdotesse di Venere la cui fortuna è frutto di un aspetto incantevole e di una condotta molto licenziosa, e i cui titoli, per pomposi che siano, si trovano soltanto negli archivi di Citera, forgiati dall’impertinenza che se ne appropria, avallati dalla sciocca credulità che li attribuisce. Bruna, formosa, occhi stranamente espressivi; quel certo scetticismo alla moda che, aggiungendo un pizzico di sale alle passioni, fa guardar con maggiore interesse le donne in cui lo si avverte; un po’ malvagia, priva di princìpi, incapace di vedere il male in alcunché, e tuttavia non abbastanza depravata perché nel suo cuore fosse completamente spenta la sensibilità; orgogliosa, libertina: ecco la signora di Lorsange.
Costei aveva ricevuto nondimeno un’ottima educazione. Figlia di un grosso banchiere di Parigi era stata allevata con una sorella, di nome Justine, minore di tre anni, in una tra le più celebri abbazie della capitale; fino all’età di dodici e quindici anni, nessun consiglio, nessun maestro, nessun libro, nessuna occasione erano stati negati alle due sorelle.
A quell’epoca, fatale per la virtù di queste giovinette, tutto mancò loro in un sol giorno. Una spaventosa bancarotta precipitò il padre in una situazione tanto crudele che egli ne morì di dolore. Un mese dopo sua moglie lo seguì nella tomba. Due parenti freddi e indifferenti deliberarono sul futuro delle giovani orfane. I debiti avevano mangiato l’eredità; la parte di ciascuna ammontava a cento scudi. Poiché nessuno si offrì di prenderle a carico fu loro aperta la porta del convento; ebbero la loro dote ed entrambe si trovarono libere di agire secondo i propri voleri.
La signora di Lorsange, che si chiamava allora Juliette e in sostanza era già formata, nel carattere e nello spirito, come lo sarebbe stata, a trent’anni ossia durante la storia che racconteremo, sembrò unicamente sensibile al piacere della libertà, senza alcun pensiero per i crudeli rovesci che spezzavano le sue catene. Ma a Justine, dodicenne come abbiamo detto, un’indole cupa e malinconica lasciò sentire tutto l’orrore delle circostanze. Dotata di una delicatezza e di una sensibilità sorprendenti possedeva, in luogo dell’avidità e dell’astuzia della sorella, un’ingenuità e un candore che la destinavano a cadere in un gran numero di trappole. La giovinetta univa a tali qualità una fisionomia dolce, completamente diversa da quella di cui la natura aveva adornato Juliette; tanto si vedeva di artificio, ammanieramento e civetteria nei tratti di costei, quanto si ammirava di pudore, convenienza, timidezza nell’altra. Un’aria da vergine, grandi occhi blu pieni di anima e sentimento, una pelle luminosa, una figura morbida e flessibile, un affascinante tono di voce, denti d’avorio e meravigliosi capelli biondi: ecco accennata questa incantevole secondogenita, le cui ingenue grazie e i cui tratti delicati superano i nostri pennelli.
Alle due sorelle furono date ventiquattro ore per abbandonare il convento e si lasciò loro la cura di sistemarsi, con cento scudi, come ritenessero meglio. Juliette, felice perch’era padrona di se stessa, cercò per un momento di asciugar le lagrime di Justine; poi, vedendo che non vi riusciva, la rimproverò invece che consolarla; le fece colpa dei suoi sentimenti delicati. Disse, con una filosofia molto superiore alla sua età, che in questo mondo ci deve affliggere solo quanto ci tocca personalmente; che era possibile trovare in noi stessi sensazioni fisiche abbastanza stimolanti e voluttuose da cancellare il dolore di qualsiasi ferita morale: sistema, questo, che era essenziale mettere in pratica, poiché la vera saggezza consiste nel raddoppiare la somma dei propri piaceri, non nel moltiplicare quella delle pene. Si doveva far di tutto, in conclusione, per smorzare nel proprio animo una sensibilità traditrice, di cui gli altri approfittavano, mentre, a chi l’aveva, non ne venivano che afflizioni. Ma si indurisce difficilmente un cuore buono: esso resiste ai consigli di una mente malvagia, e le gioie che gli sono proprie non gli fanno desiderare la luccicante bigiotteria dei begli spiriti.
Juliette ricorse allora ad altri argomenti. Disse alla sorella che alla loro età e con il loro aspetto era impossibile morir di fame. Le citò la figlia di una delle loro vicine. Fuggita dalla casa paterna era adesso riccamente mantenuta e ben più felice, senza dubbio, di quanto lo sarebbe stata in seno alla famiglia; Juliette aggiunse che bisognava guardarsi dal credere il matrimonio propizio alla felicità d’una fanciulla. Prigioniera delle leggi coniugali, questa avrebbe avuto molte tristezze da sopportare, e ben pochi piaceri da attendersi; abbandonandosi invece al libertinaggio, entrambe avrebbero potuto mettersi sempre al riparo dal mutevole umore degli amanti o consolarsi, almeno, moltiplicando il numero di costoro.
Justine aborrì quei discorsi. Disse che preferiva la morte all’ignominia e, per quanto la sorella insistesse, rifiutò ostinatamente di abitare con lei, non appena la vide propendere decisamente a un’orribile condotta.
Le due giovani si separarono, dunque, e senza alcuna promessa di rivedersi. Erano troppo diverse le loro intenzioni. Juliette che, a proprio dire, sarebbe diventata una gran dama, certamente non avrebbe consentito a ricevere una ragazzina le cui inclinazioni, virtuose ma poco brillanti, potevano disonorarla. Da parte sua, Justine non avrebbe rischiato la propria onestà in compagnia di una perversa creatura, pronta a farsi vittima della crapula e della pubblica dissolutezza. Si scambiarono dunque un addio definitivo, ed entrambe lasciarono il convento fin dal giorno successivo.
Justine, che da bambina era stata vezzeggiata dalla sarta di sua madre, la immagina sensibile alla sua sventura. Va a trovarla, le parla delle proprie vicissitudini, le chiede del lavoro. A stento vien riconosciuta, duramente la si respinge.
«O cielo,» dice la poveretta «bisogna dunque che già i miei primi passi nel mondo siano angosciosi! Questa donna, un tempo, mi amava; perché oggi mi respinge? Ahimè! perché sono orfana e povera; perché non ho risorse, e alla gente si è graditi quando spera di ottenere da noi aiuti e benefici.»
Justine in lagrime va a trovare il suo parroco; gli dipinge il proprio stato con l’energico candore dell’età. Aveva una vesticciola bianca aderente; i bei capelli raccolti negligentemente sotto un gran berretto; il seno appena segnato, nascosto sotto due o tre braccia di velo; il visetto grazioso, un po’ pallido per i dispiaceri che la divoravano. Qualche lagrima le bagnava gli occhi rendendoli ancor più espressivi.
«Voi mi vedete, signore» dice al pio ecclesiastico. «Sì, mi vedete in una situazione ben triste per una fanciulla: ho perduto mio padre e mia madre… Il cielo me li toglie nell’età in cui più avrei bisogno del loro aiuto… Sono morti rovinati, signore, non abbiamo più nulla. Ecco tutto quanto mi hanno lasciato» continua mostrando i suoi dodici luigi «… e non un giaciglio su cui poter poggiare la mia povera testa… Voi avrete pietà per me, nevvero, signore? Siete il ministro della religione e la religione fu sempre il sostegno del mio cuore; nel nome del Dio che adoro, e di cui voi siete portavoce, ditemi, come un secondo padre, quel che devo fare, cosa devo diventare…»
Il caritatevole prete rispose, guardando in tralice Justine, che la parrocchia era fin troppo gravata, e difficilmente avrebbe potuto accollarsi altra beneficenza. Se tuttavia Justine voleva restar a servizio, e fare il grosso dei lavori, ci sarebbe stato sempre in cucina un pezzo di pane per lei. Così dicendo l’interprete degli dèi le aveva passato la mano sotto il mento, dandole un bacio un po’ troppo mondano per un uomo di Chiesa. Justine, che ne aveva capito benissimo le intenzioni, lo respinse dicendogli: «Signore, non vi domando né l’elemosina né un posto di serva; da troppo poco tempo ho lasciato uno stato superiore a quello che fa desiderare simili favori, per essere ridotta a implorarli. Sollecito i consigli di cui la mia giovinezza e le mie sventure hanno bisogno, ma voi volete che li compri a un prezzo troppo alto». Il pastore, confuso per essere stato smascherato, cacciò immediatamente la giovane creatura; e la sventurata Justine due volte respinta già nel primo giorno di abbandono a se stessa, entra in una casa dove vede un cartello, affitta uno stanzino ammobiliato al quinto piano, lo paga in anticipo, lasciandosi poi andare a lagrime rese più amare da un carattere sensibile e dalle crudeli ferite inferte alla sua piccola fierezza.
Qui, se ci è permesso, la lasceremo per un po’ e torneremo a Juliette, per dire come, dalla condizione modesta in cui la abbiamo vista, senza risorse maggiori di quelle della sorella, divenga in quindici anni una donna titolata che possiede trentamila lire di rendita, bellissimi gioielli, due o tre case in città e in campagna e, al momento della nostra storia, il cuore, la fortuna e la fiducia del signor di Corville, consigliere di Stato, uomo di grande prestigio alla vigilia di entrare nel ministero. Nella carriera di Juliette non sono mancate le spine, senza dubbio. Colei che oggi è nel letto di un principe porta forse ancora, su di sé, i segni umilianti lasciati dalla brutalità dei libertini, nelle cui mani la gettarono giovinezza e inesperienza.
Uscendo di convento Juliette era andata a trovare una donna: ne aveva udito il nome dalla giovane e corrotta amica del vicinato che voleva imitare (a corromperla era stata proprio la donna in questione). Le si presenta con un fagotto sotto il braccio, una tunichetta blu in disordine, capelli sciolti e un aspetto graziosissimo, se è vero che per certi occhi l’impudicizia è attraente. Le racconta la sua storia, e la supplica di proteggerla come ha protetto la sua vecchia amica.
«Che età avete?» domanda la Duvergier.
«Quindici anni fra qualche giorno, signora» risponde Juliette.
«E mai nessuno…» continuò la matrona.
«O no, signora, lo giuro» replicò Juliette.
«Il fatto è che qualche volta, in questi conventi…» disse la vecchia. «Un confessore, una religiosa, una compagna… Ho bisogno di prove sicure.»
«Non sta che a voi procurarvele, signora» rispose Juliette arrossendo.
E la vecchia, inforcati un paio di occhiali e visitate con scrupolo le cose da tutti i lati:
«È inteso» dice alla fanciulla. «Non avete che da restar qui! Abbiate rispetto per i miei consigli, una buona dose di compiacenza e sottomissione per i miei clienti, siate pulita, economa, sincera nei miei confronti, diplomatica con le compagne, furba con gli uomini, e prima di dieci anni vi metterò in condizione di ritirarvi a un terzo piano con comò, specchiera e domestica. L’arte imparata presso di me vi permetterà di procacciarvi il resto.»
Fatte queste raccomandazioni la Duvergier s’impadronisce del fagottino di Juliette; le domanda se ha denaro; avendole lei, con troppa franchezza, confessato di avere cento scudi, la cara mamma glieli confisca. Alla nuova pensionante si garantisce che il piccolo fondo verrà investito, a suo nome, nella lotteria; non sta bene (aggiunge la donna) che una fanciulla disponga di denaro. «È» le dice «un incentivo a fare il male; in un secolo così corrotto una giovinetta saggia e bennata deve evitare con cura tutto ciò che può trascinarla in qualche trappola. Vi parlo per il vostro bene, piccola mia, conclude la vecchia, e dovete essermi grata per quello che faccio.»
Finito il sermone la nuova venuta è presentata alle compagne; le si indica la camera che occuperà nella casa, e già dal giorno dopo le sue primizie sono in vendita.
In quattro mesi la stessa merce è venduta successivamente a quasi cento persone. Alcuni si contentano della rosa, altri più delicati o più depravati (la questione è in sospeso) vogliono schiudere il bocciolo che fiorisce lì accanto. Ogni volta la Duvergier restringe e riaggiusta; per quattro mesi son sempre primizie quelle che la briccona offre al pubblico. Al termine di questo spinoso noviziato Juliette ottiene finalmente la patente di suora conversa; da allora è ufficialmente riconosciuta ragazza della casa, condivide fatiche e profitti. Altro apprendistato: se, alla prima scuola, Juliette ha servito, tranne poche deroghe, la natura, ne dimentica le leggi alla seconda. Del tutto ella corrompe i suoi costumi; il trionfo che vede ottenere dal vizio degrada completamente la sua anima; sente che, nata per il crimine, deve almeno arrivar a conoscerne la grandezza, rinunciando a languire in uno stato subalterno che le fa commettere colpe uguali, e ugualmente la avvilisce, procurandole tuttavia un profitto di gran lunga minore. Piace a un vecchio signore debosciato, che l’aveva invitata per un incontro frettoloso. Ha l’arte di farsi magnificamente mantenere. Compare agli spettacoli, alle passeggiate, a fianco dei notabili dell’ordine di Citera; la si guarda, la si cita, la si invidia, e tanto l’astuta creatura ci sa fare che in meno di quattro anni rovina sei uomini, il più povero dei quali aveva centomila scudi di rendita. Non ci volle altro per fare la sua reputazione. Tale è la cecità della gente di mondo che queste creature sono tanto più ambite, e più si anela a far parte della loro “lista”, quanto più hanno dato prova di disonestà; i sentimenti che si osa ostentare per loro sono proporzionali al grado dell’abiezione e della corruzione.
Juliette aveva appena compiuto vent’anni quando un certo conte di Lorsange, gentiluomo angioino di circa quaranta, tanto se ne invaghì che decise di darle il suo nome. Le accordò dodicimila lire di rendita e le legò il resto della sua fortuna, se fosse morto prima; le diede una casa, dei servitori, un blasone e una posizione in società che in due o tre anni riuscì a far dimenticare i suoi esordi.
Fu a questo punto che la sciagurata Juliette, scordando la sua nascita onorata e la buona educazione ricevuta, pervertita da cattivi consigli e da libri perniciosi, ansiosa di godere liberamente, di avere un nome e nessuna catena, osò abbandonarsi alla scellerata idea di abbreviare i giorni del marito. Questo progetto odioso, non appena balenato, ella cominciò a rimuginarlo; lo rafforzò purtroppo in quei momenti pericolosi nei quali il fisico s’infiamma per i vaneggiamenti dell’immaginazione, momenti in cui ci si abbandona a tutto, giacché niente si oppone alla sregolatezza dei propositi, o all’impetuosità dei desideri, e la voluttà che ce ne viene si mantiene vivida in ragione del numero dei freni spezzati, o della loro santità. Se, svanito il sogno, si torna savi, poco sarà il danno: è quel che accade quando le colpe restano nel nostro spirito: nessuno ne è offeso; disgraziatamente si va più in là. Che cosa sarà, si osa dire a se stessi, la realizzazione dell’idea, se il suo solo adombrarsi un momento fa ci esaltava e turbava così vivamente? Si dà corpo alla maledetta chimera; la sua esistenza diventa un crimine.
La signora di Lorsange si comportò per sua fortuna con tanta segretezza da mettersi al riparo da qualsiasi conseguenza, e insieme allo sposo seppellì le tracce dell’abominevole misfatto che lo precipitava nella tomba.
Tornata libera e contessa, la signora di Lorsange riprese le antiche abitudini; ma ormai si considerava qualcuno in società, e circondò la sua condotta di un certo decoro. Non era più una ragazza mantenuta, bensì una ricca vedova che offriva piacevoli cene e nella cui casa borghesi e cortigiani erano ben felici di essere ammessi: una donna perbene in una parola, che nondimeno dormiva con chiunque per duecento luigi e si vendeva per cinquecento al mese.
Fino a ventisei anni la signora di Lorsange fece ancora brillanti conquiste. Rovinò tre ambasciatori stranieri, quattro appaltatori generali, due vescovi, un cardinale e tre cavalieri dell’Ordine del Re; ma è difficile fermarsi dopo un primo delitto, soprattutto andato a buon fine: la sciagurata Juliette si macchiò dunque di due nuovi crimini, simili al primo, per derubare uno dei suoi amanti che le aveva affidato all’insaputa della famiglia una somma considerevole (somma che la signora di Lorsange poté incamerare grazie alla sua spaventevole azione) e per ottenere anzitempo un legato di centomila franchi che uno dei suo...