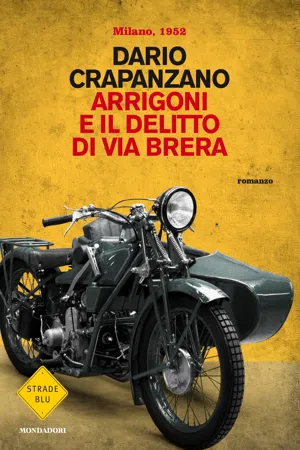Mariangela Marangon era proprio una gran bella ragazza. A cominciare da un viso dall’ovale perfetto, illuminato da stupendi occhi nocciola da cerbiatto, incorniciato da lunghi, setosi capelli biondo cenere. E, sotto un bel naso dal profilo greco, il capolavoro di una bocca dalle labbra morbide e carnose, caratterizzate da un’imbronciatura naturale che le conferiva un’espressione al contempo capricciosa e sensuale. Alla Brigitte Bardot, per intenderci. A completare l’opera, un fisico mozzafiato: un metro e settanta di altezza e una serie di curve messe nei punti giusti, che provocavano più di un torcicollo al pubblico maschile quando la ragazza passeggiava per le strade di Milano.
Alle otto e un quarto di una calda mattina del luglio 1952, Mariangela procedeva con passo svelto ed elastico lungo via Brera, diretta verso il suo posto di lavoro, lo studio pubblicitario Le Idee, situato in un signorile palazzo della stessa via, circa a metà strada fra piazza della Scala e la sede del “Corriere della Sera” in via Solferino, nel bel mezzo del quartiere artistico e intellettuale milanese.
Uno studio pubblicitario, all’epoca, era solo un lontanissimo parente delle rutilanti agenzie che, a partire dalla fine degli anni Sessanta, soprattutto grazie all’arrivo delle multinazionali americane, avrebbero dominato il panorama della comunicazione commerciale in Italia. La televisione non era ancora nata, e gli sforzi dei creativi si concentravano soprattutto su manifesti, stampa e radio.
La star dell’epoca era il barese Gino Boccasile, morto nel maggio del ’52 a poco più di cinquant’anni. Boccasile è ricordato anche per la sua adesione convinta al regime mussoliniano, che aveva propagandato con geniali slogan (uno per tutti: “Taci, il nemico ti ascolta!”). Ma era soprattutto un artista dalle grandi capacità creative, che negli anni Trenta aveva ideato le copertine della rivista “Signorine Grandi Firme”, inventando e imponendo il modello ideale della donna dell’era fascista: mediterranea, procace e sensuale. Lo stesso tipo di donna che Boccasile propose, nel dopoguerra, in famose campagne pubblicitarie per i prodotti più disparati: calze, motociclette, formaggini, dentifrici, talchi e profumi. Fece scandalo, e fu infatti censurato, il suo manifesto per i cosmetici Paglieri, dove, accanto all’innocente scritta “Dai fiori le ciprie i profumi Paglieri”, appariva il disegno di una giovane donna a seno nudo.
Le immagini a disegno, soprattutto se femminili, in pubblicità erano molto più utilizzate delle foto, in quanto meno passibili di interventi da parte della censura. Nell’Italia bacchettona e clericale di allora, la rappresentazione grafica di un corpo femminile, anche se proposto in atteggiamenti vagamente provocanti, era considerata peccaminosa come quella di una donna fotografata in carne e ossa.
Mariangela, pur lavorando nel settore, non era né una grafica né un’artista. Il suo compito era quello di tenere i rapporti con i responsabili delle aziende che si affidavano allo studio per la pubblicità dei loro prodotti o servizi. Ci riusciva benissimo perché, oltre che bella, era dotata di una notevole intelligenza e di un formidabile intuito, che le consentivano di capire al volo le esigenze dei clienti e di tradurle poi nelle risposte professionali più efficaci, sopperendo brillantemente alla mancanza di quel supporto culturale che solo un’educazione scolastica più completa avrebbe potuto darle.
Figlia di genitori immigrati da un paesino della provincia di Vicenza, lui muratore spesso disoccupato e lei donna di servizio, Mariangela era cresciuta in due locali di una casa popolare di via San Mamete, a Crescenzago, rione nella zona nord della città. Rivelandosi, fin da piccola, una sorprendente miscela di bellezza, intelligenza e vivacità.
La vita scolastica aveva confermato sul campo le qualità della bambina, con promozioni a pieni voti sia alle elementari sia alle successive commerciali, le scuole che formavano le future impiegate e commesse.
Visti i brillanti risultati, i genitori di Mariangela, per quanto quasi analfabeti, capirono, anche grazie alle insistenze di un’insegnante, che la ragazzina doveva continuare a studiare. Rinunciarono così al pur modesto contributo che, lavorando, Mariangela avrebbe potuto dare al magro bilancio familiare e la iscrissero al corso biennale per il diploma di computista commerciale, che lei conseguì con i migliori voti della classe, acquisendo un bagaglio di conoscenze che andava da più approfondite nozioni di contabilità a una maggior padronanza della lingua francese.
A questo punto, secondo i genitori era ora che Mariangela trovasse un lavoro e cominciasse a portare a casa qualche soldo. Lavoro che arrivò subito, grazie alla felice combinazione di un decente titolo di studio e di una bellezza fuori del comune. Fu assunta come commessa in una panetteria vicino a casa, per passare poi a una più pretenziosa pasticceria, sempre nella zona di Crescenzago. Passato un anno, la ragazza già scalpitava, troppo ambiziosa per arrendersi alla prospettiva di passare la vita a incartare torte e pasticcini in un negozio di periferia. Aveva diciassette anni, ormai adulta nel fisico, e che fisico!, e nella testa e, ben consapevole delle sue doti, sentiva che era il momento giusto per provare a dare una svolta alla sua carriera. Rispose ad alcune inserzioni e, dopo qualche colloquio, fu assunta come commessa in un’elegante pelletteria del centro, in corso Vittorio Emanuele.
Nel nuovo, raffinato ambiente, Mariangela si trovò subito a suo agio: si muoveva con garbo ed eleganza, fra solidi scaffali in legno massiccio, tavoli di mogano, parquet e tappeti persiani, maneggiando con grazia e sicurezza la preziosa merce, consistente in morbidi guanti, borse e borsette, cartelle, portafogli e cinture.
Nel giro di pochi mesi entrò nelle grazie della clientela, non solo maschile come sarebbe troppo facile pensare, ma anche delle signore, colpite e conquistate dai suoi modi cortesi e coinvolgenti. Meno successo ottenne presso le due esperte colleghe, mature “signorine” di scarsa avvenenza, che dovettero però fare buon viso a cattivo gioco, perché i coniugi proprietari del negozio stravedevano per “la bionda Mariangela”, che gratificarono anche con un piccolo aumento di stipendio.
La ragazza rimase alla pelletteria per un paio d’anni, cioè fino a quando un cliente, l’architetto Osvaldo Verga, un bell’uomo sulla quarantina titolare di uno studio di pubblicità, non fece una certa mossa.
Dopo una serie di approcci ondeggianti fra il corteggiamento e l’intervista professionale, il Verga una sera la invitò per un aperitivo in San Babila, dopo la chiusura del negozio. Senza troppi preamboli, le offrì un posto di lavoro. Mariangela, che forse si aspettava qualche altro tipo di proposta, fu presa in contropiede e, come prima reazione, con molta sincerità fece presente che non sapeva disegnare né tanto meno inventare slogan. Il Verga chiarì subito che quelle qualità non erano necessarie per il compito che aveva in mente di affidarle, precisando che cercava una persona di fiducia in grado di dargli una mano nei rapporti con i clienti, e aggiunse:
«Lo so che sei giovane e senza esperienza, ma hai dalla tua il bell’aspetto e una notevole capacità di trattare con la gente, e ho sentito che mastichi pure un po’ di francese. Una volta che avrai imparato alcune regole del mestiere, sarai perfetta, credi a uno che se ne intende. Riflettici pure per qualche giorno. Ah» proseguì dopo una breve pausa, «il tuo stipendio iniziale sarà di 50.000 lire al mese.»
“Mamma mia, 50.000 lire al mese!” si disse Mariangela, eccitata ma anche stupita e insospettita da una proposta così generosa per un lavoro a lei del tutto sconosciuto. Il fatto che tra le sue qualità il Verga avesse accennato alla bellezza, pur mettendola in guardia, non la stupì più di tanto, avendo ormai capito da sola quanto questa avesse contribuito al suo successo nel mestiere di commessa.
Per dare un’idea del valore dello stipendio offerto, 50.000 lire equivalevano a più di 1000 euro attuali, ma, in proporzione, con un maggior potere d’acquisto. Non male per una ragazza di diciannove anni!
Mariangela ci pensò su un paio di giorni. Le dispiaceva lasciare un posto dove si trovava benissimo, ma alla fine decise di accettare, sia perché allettata dal forte aumento di stipendio, sia perché, per natura curiosa e portata alle novità, la intrigava questo strano tipo di lavoro, una sfida e allo stesso tempo un’opportunità che il destino aveva messo sulla sua strada.
Comunicò la sua decisione in un secondo incontro con aperitivo, durante il quale il suo futuro principale aggiunse altra carne al fuoco:
«E ricordati che siamo solo all’inizio. Questo è un mestiere privilegiato, dove si possono ottenere grandi soddisfazioni e guadagnare un sacco di soldi: se te lo meriterai, gli aumenti di stipendio non dovrai nemmeno chiederli.»
«Architetto, non corriamo troppo, sono già contenta così» fu la cauta e apparentemente umile risposta della giovane, che però dentro di sé non poté fare a meno di pensare: “A caval donato non si guarda in bocca. Se poi c’è sotto qualcos’altro, si vedrà, caro Osvaldo”.
Nei due anni trascorsi allo studio, Mariangela se la cavò molto bene, imparando in fretta e svolgendo con sempre maggior sicurezza il compito affidatole. E vennero pure un paio dei promessi aumenti, più l’inatteso regalo, da parte del Verga, dell’iscrizione alla scuola guida per il conseguimento della patente, ottenuta al primo tentativo.
Non essendosi però ancora comprata l’auto, Mariangela arrivò a piedi davanti al portone d’ingresso del palazzo dove aveva sede lo studio, annunciato da una targa che recitava, un po’ velleitariamente: “Le Idee. Studio di pubblicità – Le nostre idee per i vostri successi”.
Salutato il sussiegoso portiere, elegante nella sua divisa con tanto di alamari e degno copricapo, la ragazza raggiunse lo studio, al primo piano, preparandosi ad aprire con le sue chiavi, visto che a quell’ora probabilmente dentro non c’era ancora nessuno. Infatti, tutte le stanze erano vuote, tranne quella di Osvaldo Verga, la cui porta era spalancata, rivelando un marasma di fogli e oggetti sparsi qua e là, certamente provenienti dai cassetti, anch’essi in terra, completamente svuotati. Seduto alla scrivania, piegato in avanti quasi stesse dormendo, stava il corpo del titolare dello studio. Un esame più approfondito avrebbe rivelato, in corrispondenza della tempia sinistra, un vistoso squarcio con sangue ormai coagulato, che imbrattava anche il petto e le maniche della camicia. Mariangela toccò leggermente la spalla dell’uomo, ma non ottenne alcuna reazione e, accortasi del mare di sangue, cacciò un urlo terrificante, uscì e si precipitò giù dalle scale per raggiungere la portineria. Osvaldo Verga era morto.
Mattinata tranquilla, al commissariato Porta Venezia. Calda, ma tranquilla. Sarà stato a causa della temperatura, che in quei torridi giorni di luglio non perdonava, ma anche la malavita batteva la fiacca: qualche furto qua e là, un borseggio sul tram... roba da poco insomma.
Il commissario capo Mario Arrigoni, in maniche di camicia, cravatta allentata e colletto sbottonato, dopo il caffè preparatogli dall’agente centralinista Maiocchi, stava sfumazzando il primo toscano della giornata, impegnato nella lettura del giornale.
Nell’anno di grazia 1952 non mancavano gli argomenti per riempire le pagine dei quotidiani.
In Europa era ormai prossima l’istituzione della Comunità Europea Carbone e Acciaio (CECA), prima pietra della futura Unione, cui aderivano Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo.
Al di là dell’oceano, negli Stati Uniti, era in corso la campagna elettorale per la presidenza, che a novembre avrebbe visto vincitore l’ex generale Dwight Eisenhower, detto “Ike”, già comandante in capo delle truppe alleate durante l’ultima guerra mondiale.
A casa nostra, incendiava il mondo della politica la preannunciata proposta di una nuova legge elettorale, già battezzata “legge truffa”, che prevedeva, per il partito o la coalizione che avesse ottenuto il 50 per cento più uno dei voti alle elezioni politiche, l’assegnazione del 65 per cento dei seggi, nel nome della governabilità e stabilità del Paese. Così sostenevano i promotori, in primis la Democrazia Cristiana, mentre gli oppositori contestavano il fatto che alla coalizione vincente in pratica veniva regalato un 15 per cento non ottenuto con i voti degli elettori. Comunque, alle elezioni del 1953 la coalizione capeggiata dalla Democrazia Cristiana avrebbe ottenuto il 49,89 per cento dei voti, e per un’inezia la nuova legge non produsse alcun effetto, per essere poi abolita l’anno seguente.
Infine, pur non essendo particolarmente interessato allo sport, persino Arrigoni non poteva esimersi dal seguire l’andamento del Tour de France, che appunto si correva, e si corre tuttora, nel mese di luglio. Tour che il campionissimo Fausto Coppi, dopo un inizio incerto, si preparava a vincere per la seconda volta, realizzando ancora l’accoppiata Giro d’Italia/Tour de France come nel 1949, impresa fino ad allora mai riuscita a nessun corridore.
Erano giorni un po’ particolari per il commissario capo, rimasto solo in città. Infatti, la bella moglie Lucia e la figlia dodicenne Claudia erano in vacanza a Canzo, in Brianza, assieme all’ottantenne nonna Giulia, madre di Arrigoni. La quale però, nel segno della sua spiccata tendenza all’autonomia, soggiornava in una piccola pensione a un centinaio di metri dalla villetta dove stavano nuora e nipote.
Anche se non lo avrebbe confessato nemmeno sotto tortura, questa situazione estiva non piaceva per nulla a Mario Arrigoni, per una serie di motivi, dai più nobili ai più biecamente egoistici. Fra i primi, mettiamoci la mancanza di tutti i suoi punti di riferimento affettivo, e la conseguenza di una vita privata solitaria e silenziosa, un grande vuoto che il lavoro non riusciva a colmare. Egoisticamente invece, in prima fila c’era il fatto che il commissario, tanto bravo a fare il suo mestiere, in casa non valeva una cicca e, a cinquant’anni suonati, pur con tutta la sua buona volontà, non riusciva proprio a imparare. In cucina, come del resto tutti gli uomini dell’epoca, era un vero disastro, anche quando si cimentava nella preparazione dei cibi più semplici, come un uovo al burro o una bistecca. Rinunciava persino al tradizionale caffè di prima mattina, rimandandone il piacere fino all’arrivo in commissariato.
Essendo però una gran bella forchetta, di saltare il pasto non se ne parlava proprio. Non potendo permettersi di andare due volte al giorno in trattoria o al bar da Gino, specializzato nei famosi sanguis, come i milanesi chiamavano i panini storpiando l’inglese “sandwich”, per la cena si era accordato con la portinaia Santina, che, da buona pugliese, gli preparava ottimi piatti di ispirazione “sudista”, a volte un po’ troppo piccanti per le abitudini e i gusti lombardi di Arrigoni. Con un leggero sovrapprezzo, era sempre la custode a occuparsi del bucato, ai tempi fatto a mano con sapone di Marsiglia essendo ancora una rarità le lavatrici, e della stiratura delle camicie.
Con queste premesse, si comprenderà come Arrigoni aspettasse con ansia l’arrivo del sabato, quando, se non c’erano gravi problemi di lavoro, prendeva il treno alla Stazione Nord di piazzale Cadorna e se ne filava nella verde Brianza, dove avrebbe in fretta dimenticato le solitudini milanesi.
Raramente c’era stato un periodo così calmo al commissariato Porta Venezia, che Mario Arrigoni dirigeva ormai da diversi anni. Risolto, nel mese di maggio, il brutto caso dell’omicidio di una prostituta, era subentrata una tranquilla e poco impegnativa routine. Tant’è vero che Arrigoni aveva autorizzato quindici giorni di ferie, in anticipo rispetto al periodo tradizionale, al suo vice Mas...