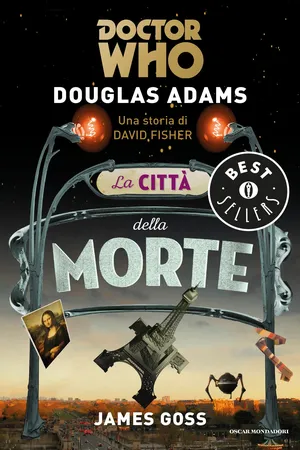Era martedì e la vita non era ancora cominciata. Mercoledì sarebbe stata tutta un’altra storia.
Scaroth, l’ultimo degli Jagaroth, stava per ricevere una sorpresa. Per cominciare, non immaginava che tra poco sarebbe diventato l’ultimo degli Jagaroth.
Se gli aveste chiesto degli Jagaroth appena, diciamo, venti soned prima, lui si sarebbe stretto nelle spalle e vi avrebbe risposto che erano una razza di feroci guerrieri, e che se non vi andava bene, avreste dovuto conoscere gli altri.
Nel contesto dell’universo, le razze di feroci guerrieri andavano per la maggiore. “Indicatemi una stirpe di poeti e filosofi” diceva Scaroth “e vi mostrerò il mio prossimo pranzo.” Sarebbe tuttavia ingiusto affermare che gli Jagaroth fossero completamente privi di talento. Costruivano astronavi davvero graziose, per quanto non necessariamente ben funzionanti. La Sephiroth presentava svariati aspetti degni di nota. Con la sua forma di sfera appoggiata su tre artigli, aveva un’aria terribilmente minacciosa pur ricordando il tipo d’insetto che non ci si fa troppi problemi a schiacciare se ce lo si trova tra le lenzuola. La disposizione delle zampe a treppiede mostrava che era in grado di atterrare su qualsiasi superficie.
Ironico, dato che in quel momento non poteva staccarsi da quella su cui si trovava. L’unità motore aveva subìto un guasto quasi subito dopo essere sbarcati in questa terra desolata. Stavano dando la caccia a un segnale di energia araknoide ed erano atterrati confidando in un’altra vittoria. L’ennesima.
Gli Jagaroth si erano votati allo sterminio. Non avrebbero lasciato altra traccia del proprio passaggio. Niente storia, né letteratura, né sculture. Come specie non avevano mai ottenuto alcun risultato all’infuori della cancellazione della vita.
Il problema consisteva nel fatto che ogni altro essere vivente dell’universo si fosse votato al medesimo obiettivo. E tutti avevano ottenuto un successo tale che non era rimasta più molta vita in giro. Gli Jagaroth erano tra gli ultimi ancora in circolazione, e non senza gravi perdite. Quando parlavano della loro temibile flotta militare, si riferivano perlopiù alla Sephiroth. O per meglio dire, si riferivano esclusivamente a essa.
Il che preoccupava Scaroth, il suo pilota, appartenente alla flotta militare degli Jagaroth. Astronavi graziose, sistemi di navigazione sinceramente mediocri, nomi poetici e, sì, una francamente folle ostinazione a proseguire.
Ecco il motivo per cui le voci dei suoi compagni di bordo riempivano la sua cabina di comando.
Era cominciato il conto alla rovescia. «Meno venti soned alla propulsione a curvatura.»
«Propulsione contro la superficie del pianeta innestata a forza tre.» Giù al reparto Ingegneria c’era qualcuno che proprio non vedeva l’ora di andarsene da lì.
«Negativo» replicò seccamente Scaroth. «La forza tre è troppo violenta.» Si ricorreva alla propulsione a curvatura per accelerare nei viaggi interstellari, non nei decolli. Nemmeno per andarsene da un pianeta morto dalla gravità ridotta e dall’atmosfera rarefatta. Troppo rischioso. Nessuno aveva mai provato a staccarsi dal suolo servendosi della propulsione a curvatura. «A forza tre è un suicidio.»
Come si aspettava, a queste parole le voci che lo incalzavano si zittirono di colpo.
«Attendo istruzioni» si limitò a dir loro.
La voce impaziente riprese la linea dal reparto Ingegneria. «Scaroth, forza tre. Fine della discussione.»
Il tipico rifugiarsi degli Jagaroth negli assoluti indiscutibili, pensò Scaroth con una smorfia di cinismo. Be’, per quanto potesse essere cinica l’espressione di un volto formato da una massa brulicante di tentacoli verdi intorno a un solo occhio.
In quanto pilota, era Scaroth il responsabile. Sarebbe stato lui a premere il bottone. Se di tutto ciò fosse rimasta traccia nella storia, la colpa sarebbe ricaduta su di lui. Sapeva che si trattava di una decisione stupida, ma del resto, da un punto di vista evoluzionistico, gli Jagaroth prendevano una grande quantità di decisioni alquanto stupide.
«Meno dieci soned alla propulsione a curvatura» lo incalzò il conto alla rovescia. Nella sua voce c’era forse una nota di disperazione?
Le mani verdi di Scaroth armeggiarono sul terminale. Se la Sephiroth avesse funzionato correttamente, i comandi di curvatura sarebbero stati un mucchio d’indicatori di stato che lui avrebbe saputo interpretare alla perfezione. Purtroppo, però, la gran parte dei pannelli lampeggiava richiedendo urgenti aggiornamenti software, o era spenta del tutto.
Doveva fare affidamento sui propri istinti e sulle indicazioni delle voci. E il resto dell’equipaggio sembrava ben lieto di lavarsene le mani.
«Attendo istruzioni!» ripeté, sperando di ricevere un consiglio sensato.
E invece si sentì rispondere stancamente: «Scaroth, la sorte degli Jagaroth è nelle tue mani. Senza motori ausiliari dobbiamo servirci per forza del propulsore a curvatura principale. Lo sai. È la nostra unica speranza. Tu sei la nostra unica speranza».
“Grazie tante” pensò Scaroth, con i tentacoli che adesso tremavano decisamente di cinismo. «E sono anche l’unico che si troverà nel bel mezzo del campo di curvatura!» Come a dire, il primo ad andarsene. «Conosco bene i rischi.» Questo era il massimo a cui uno Jagaroth si fosse mai spinto nel chiedere un ripensamento. Una volta che si mettevano in testa un’idea, per quanto ridicola o letale, gli Jagaroth andavano fino in fondo.
I suoi pensieri ricevettero conferma quando il conto alla rovescia riprese in un tono che gli parve decisamente vispo. Comunque fosse, stava per accadere qualcosa. «Meno tre soned... meno due... meno uno...» scandì la voce, quasi non sapesse che i giorni dei soned come unità di misura stavano per tramontare definitivamente.
Scaroth rischiò un ultimo tentativo. «Cosa succederà se...?» “Se tutto va storto? Se l’azione dell’atmosfera e della gravità combinata con la propulsione a curvatura determinerà un risultato imprevisto e orribile di cui sarò io il primo ad accorgermi?”
Ah, be’. Che senso aveva? Discutere con gli Jagaroth portava a una sola conclusione: la morte.
Scaroth premette il pulsante.
La Sephiroth si elevò maestosa da quella landa desolata alla massima potenza consentita dal motore. L’idea di trattenersi laggiù anche solo un altro minuto aveva riempito di sgomento l’equipaggio. “Perché restarcene su questo pianeta deserto a gingillarci con i lavori di riparazione quando potremmo andarcene altrove, magari a sterminare qualche altra specie?” I segnali erano incoraggianti. Una leggera fluttuazione determinata da una perdita di carburante parve sistemarsi da sé. La sfera si sollevò ripiegando ordinatamente le zampe simili ad artigli. Rimase a fluttuare per un istante, solenne e splendente di energia, come in attesa.
E poi esplose.
Nel bel mezzo del campo di curvatura Scaroth si accorse personalmente che a) la nave stava collassando e b) lui si stava stranamente allontanando dal mondo sensibile. Sembrava che non esistesse più nulla di certo all’infuori del dolore. E le voci degli Jagaroth che ancora riempivano la cabina di comando.
Sembrava che non si fossero minimamente resi conto di avere commesso un terribile sbaglio a ordinargli di premere il pulsante. Si aspettavano semplicemente che lui rimediasse al guaio.
«Aiutaci, Scaroth! Aiutaci!» lo supplicarono. Come se adesso potesse farci qualcosa. «Il destino degli Jagaroth è nelle tue mani! Aiutaci! Sei la nostra unica speranza!»
Le grida cessarono e, per un breve istante, a Scaroth fu concesso di godere della propria agonia in relativa tranquillità.
“Sono l’ultimo degli Jagaroth” pensò. “Finché dura.”
Per fortuna, il campo di curvatura alla fine collassò. I frammenti della nave, fino a quel momento stretti l’uno contro l’altro da forze incomprensibili, si sentirono liberi di tramutarsi in una luminosa nube rovente che si diffuse in lungo e in largo sulla superficie del pianeta morto.
Scaroth morì. E fu allora che accadde l’imprevisto.
“Così va bene” pensò Leonardo.
Come quasi tutti i capolavori, anche questo gli era venuto quasi senza accorgersene.
Un momento non esisteva e quello dopo invece sì, come facendosi largo a fatica tra le pile di fogli e i modellini penzolanti che ingombravano il suo studio.
Leonardo si abbandonò sulla sedia e scrutò il dipinto con il pennello ancora in mano, sospeso sopra il bordo della tavolozza. Senza appoggiarlo, osservò la propria opera. Davvero aveva finito? O serviva aggiungere qualcosa?
Finalmente distolse lo sguardo dalla tela. Lanciò un’occhiata all’ospite che russava nell’angolo, con gli stivali appoggiati al modellino della diga che aveva progettato per Machiavelli. Per qualche istante Leonardo rifletté sui consigli dell’ospite, senza dubbio offerti in buona fede, riguardo al volto nel ritratto.
Ma no, pensò. Avrebbe rimesso mano al dipinto, certo che sì. Ecco il suo problema: non riusciva mai a portare a termine nulla. Ma per il momento bastava così.
Lasciò cadere il pennello, mentre la frenesia creativa cedeva il passo a un brusco calo di tensione. E adesso?
Era la notte giusta per bere. Si versò un bicchiere di vino scadente e lo sorseggiò con cautela. Forse domani si sarebbe comprato qualcosa di meglio, ma probabilmente no. Dalle finestre ad arco osservò le stelle e la città acquattata ai loro piedi. Lasciò vagare lo sguardo tra le strade di Firenze. “Dio solo sa cosa se ne dirà in giro” pensò. Sapeva che l’indomani non si sarebbe parlato d’altro che del suo ultimo dipinto. Qualcuno l’avrebbe definito una delusione. Qualcun altro avrebbe sentenziato che era arrivato il momento che smettesse di dividersi tra pittura e invenzioni. E di certo non sarebbe mancato chi avrebbe parlato di “un trionfale ritorno alla forma”.
Ah, dicessero un po’ quel che volevano. Lui era soddisfatto. Più o meno.
Il suo ospite si mosse nel sonno, e Leonardo tornò a interrogarsi sul volto del ritratto.
No, doveva lasciarlo così, per il momento.
Dondolò sulla sedia, assaporando il vino per quanto possibile mentre contemplava il dipinto. Era stata una sfida, e sebbene lui non si sentisse ancora arrivato alla fine, poteva ben dire che ne fosse valsa la pena.
E grazie a Dio non avrebbe dovuto rifarlo.
William Shakespeare stava barando a croquet. Il suo ospite ci rimase male e, mentre il Bardo non guardava, con un colpo leggero avvicinò la propria palla all’archetto. Alzò gli occhi. Be’, che gli prendesse un colpo se William non aveva fatto lo stesso. I due si sorrisero educatamente.
«Ah, i clienti!» esclamò Shakespeare cambiando argomento.
L’ospite annuì con una risatina.
«Ne ho uno proprio impaziente» proseguì il Bardo. «Ieri sera gli ho passato un po’ di roba nuova. Di solito basta a tenerli a bada per qualche settimana, e invece questo ha promesso che tornerà per la fine di questa settimana. E così devo dargli altro materiale.» Inclinò la stecca e mandò la palla a rimbalzare allegramente sul prato, evitando con abilità la sciarpa del visitatore che inspiegabilmente strisciava lungo la traiettoria. La palla superò senza difficoltà un archetto e andò a sbattere contro il paletto. Shakespeare sorrise compiaciuto.
«Oh, bel tiro» si congratulò l’ospite con falsa cortesia.
«Mi ha fatto molti complimenti per un verso di cui sono proprio soddisfatto.» Shakespeare si interruppe, sia per fare una pausa a effetto che per indurre l’ospite a sbagliare il tiro. «Ah, sì» dichiarò con una spontaneità artefatta che spiegava il motivo per cui aveva smesso di recitare. «“Potrei vivere nel guscio di una noce e credermi re d’uno spazio infinito, se non fosse per certi cattivi sogni.” Sì, era quello. Ha detto che lo ha colpito, e che non vede l’ora di sapere come va a finire. Bah! Chissà quali elevati pensieri turbano i sonni di uno così, eh? Oh, che peccato» concluse quando l’ospite mancò completamente la palla.
Senza più pensare ai sonni agitati del cliente, Shakespeare continuò a giocare fino a vincere la partita.
Si dice che i nazisti amassero l’arte quanto le barzellette. Curiosamente, però, non appena irruppero a Parigi riempirono le proprie lussuose suite d’albergo di tutte le opere d’arte su cui riuscirono a mettere mano. Quando furono costretti a sloggiare, il lor...