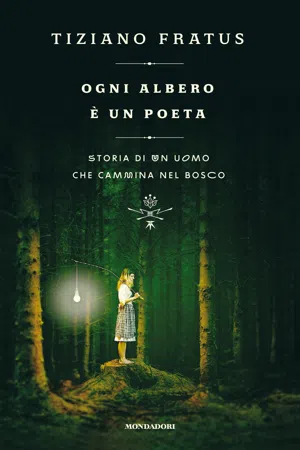![]()
![]()
Anche il Silvano che delimita i miei spazi e le mie parentesi ha imparato che l’ora del tramonto apre le porte di un continente che resiste per pochi minuti. Un magnete delle malinconie e delle epifanie che l’umanità ha accantonato, da quando centomila anni fa ha iniziato a guardare in lontananza, e ha mosso i primi passi per procedere, per conoscere, per capire o tentare di. Ci sono giorni in cui aspetti l’arrivo del tramonto come si attende d’incontrare un vecchio amico che non vedi da anni. La calma oceanica che si manifesta sopra e intorno alle nostre piccole anime piene di spilli. Magari sei seduto a terra, sul prato, a gambe storte, gli ultimi raggi di sole gettati oltre le colline, la testa inclinata mentre fai all’amore coi capelli che attraversi con un pugno che preme contro la nuca. Note appena pizzicate di chitarra classica. Lo senti così quel tramonto che si disegna in sospensione, quasi a occhi chiusi. Un momento di immensa calma, onde che si allungano senza produrre rumore e ti dilavano dentro. Ti placano. Ti riscaldano. Ti godi la distanza, se spalanchi gli occhi davanti a una foresta di pini stanchi e contorti, l’ultimo segno di civiltà ristora a qualche chilometro a valle. Accarezzi una corteccia spezzata, il cielo si colora come una volta di Giotto, di quel blu lapislazzulo che rasenta la perfezione cromatica. Il volo di una nocciolaia aggiunge moto visivo a un pezzo di preistoria forgiata nei colori del tramonto. Le prime stelle baluginano a intermittenza. Scolpisci il tuo cuore d’alabastro ogni giorno, lo accarezzi la mattina appena alzato e la sera prima di coricarti. Lo senti finalmente nel petto in istanti come questi, quando la notte inizia a impietrirsi e a rigenerarsi nelle ombre minuscole degli alberi, a fermentare sotto le pietre e dentro le grotte. Quelle stesse grotte nelle quali i nostri antenati hanno rappresentato scene di caccia, animali estinti, uomini e donne e bambini e anziani intenti a vivere. Speri sempre in un miracolo, anche se in molti ti ripetono che la scorta è terminata da tempo. È ora di tuffarti.
![]()
Se immaginiamo di risvegliarci libellula e di volare in un cielo carta da zucchero, col vento che ci sbalestra e le ali che svirgolano per riacquistare equilibrio, il sole ci acceca risalendo da oriente e noi viriamo dalla parte opposta, percependo il tepore che ci riscalda la coda; schiviamo un trio di calabroni, scendiamo nel mare verde che si apre sotto di noi, le onde di spighe e d’erba fluiscono in maree granulari e ci piace tanto sbattere le ali al massimo mentre sotto il paesaggio sfuoca. Ne sentiamo l’attrazione richiamati all’ordine dalla forza di gravità ma la nostra volontà e il senso d’avventura ci impongono di proseguire a sfrecciare. Sfiniti ma appagati ci posiamo su un sasso. Una goccia d’acqua ci cola sulle antenne e sui nostri occhi fucsia. Un ruscello che scorre. L’acqua che risplende. Il mormorio in sottofondo. Giriamo le grandi lenti verso il muso appisolato d’un rospo che improvvisamente spalanca gli occhi e ci inghiotte.
Il bosco è il grande divoratore. Le guerre si combattono spesso da un di fuori che penetra a fondo negli spazi di luce e vita, è la notte che arriva e ingloba ogni cosa. Chiunque fra i lettori abbia avuto modo di trovarsi nel folto del bosco mentre la sera trasforma il cielo limpido e infuocato in un buio indistinguibile, avrà assaporato l’intera gradazione spaventevole che trascina ogni cosa visibile e distinguibile in un’unica mappa senza distanze e senza confini. La notte salta fuori dalle radici degli alberi, cala dalla cima delle fronde, germina sotto le foglie, nei botri e negli orridi. Il verde degrada in nero e in mezz’ora satura ogni spazio. Le uniche luci possono arrivare da un cielo sbiancato dalla luna, dalle scogliere d’una montagna che riflettono il bagliore proveniente all’orizzonte, dalle acque correnti d’un torrente che sfavilla nel silenzio circostante. Il rumore è parte dell’immagine che siamo pronti a riconoscere, il suono preannuncia lo sguardo. Per chi almeno vede e sente. Camminare nel buio allerta le cartilagini e spalanca gli occhi nelle gambe. Non si pensa più col cervello, è il corpo che ci guida in salvo, che ci trascina lungo traiettorie di cui ha memoria.
Antonio Moresco è una montagna. In un libro minuto intitolato La lucina (2013) lo scrittore mantovano tratteggia un soggetto-alter ego che si rifugia per un periodo in un bosco fra i monti. Qui, la notte, si trova lungo una strada e ammira la cattiveria del bosco: “Perché c’è tutto questo sottobosco cattivo? Mi domando. Che cerca di avviluppare e di cancellare e di soffocare gli alberi più grandi? Perché tutta questa miseria e disperata ferocia che sfigura ogni cosa? Perché tutto questo brulicare di corpi che cercano di prosciugare gli altri corpi suggendoli con le loro mille e mille scatenate radici e le loro piccole, forsennate ventose, per dirottarne su di sé la potenza chimica, per creare nuovi fronti vegetali in grado di annientare tutto, di massacrare tutto?”. È così, a virare lo sguardo, a scartare la realtà nella quale siamo immersi fino al collo, e oltre, anche nelle nostre città. È così nella nostra professione, quella di coloro che per arrivare a fine mese in qualche misura si occupano di scrivere e pubblicare, ma si può dire senz’altro meglio. Anche noi, non dico tutti, ma molti degli scrittori “cercano di prosciugare gli altri corpi suggendoli con le loro mille e mille scatenate radici e le loro piccole, forsennate ventose, per dirottarne su di sé la potenza chimica”. Gli alberi, la natura lasciata a se stessa, e anche noi, consumiamo, vampirizziamo, suggiamo. È la nostra natura. Ci nutriamo d’altro. E ci piace.
![]()
La foresta non fa che aumentare di volume e di massa. Nonostante le forze contrapposte che vi agiscono l’espansione è l’unica direzione possibile. A riprova che anche gli alberi “camminano”. Non è rara la rappresentazione grafica della vita con le terminazioni nervose di un cervello: radici che spingono nuova vita in diverse direzioni. Così come una foresta, o un singolo albero, allunga le radici nella terra e i rami nell’aria, così un cervello, o meglio, l’immaginazione di un uomo, può generare sempre nuovi mondi e nuove declinazioni di realtà. È quel che chiamiamo arte, letteratura, poesia. Mi chiedo da dove sia scaturita tutta quella materia di immagini, questa calcografia intima che ha riempito decine e decine di quaderni, di taccuini, di moleskine, ed è confluita, tramite inchiostro a stampa, nei libri che portano il mio nome. Non ricordo più chi l’abbia detto ma trovo incoraggiante che per quanti mondi vasti esistano intorno a noi, ne esistano altrettanti possibili e complessi dentro di noi. Pensiamo alla geografia che continuiamo a immaginare a due dimensioni, a raffigurare – cartine, mappe, navigatori – come in un disegno, tuttavia colorato, da terza elementare, o alla storia, che è un tentativo di mettere in ordine gli eventi salienti che riguardano una minima parte delle persone che abitano quei Paesi, quelle aree geografiche. Quanta gente al tempo ignorava l’importanza di quel che accadde a Waterloo? I grandi eventi della storia sono sempre stati percepiti a distanza, tranne nell’ultimo secolo che abbiamo alle spalle, oramai innervato e mutato dalle reti comunicative globali – radio e telegrafo prima, televisione e internet ora. Alla galassia spirale barrata che ci gira intorno ne corrisponde una elicoidale in rotazione perpetua dentro ciascuno dei sette miliardi di umani attualmente e contemporaneamente viventi sul pianeta. Sette miliardi di individui che proprio come chi scrive e pensa e proprio come chi legge e riflette, esistono. In questo istante. Sette miliardi di palpebre che sbattono, sette miliardi di respiri gonfiati ed emessi. Tutti insieme spinti verso mete scontate e necessarie: l’appagamento, la felicità, la gioia, il piacere. Ma dove termina questa energia “oscura” – poiché invisibile, perché si rigenera in modi che non comprendiamo, ora c’è e poi non c’è più – quando ci spegniamo? È una domanda che mi pongo ogni qual volta attraversi un bosco. Quando i nostri corpi si cristallizzano e diventano legna da ardere dove finiamo? Dove si convoglia la fonte di energia che ci alimenta per venti, cinquanta o cent’anni? Mi basta osservare una foresta nella luce dorata del tramonto o nei riflessi stellari di una notte di luna piena per sentirmi certo che sia impossibile che tutto questo mondo in rotazione interna si possa zittire e basta. Non lo posso credere. In natura ogni minima particella si trasforma in altro. L’evoluzione è trasformismo.
![]()
Nella mia biblioteca da cercatore di alberi secolari ho libri che descrivono il susseguirsi di pensieri, ricordi, citazioni e sensazioni che sono stati catturati su carta da scrittori, poeti, naturalisti e viaggiatori. Elogio della quiete e Diario di Saga del poeta giapponese Bashō – che significa banano, accanto a una delle baracche nelle quali ha vissuto ne cresceva una pianta –, il padre di una forma di poesia attualmente molto popolare, l’haiku. Camminare (Walking) di Enrico Davide Thoreau, un americano che aveva vissuto per due anni in una capanna negli Stati Uniti. La foresta di Fontainebleau di Giorgia Sand, viaggiatrice e scrittrice parigina del XIX secolo. Le passeggiate del sognatore solitario di Gian Giacomo Rousseau, il grande donnaiolo di Francia. La passeggiata (Der Spaziergang) di Roberto Walser, poeta e narratore svizzero del primo Novecento. Piccoli libri minuti e che qualcuno aveva usato prima, con alcune note a penna o a matita sui margini, qualche parola sottolineata, alcune orecchie alle pagine. Materia imbottigliata e fermentata, ossidata come il vino che prende corpo e struttura maturando.
Affinando lo sguardo provo a discendere nel girone magmatico riservato alla poesia americana dello scorso secolo: c’è un poeta che, per me, occupa un posto di particolare affetto. Non è un nome noto, nemmeno fra i cultori della letteratura a stelle e strisce. Si chiamava Tommaso McGrath, stesso cognome di uno scrittore molto conosciuto, inglese, Patrizio McGrath. Quest’ultimo ha scritto romanzi intensi, quali Il morbo di Haggard, Follia e Grottesco. Thomas invece ha lavorato per trent’anni a un unico immenso poema, suddiviso in quattro parti, che ha iniziato a pubblicare nel 1963. L’edizione finale, quella che conservo nella mia modesta biblioteca da Uomo Radice, è pubblicata dalla Copper Canyon Press, eccelso editore di poesia americana, nel 1997. Titolo: Letter to an Imaginary Friend, Lettera a un amico immaginario. Forse l’intera mia produzione poetica e narrativa è indirizzata allo stesso lettore immaginario tratteggiato da McGrath. Custodisco una vera passione per i poemi immensi, foreste di migliaia e migliaia di versi, immagini, onomatopee e ipotesi di mondo. Penso ad esempio al romanzo in versi in cinque libri Freddy Nettuno dell’australiano Les Murray o al titanico Omeros di Derek Walcott, premio Nobel per la letteratura nel 1994.
La bellezza di queste opere è che sono senza confine, chi le scrive ha impiegato il tempo della vita per lottarci contro, dimenticando o smarrendo inconsapevolmente il confine fra vita e opera. Le due parole si sono sovrapposte e scisse, hanno germinato nuovi continenti d’inchiostro nei quali sbucano scoiattoli che smangiano i bordi alle pagine. McGrath Tommaso è nato nel 1916, un secolo fa, in Nord Dakota, ha vissuto e scritto per anni nella periferia di Los Angeles ed è morto nel 1990 a Minneapolis, la città dei ponti sul Mississippi, senza vedere la pubblicazione completa della sua opera. Da uno di quei ponti, il Washington Avenue Bridge, si era suicidato uno dei massimi poeti americani della sua epoca, Giovanni Berryman, il 7 gennaio 1972. Non ero ancora stato concepito.
Nella seconda parte del suo poema McGrath registra i pensieri che macina mentre è intento a spaccare la legna. Si tratta di accumuli, di immagini, di visioni, e poi a un tratto la cruda realtà entra nella pagina:
Thump
Dacci le notizie quotidiane
Scritte col sangue sopra i miei pantaloni: troppo tardi per
[la stampa
[...] Scava le tombe.
Thump
[...] Thump
Thump
Il suono dell’ascia nell’albero...
[...] Taglio il legno.
Gli alberi esplodono intorno a me...
dinamite segreta
[...] Taglio il legno.
Sognando di questo.
Questa pagina...
![]()
Cos’è questo mondo capovolto che si trascina contro il nostro sguardo e si è sostituito al cielo alto? Dove è finito lo scheletro della luna? Dove sono le rondini che sfrecciano tirando fili sottili sopra i campi e le cime dei boschi? Un fronte compatto di gobbe e aperture negate si orienta da nord a sud, decalitri e decalitri di acqua che transitano sopra di noi senza che ne possiamo sfruttare l’energia. Ogni tanto si divertono ad assumere forme che noi riconosciamo per qualche secondo, prima che il mutamento le trasfiguri nuovamente. Un elefante con la proboscide. Un’oca che sbatte le ali. Un anello di fumo di sigaretta. Un cuore. Un polmone. Un fegato. Un intestino. Una nave infuocata al tramonto. Avvolti e protetti da Madre Foresta non ci accorgiamo più di tanto della sostituzione, certo il sole non ci può raggiungere improvvisamente alla base degli alberi, non ci dobbiamo riparare con la mano da un raggio impertinente. Eppure il movimento non è garantito dall’oscillazione delle cime degli alberi, ma da quel pezzo di mondo capovolto che si trascina lì sopra. Lo guardiamo di rado ma quando lo facciamo coviamo il sospetto. Che vorrà dire?
La poesia ha bisogno di silenzio. Non è vero che il poeta ha l’imperativo categorico di transitare in televisione per esistere, o presenziare a qualsiasi festival. Non sta scritto che sei poeta se i tuoi piccoli minuscoli versi vengono elogiati su una rivista, tradotti in inglese o inseriti nelle liste da annuario. Proprio perché la poesia è un corpo chiuso e ben vigilato da coloro che la sanno molto lunga il poeta non deve temere il silenzio: è la sua patria. Questa è una delle leggi basilari che l’uomo che si immerge nella natura va a comporre, segno dopo segno, passo dopo passo. Noi uomini ci inganniamo continuamente: sulla nostra rilevanza, sulle nostre capacità e sulla portata eventualmente generale di quel che andiamo pensando, dicendo o facendo. La natura ci ignora, anche se ne abbiamo bisogno. Una volpe ci vede mentre corre e spera di non incontrare la pallottola d’un fucile. Ce la portiamo dietro anche per mezzo secolo, per tutta la vita, quella fugace impressione sbocciata dall’incontro, ma loro, gli animali, i selvatici, ci evitano e non conservano memoria. Il mondo animale vive ogni giorno come se fosse il primo o l’ultimo, non c’è differenza. Noi umani vorremmo ma non riusciamo. Anche se siamo poeti.
![]()
L’azione e la location sono queste: salire e scendere una m...