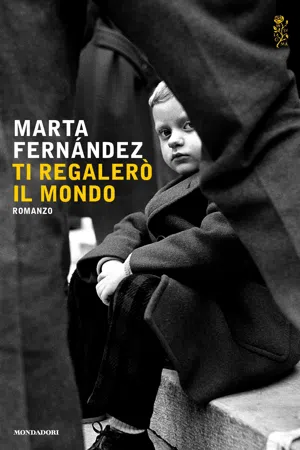Nella cella in fondo c’è un uomo che non sa di essere pazzo. Da anni ripete che è innocente. Che non ha ucciso nessuno. Da anni è incatenato ai suoi ceppi e al suo dolore, ma gli pare che non sia trascorso neanche un giorno dal momento in cui è accaduto tutto. Perché in manicomio il tempo non esiste. L’uomo non sa quando è arrivato in questo luogo, dove il passato si limita a ieri e il futuro è inconcepibile. Non se lo domanda neppure.
Sei anni fa il maestro Rossum fu trasferito nell’istituto con altri quarantatré poveri pazzi atterriti. Gli avevano promesso che da qui avrebbe visto in lontananza le cupole del monastero di Mafra. Ma l’unica cosa che vide fu lo sguardo allibito dei contadini appostati sulla porta dell’edificio, per capire se i nuovi arrivati fossero umani o bestie. Migliaia di occhi indagatori, che la paura rendeva enormi, di fronte alla sfilata della follia. Fra i quarantaquattro dementi coperti di stracci, pieni di lividi, famelici, segnati dalla vita e dalla follia, c’era un uomo che in altri tempi era stato uno scienziato di grande fama. Rossum guardava i contadini fermi sulla strada che porta al manicomio come fossero bestie rare. Non si rendeva conto che adesso la bestia rara era lui. Non sapeva di essere pazzo come i pazzi che lo circondavano. Era ancora convinto di essere rinchiuso per un delitto che non aveva commesso. E in qualche modo è davvero così. Le autorità erano giunte alla conclusione che un uomo saggio come lui avrebbe potuto fare ciò che aveva fatto soltanto in preda a un insano delirio. E lo avevano rinchiuso in una Casa di Misericordia, dove persino l’aria era immisericordiosa.
Dalla cella in fondo al corridoio non vedeva il monastero della sua gioventù, e non riusciva a guardare liberamente dalla finestra, poco più di una fessura nella parte alta della parete che schermava il sole. Dapprincipio le catene gli avevano impedito di alzarsi. Ma quando erano finalmente finiti i bagni d’acqua gelida e le sue mani erano state sganciate dagli anelli di ferro, l’uomo aveva esaurito le forze necessarie per reggersi in piedi e affacciarsi alla finestrella. Non valeva la pena sopportare il dolore che provava alzandosi. Rossum, alto un metro e ottanta, passava le giornate raggomitolato, con la vecchia spina dorsale inarcata. La testa eccelsa nascosta tra le ginocchia. Le parole confuse in un balbettio delirante.
Me l’ha portata via. Me l’ha portata via. Me l’ha portata via. Mi ha portato via tutto. Tutto. Tutto. Che possa bruciare all’inferno. Tutto. Non esiste inferno come il mio. Il mio… In… Fer… No. No… Me l’ha portata via. Rossum si aggrovigliava nella sua litania inutile. La sua voce era un ronzio intrappolato fra le rotule. Le parole risuonavano così lontane, flebili, dolcemente stonate, da non infastidire più i guardiani. Il maestro Rossum era un pazzo ripetitivo, ossessivo, preciso come una formula. Era esattamente uguale a quando era stato lucido: metodico come la sua scienza.
Sembrava impossibile che un tempo la sua mente fosse tra le più brillanti dell’epoca. Nessuno avrebbe mai detto che la Regina Maria Anna d’Asburgo lo avesse fatto venire da un luogo lontano dell’Europa centrale per educare il figlio, l’erede al trono del Portogallo. Rossum giunse nella Lisbona faraonica dell’oro brasiliano, delle promesse di grandezza e della miseria assolutista. La sua precisa mente matematica si smarriva nel dedalo assurdo di vie che solo un terremoto avrebbe potuto raddrizzare. In quella città che pareva costruita intorno a conventi e distrutta a furia di contese, il maestro soleva domandarsi se fossero più numerosi i religiosi o i peccatori. Che cos’era Lisbona, annerita dalle tonache, dalla sporcizia e dall’ombra del peccato? Sodoma, Gomorra o la nuova Gerusalemme? Rossum passeggiava con stupore per le stradine labirintiche, sino a quando restava come ipnotizzato di fronte alle acque del porto, inebriato dall’odore pestilenziale e dal vociare in mille lingue che tentava di riconoscere. Ma il maestro era stato chiamato in quel regno non suo per compiere una missione: educare l’Infante Giuseppe, un bambino dal mento pronunciato e le palpebre cascanti, come se a dieci anni avesse già inventato la malinconia. La cosa che preferisco al mondo, signore, è la musica. La piccola bocca aveva pronunciato quelle parole con un accento tedesco quasi perfetto. Nonostante la fredda solennità dell’affermazione, Rossum era convinto che le parole del bambino nascondessero una certa passione.
Il compito affidatogli dalla Regina non si rivelò facile. L’Infante era un bambino distratto e distante, poco interessato all’apprendimento. Rossum scrutava i suoi occhi neri, cercando di intravedere la scintilla della comprensione. Ma lo sguardo del bambino era un frammento perfetto di vuoto. Tranne quando vedeva la madre o la sorella sedute davanti alle tastiere dei clavicordi olandesi. L’eco delle note pareva risvegliare l’Infante. Perciò il maestro decise di spiegargli il mondo come se fosse un pentagramma, nel quale le leggi della natura si rivelavano secondo la logica dell’armonia, e le note erano numeri che costituivano la melodia della ragione. E il piccolo Principe, destinato a ereditare il trono, l’oro, il mare e la terra, alzò lo sguardo e fissò Rossum come se cominciasse a capire. Qualcosa era cambiato in quel bambino taciturno e rigido. La Regina, orgogliosa del suo nuovo acquisto europeo, era certa che Rossum sarebbe riuscito nell’impresa. In cambio, Maria Anna d’Asburgo concedeva al maestro tutto ciò che gli occorreva per le sue ricerche. Non sapeva che finanziando il suo laboratorio contribuiva all’unico regno in cui suo figlio si sentiva felice.
La specialità di Rossum era la meccanica. Aveva cominciato a guadagnarsi da vivere come orologiaio a Liegi, ma la sua mente inquieta di scienziato si rifiutava di girare intorno a un’unica ruota dentata. Voleva studiare, scoprire, inventare. E fu ciò che fece a Lisbona, oltre a occuparsi di educare il futuro Re. Rapito dalle potenzialità del magnetismo, organizzò un laboratorio che era il rifugio di un mago con mille segreti da svelare. Il rifugio nel quale l’Infante Giuseppe amava rintanarsi. Arrivava pieno di impazienza, si sedeva e guardava. E Rossum gli permetteva di osservare. Quando parlava con quel bambino taciturno, gli pareva di conversare con il proprio cervello. I lampi descritti da Plinio e di cui ti ho già parlato si formano così, diceva, e intanto muoveva una strana conocchia che faceva girare una piccola sfera. E un fulmine, come quello di Plinio, si sprigionava nell’aria inerte. Il maestro definiva quel fenomeno elettricità.
In quel gabinetto delle meraviglie, dove giocava con magneti che mettevano alla prova la sua forza, sfidava a braccio di ferro pistoni invincibili, ricostruiva rompicapo fatti di lancette, l’erede poteva finalmente essere un bambino. Là dentro era solo Giuseppe. Giuseppe di dieci anni, con gli occhi luccicanti. Giuseppe che comprendeva il mondo e scopriva l’affetto. Giuseppe che dimostrava il suo amore per la scienza, la sua capacità di interrogarsi e di interrogare. Come fanno i vostri orologi a sapere che il giorno ha ventiquattro ore? E chi ha stabilito la durata dei giorni? E la lingua degli uomini? Perché alcuni parlano in portoghese, altri in francese e altri in tedesco? Perché voi capite tutte le lingue? Un giorno le capirò anch’io. Un giorno viaggerò e vedrò le mappe che si fanno realtà.
«Signore, potete spiegarmi ancora come funziona la bussola, e come fanno i cartografi reali a sapere che la costa è tale e quale la disegnano? A volte immagino che vedano come i gabbiani. Dall’alto.»
«Forse scoprono la verità dove gli altri non riescono a vederla» osserva il maestro.
Il bambino ha una risposta per quell’affermazione. È quello che fate voi.
A volte Barbara, la sorella maggiore dell’Infante, si univa ai giochi nel laboratorio. Il maestro Rossum era turbato dalla bruttezza della bambina, risoluta e sicura come un’adulta, i lineamenti flaccidi e gli occhi minuscoli, infossati nelle guance paffute. Ma in quegli occhi, così piccoli da non riuscire a indovinarne il colore, brillava una vita che non si sarebbe mai affacciata in quelli del piccolo Giuseppe. Guardandola, Rossum scoprì un’intelligenza che conferiva all’Infanta una bellezza particolare, una forza indefinibile. Barbara veniva a trovarli tutti i giorni prima delle lezioni di musica. Le sue mani grassocce divenivano leggere sul clavicordo. Si capiva perché fosse così amata dal suo maestro italiano, che ne elogiava di continuo il talento per la composizione. Quando i domestici la chiamavano per condurla alle lezioni di armonia, sembrava che qualcosa si spegnesse nel futuro Re, nel bambino che guardava di continuo le tastiere, e che Rossum non aveva mai visto suonare. L’istitutrice del piccolo finì per confessare al maestro ciò che l’Infante tentava di tenere segreto: le sue dita fragili sembravano non rispondere agli ordini del cervello. L’Infante era incapace di suonare una partitura, incespicava, si perdeva, capiva le note, ma i muscoli delle sue mani si rifiutavano di obbedire. L’impossibilità di fare una cosa che desiderava moltissimo era talmente dolorosa che Giuseppe aveva chiesto alla madre di non lasciarlo suonare mai più.
Rossum fu commosso dal primo fallimento del bambino che un giorno avrebbe avuto tutto, ma che a dieci anni voleva soltanto imparare a suonare. Il maestro inventore decise di regalare al suo allievo la possibilità di trasformare in musica i movimenti goffi delle sue dita sulla tastiera.
Il puntatore di Rossum era un congegno prodigioso. Il maestro lo aveva concepito una notte, tra il sonno e la veglia, dopo aver passato il pomeriggio a guardare l’Infanta Barbara che suonava estasiata con il suo maestro italiano. Per lei era semplicissimo ciò che per il povero Giuseppe sembrava impossibile… Le mani paffute della sorella si muovono come se fossero azionate da un’energia invisibile. Scendono e danzano passando dalle note più gravi a quelle più acute senza che i suoi occhi si spostino dalla partitura. Rossum, meravigliato dal talento naturale della bambina, fantastica pensando a una macchina capace di guidare il peggiore degli interpreti, l’Infante Giuseppe. Riesce quasi a vederlo trasformato in una marionetta, le falangi appese a fili che non permettono errore. Il mattino successivo, come se l’invenzione gli fosse stata rivelata, Rossum disegna con precisione il progetto del congegno che darà all’Infante la felicità. Una settimana dopo il maestro mostra all’allievo la sua opera. Il puntatore.
L’Infante guarda il marchingegno con aria confusa. Non immagina a che cosa possa servire quell’arnese che ricorda il meccanismo di un carillon gigantesco. Riconosce soltanto un rullo dentato. Gli pare una copia immensa del meccanismo racchiuso in un giocattolo musicale. Ma i carillon che sua madre gli ha portato dalla Francia azionano una serie di percussori che riproducono la melodia. Qui il rullo muove un certo numero di serie di stecche snodate, sottili, che si elevano sopra un baldacchino sospeso e poi scendono, libere. Sembra un telaio sopraelevato, formato da spessi fili metallici. All’estremità opposta rispetto al rullo dentato, Rossum ha collocato uno dei clavicordi di palazzo. L’Infante si domanda a che gioco intenda giocare il maestro quando lo invita a sedersi.
«Signore, anche se amo la musica, o proprio per questo, non suonerò.»
«Suonerete, eccellenza» dice il maestro. «So che non volete fallire, ma con questo strumento persino io riesco a strappare musica a quei tasti.»
Prima che il bambino reagisca, Rossum è di fronte al clavicordo, sotto l’incredibile struttura dorata che darà alle sue dita un impulso meccanico più preciso dell’ispirazione. La partitura non c’è. Non ce n’è bisogno. Basta infilare le dita dentro i dieci anelli posti alle estremità delle stecche.
«Eccellenza, potete azionare la manovella che muove il rullo? Non abbiate paura, fate conto che sia un normale carillon…» Rossum si gira verso il Principe bambino, con le falangi che fluttuano nei dieci anelli che ha messo alle estremità delle stecche del puntatore.
L’Infante è dubbioso. Si avvicina lentamente e fa girare il meccanismo. Il rullo muove la struttura, portando le dita di Rossum sulla tastiera con una delicatezza virtuosistica. Il maestro suona il clavicordo, arte che non ha mai appreso. Il bambino lo guarda meravigliato e scettico: testimone di un miracolo laico, desidera soltanto che l’incantesimo funzioni anche per lui. Il suo sguardo vuoto si è riempito di aspettativa. Di paura. Di qualcosa che assomiglia a una speranza vagamente terrorizzata. I suoi occhi brillano, timorosi, mentre il maestro lo invita a sedersi sullo sgabello di fronte allo strumento. Quando gli prende le mani per infilarle negli anelli magici, Rossum sente il tremito e lo sconcerto, la fascinazione di qualcuno che a dieci anni spezzerà un incantesimo. E lo lascia lì, seduto di fronte alla tastiera, con gli occhi che cercano una partitura che non gli servirà, con le manine leggermente sollevate come quelle di un prestigiatore che sta per fare una magia. Ma la magia è di Rossum, che sta per realizzarla con un colpo di manovella. Prima di farlo, il maestro vuole officiare il rito, renderlo sacro attraverso un’enunciazione solenne. Sua eccellenza, l’Infante Giuseppe, al clavicordo, interpreta la sarabanda della Suite in la maggiore del maestro Dieterich Buxtehude.
Quando Rossum aziona la manovella accade l’impossibile: il bambino suona senza commettere errori, le sue dita sono rese sapienti dalle stecche, come se gli angeli guidassero le sue mani canticchiando la musica celestiale. Rossum crede di intravedere anche un certo piacere nell’esecuzione. Lamenta un unico difetto del suo congegno: dal punto in cui si trova, dietro il telaio, non può vedere il volto dell’Infante. Ma sa con certezza che è il ritratto della felicità.
Quando il pezzo termina, il silenzio che viene dopo la musica è più profondo del primo silenzio del mondo. È il Nulla pregno del Tutto che segue alla perfezione. Giuseppe, ammutolito, disarmato, immobile, scoppia a piangere. Senza sfilare le dita dalla meccanica sapiente di quegli anelli rimane impietrito con le sue lacrime. Rossum si inginocchia davanti a lui, come nella sua vita di Re onnipotente non farà più nessuno. L’uomo che ha appena fatto avverare il suo sogno deve consolarlo. Lo abbraccia come può averlo abbracciato soltanto la sua istitutrice. E in quel momento Rossum, a poco più di vent’anni, si sente padre per la prima volta. Vuole consolare quel piccolo corpo sussultante ancora attraversato dal vibrato delle note, quel fascio di singhiozzi. E quando finalmente il tremito cessa, gli occhi del bambino si accendono di mille dubbi che quasi non osa formulare.
«Maestro, come è possibile? Potrò suonare di nuovo?»
«Certo che potrete. Avete suonato benissimo, altezza. Vi siete lasciato condurre dal puntatore con una calma ammirevole. Sono sicuro che imparerete molto in fretta».
L’Infante è perplesso. Imparare?
«Il puntatore serve a questo. Non è finali...