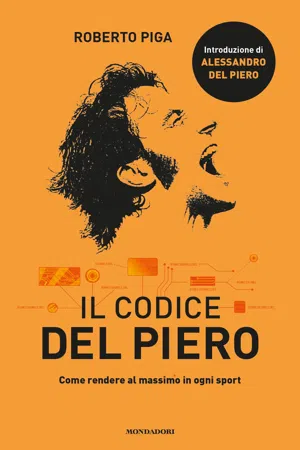Di Alessandro Del Piero ho conosciuto prima di tutto i dati fisiologici, quelli che determinano l’efficienza della complessa macchina che è il corpo umano, nella quale i sistemi neuromuscolari si intrecciano e si coniugano ordinatamente per dare forma al prototipo del campione. Mi sentivo un po’ come Robert Redford nei panni di analista della CIA nel film I tre giorni del Condor di Sydney Pollack (1975): dovevo esaminare e interpretare un’immensa mole di dati, i risultati dei test somministrati ai calciatori che il professor Giampiero Ventrone, allora responsabile della preparazione fisica della Juventus, mi spediva regolarmente ogni settimana.
Ho iniziato a collaborare con la squadra bianconera nel 1998. A quel tempo il mio compito consisteva nel fornire le indicazioni specifiche perché ogni atleta fosse in grado di realizzare la miglior prestazione durante l’attività agonistica. Avevamo stabilito che il metodo, perché fosse il più oggettivo possibile, non prevedesse che vedessi di persona i calciatori né le partite che giocavano. Attraverso la pura analisi numerica, non influenzata dagli aspetti tecnici e tattici riscontrati in campo, dovevo fornire indicazioni sullo stato psicologico e fisico dei vari calciatori.
Perciò mi trovai davanti a qualcosa come 120 dati numerici per ciascun atleta, la cui identità fisica e motoria mi si presentava in forma apparentemente disordinata e priva di senso, come un insieme di tessere di un puzzle. Quando esaminavo Alessandro Del Piero, ogni numero si rivelava stranamente compatibile con altri. L’analisi veniva svolta su diversi aspetti, dal piano biomeccanico, dinamico e funzionale, a quello mentale e della coordinazione e, non ultimo, a quello delle variazioni della composizione corporea. Avevo l’impressione, rimanendo nel paragone con il puzzle, che le tessere fossero dotate di un certo particolare “magnetismo”. Infatti, si collegavano le une alle altre in modo automatico, risparmiandomi il consueto provare e riprovare alla ricerca degli incastri giusti.
Ricordo che contrassegnavo ogni scheda dei calciatori con asterischi, per dare un’idea a chi leggeva la diagnosi del valore di ciascun parametro. I compagni di squadra di Del Piero, per citarne alcuni di quegli anni, Edgar Davids, Ciro Ferrara, Antonio Conte, Zinédine Zidane, Filippo Inzaghi, Didier Deschamps, Pavel Nedvěd, Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Gianluca Pessotto, David Trezeguet, Paolo Montero, Edwin van der Sar, Thierry Henry, collezionavano 2 o 3 o 4 asterischi su determinati valori e in determinati periodi. Del Piero, quasi sempre, sommava 6 asterischi su tutto il fronte. Evidenziai tale profilo eccezionale, in attesa di un commento. Se era vero che non era mio compito spingermi al di là della semplice lettura dei numeri, l’anomalia dei suoi parametri necessitava di un confronto interpretativo con Ventrone, il responsabile della preparazione. Il suo parere mi interessava molto e avrebbe soddisfatto, almeno in parte, la mia inquietudine scientifica. “Questa è una cosa speciale” fu la risposta asciutta e al contempo solleticante ulteriori domande. Il tono pacato e riflessivo del collega racchiudeva significati in divenire, tutti da scoprire. Come se i numeri che leggevamo insieme possedessero un’intrinseca capacità di elevazione esponenziale.
Da quel momento la mia curiosità si accrebbe in proporzione. Avrei voluto incontrare Alessandro quanto prima. Naturalmente lo conoscevo di fama, ma desideravo verificare di persona a chi corrispondessero i numeri, quel razionale e stupefacente algoritmo studiato sulla carta. Mi affascinava l’idea di passare dai freddi numeri al soggetto in carne e ossa. I veri campioni hanno sempre qualcosa che li contraddistingue e che, in parte, li accomuna.
Tutte le ore e i giorni passati ad analizzare quei dati e grafici, invece di trasformarmi in una sorta di topo da laboratorio, attività che appaga solo metà della mia natura, suscitarono in me la smania di associare all’interpretazione speculativa un’esperienza di carattere umano, tale da suggestionarmi. Incontrai Del Piero durante una pausa di lavoro, al bancone del bar dell’albergo di Châtillon dove la Juventus era ospitata in raduno precampionato. Mi ci trovai accanto mentre sorseggiavamo un caffè e non potei fare a meno di presentarmi. Fu uno di quei momenti in cui la dimensione reale, attraverso una semplice stretta di mano, si trasforma in un’intensa suggestione. Il suo sorriso aperto e genuino, la sua disponibilità mi diedero l’impressione di una persona mite e riservata. Ricordo bene quell’incontro. Un decollare in verticale dalla dimensione piatta dei numeri. Tutto ebbe inizio da lì.
Nella mia lunga carriera, avendo partecipato, nel ruolo di tecnico della Nazionale italiana di atletica leggera, a due Olimpiadi, quella di Los Angeles del 1984 e quella di Seul del 1988, ho seguito tanti campioni, passati alla storia per le loro imprese. Per singolare coincidenza, il nome di tutti gli atleti con cui ho avuto a che fare in maniera esclusiva inizia con la “A”. Tanto che la prima lettera dell’alfabeto, nella mia mente, è giunta a simboleggiare un codice suggestivo di eccezionalità, una chiave musicale e stilistica. Mi riferisco ad Alessandro Andrei, campione olimpico nel 1984 e primatista mondiale nel getto del peso nel 1987; a Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano, vincitore del Roland Garros e della Coppa Davis nel 1976; ad Alberto Tomba, cinquanta vittorie in Coppa del Mondo, poi conseguita nel 1995, tre medaglie d’oro olimpiche e due mondiali. E, naturalmente, ad Alessandro Del Piero.
Alessandro Andrei era un atleta dalla doppia personalità. Chi lo vedeva per strada, vestito con abiti normali e con i suoi tipici occhiali da vista, ne avrebbe ricavato un giudizio di decorosa serietà. Allo stesso modo si poteva riceverne l’impressione di un Clark Kent: un uomo pacifico, molto timido e riservato. Ma nelle gare importanti si trasformava e assumeva le caratteristiche di Superman, capace di tirare fuori poteri eccezionali. In quelle situazioni riusciva a sorprendere tutti, sembrava che mutasse in una dimensione diversa da quella umana. Il meccanismo che dava il via alla sua trasformazione era innescato dalle offese. Doveva essere insultato, fatto oggetto delle più ignobili ingiurie. Era lui stesso a chiederlo. Mi domandai come avesse potuto sviluppare un comportamento del genere. La prima volta che accadde rimasi sbigottito: si mise di fronte a me e iniziò a compiere una sequenza interminabile di salti, sembrava che stesse abbandonando le sembianze umane. Le braccia flesse, le vene gonfie, i pugni stretti, mi aizzava con frasi del tipo: “Offendimi. Dài, offendimi!”. Travolto da simili urla e provocazioni, facendo i conti con il senso di vergogna che provavo, chiaramente non eravamo soli, più per levarmi subito dall’imbarazzo che per convinzione sull’efficacia di quella “tecnica villana”, indossai i bizzarri panni che anni dopo vidi interpretati dal sergente maggiore Hartman nel film Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, quello che ruggiva: “Palla di Lardo... ti ammazzo a forza di ginnastica, ti faccio venire i muscoli al buco del culo...”. Non credevo alle parole che uscivano dalla mia bocca, e lui pompava come un maledetto. Poi entrò in pedana e catapultò quella dannata sfera oltre i 20 metri. Fino ad allora era fermo a poco più di 18. Corsi ad abbracciarlo e, commosso, gli domandai se si era reso conto di quello che aveva appena fatto e come stava. Mi guardò con gli occhi smarriti, la mandibola cascante, un impacciato Clark Kent appena smesso l’alter ego di Superman. Nei giorni a venire capii il perché di un comportamento del genere. Andrei si serviva della mia autorità per sentirsi in uno stato di sottomissione. Voleva essere mortificato, l’innesco giusto per scatenare la micidiale metamorfosi. Il suo cervello, in condizioni normali tipico di una persona garbata e timorosa, al momento della gara si trasformava in quello di un demone visionario capace di accendere la scintilla eroica in quella massa colossale di muscoli. Qualcuno doveva inserire la spina, e l’addetto alla mutazione del Terminator ero io.
Alle Olimpiadi di Los Angeles, dove vinse la medaglia d’oro, visto che per regolamento non mi era permesso di essere in campo a incalzarlo, sul bus che ci portava allo stadio mi implorava in modo confuso un aiuto per affrontare la prova più importante della sua vita. Riguardava la cattiveria e la ferocia. Il licantropo, nell’immaginario collettivo, personifica la creatura umana capace di mutarsi in lupo. Una belva sanguinaria e spietata in grado di sbranare chiunque tenti di ostacolarlo. Sono convinto che Andrei, dopo aver ascoltato le mie parole deliranti, scese in campo con un’idea fissa: far piazza pulita degli avversari. Durante le pause della gara, aspettando il suo turno di lancio, si cospargeva il collo di carbonato di magnesio per non far scivolare il peso e saltellava come un animale selvaggio. Le telecamere lo riprendevano per questa sua stranezza: primi piani sul volto trasfigurato in qualcosa di feroce, in una visione ultraumana, mentre gli altri atleti aspettavano seduti e immobili, imbambolati e tesi. I circa centomila spettatori seguivano sbalorditi sui maxischermi. Salì in pedana e, con gesto liberatorio e un urlo lacerante, spinse la sfera di ferro a 21,26 metri, a pochi centimetri dai 21,35 del record olimpico del russo Vladimir Kiselëv. A quel punto Andrei montò sul podio con aria fiera e smarrita: mentre suonava l’inno di Mameli i suoi occhi si inumidirono di timidezza e commozione e tornò uomo comune, ma con la medaglia d’oro appesa al collo.
La vittoria e i modi con cui Andrei si era imposto su avversari ben più quotati stupirono anche il mitico Sylvester Stallone che, qualche giorno dopo, ci invitò nella palestra di Santa Monica (Los Angeles) dove quotidianamente scolpiva la propria muscolatura. Ecco apparire la sua inconfondibile e imponente figura di Rambo in maglietta larga, che lasciava scoperti gli enormi avambracci, e con i tipici mezzi guanti neri per il sollevamento dei pesi. Appena vide Alessandro esultò di gioia con un grido da cowboy. Allargò le braccia, si avvicinò e gli strinse con vigore la mano. Tastò l’eccezionale muscolatura del campione italiano e si girò verso di me. Dondolava la testa in segno di complicità e apprezzamento, le labbra tipicamente tese e turgide, poi con sguardo serio e sopracciglia aggrottate commentò: «He’s a good guy!», come per confermare che quello Spartacus italiano era di indole buona. Dopo aver scambiato battute e complimenti da conterraneo di origine, Sylvester disse ad Alessandro che se fosse rimasto in America avrebbe avuto delle ottime chance per combinare qualcosa nel mondo dello spettacolo, e anche per ottenere parti in alcuni film di Hollywood. La risposta del nostro fu un no deciso, espresso con gesti delle mani mosse avanti e indietro come si fa per segnalare di frenare o di fermarsi. Certamente Andrei avrà avuto le sue ragioni, ma ancor oggi resto dell’avviso che sarebbe potuto diventare un buon attore. Riusciva molto bene nelle trasformazioni.
Questi aneddoti mi paiono importanti, fanno parte della storia mai raccontata dell’atletica, e rappresentano bene la personalità di un campione che ancora oggi occupa il terzo posto nelle liste mondiali all-time del getto del peso. È bene aggiungere che Andrei possedeva caratteristiche elastiche muscolari esagerate, mai riscontrate in nessun altro atleta. In vent’anni di attività agonistica, e dopo aver sollevato milioni di chilogrammi in palestra (il suo record è di 110 tonnellate in un solo giorno), non ha mai sofferto di un problema fisico, né ha mai subito traumi di una certa gravità. Non ha mai perso un allenamento. Ricordo che una volta, dopo essersi esercitato la mattina e il pomeriggio, fatta la doccia si presentò di nuovo in campo e con piglio categorico mi disse: «Devo rifare tutto da capo perché non mi sono piaciuto». Lanciò per altre due ore. Questo era Andrei, Clark Kent nel quotidiano e Superman in pedana. Nel salto in lungo da fermo, un test standard per misurare la forza esplosiva degli arti inferiori, realizzava 3,40 metri. Gettava la sfera da 10 chilogrammi a 18 metri. Pesava 118 chili e la sua percentuale di grasso stava sotto il 10 per cento. I lanciatori dell’epoca non pesavano meno di 130 chili. Aggiungo un ricordo impressionante: ai Campionati del Mondo di Roma del 1987, Stadio dei Marmi, nella fase di riscaldamento riuscì a gettare ripetutamente il peso a 24 metri con avvilito stupore dei lanciatori tedeschi dell’Est, tra i quali c’era il grande Udo Beyer. Il record di Andrei è di 22,91 metri, attualmente quello del mondo è fissato a 23,12. A ripensare a come iniziò questa straordinaria avventura sportiva mi viene da sorridere. Infatti scelsi Alessandro Andrei sulla base di un semplice criterio antropometrico, valutandolo ideale per il getto del peso. Un aneddoto rende bene come andarono le cose. Andrei si presentò ai campionati studenteschi (1975) di atletica e si piazzò al quinto posto con una misura non certo esaltante. Tuttavia mi colpì il suo fisico, massiccio ma non grasso. Lo convinsi a proseguire nella disciplina sotto la mia guida, nonostante i risultati deludenti. Confesso che, in quel periodo, per giustificare in famiglia le mie troppe assenze e le mancate soddisfazioni agonistiche, dichiarai: “Con questo ragazzo, tra dieci anni, vinco le Olimpiadi”. Così accadde davvero. L’archetipo del lanciatore del peso, al tempo di Andrei, prevedeva una specie di ciccione, dotato di una mole fuori dalla norma. Infatti, la forza veniva attribuita alla corporatura: l’effetto propulsivo impresso all’attrezzo (7,257 chili) sarebbe aumentato proporzionalmente alla massa dell’atleta. Nella società sportiva in cui il giovane era iscritto, prima di dedicarsi al getto del peso i tecnici lo avevano destinato alla corsa di fondo per farlo dimagrire, anche sotto le pressioni della madre che lo riteneva troppo grosso.
Per parte mia, dallo studio antropometrico avevo tratto notevoli indicazioni per la scelta dei lanciatori e i risultati mi davano ragione. La forza non è determinata solo dalla massa, ma anche dall’accelerazione con cui si muove, e questa è tanto maggiore quanto è attiva, formata da muscoli e non da grasso. Nelle esercitazioni di forza, che ormai si stavano diffondendo nelle nasciture palestre, il carico spostato corrispondeva alla misura della forza espressa dal soggetto. All’epoca molti lanciatori erano diventati veramente forti, ma il più delle volte si lanciavano l’attrezzo sui piedi. Un ricordo va tributato a un certo Adolfo Consolini, primatista mondiale del lancio del disco. Nell’ambiente si vociferava che non fosse un granché nel sollevare i pesi, eppure era dotato di una forza sovrumana. Poteva, a braccia tese in avanti, sostenere una persona. Da non credersi, una sorta di Primo Carnera prestato all’atletica. È pur vero che nel lancio del disco non è necessaria una forza enorme, ma di certo è indispensabile una forza espressa con grande velocità. Stranamente Consolini sprigionava una forza statica bruta, non costruita con l’esercizio, ma lanciava il disco molto lontano. Questo genere di incongruenze mi portò a compiere studi più approfonditi sui diversi tipi di lancio, soprattutto su come veniva espressa la forza nei vari momenti del gesto (fase iniziale, centrale e finale). Mi venne l’idea di far costruire un congegno elettronico collegato a una fotocamera che cominciava a scattare immagini in automatico nell’istante in cui il lanciatore iniziava lo spostamento in pedana, continuando fino a lancio effettuato. Venivano scattate ben 5 foto al secondo. Tra il 1980 e il 1984 consumai gli occhi a studiare le sequenze fotografiche che comparavo sovrapponendole con la tecnica della carta velina. Attraverso questo modo rudimentale ma efficace ricalcavo la sagoma del lanciatore sulla fotografia, rispettando i tempi e le diverse fasi del lancio. Prendevo come riferimento l’atleta che aveva ottenuto il massimo risultato. Quando le misure erano più scadenti riuscivo a individuare la posizione corporea tecnicamente sbagliata, con riferimento ai tempi di esecuzione. Rimaneva un problema, per me a quel tempo irrisolto: a volte le sagome risultavano identiche, ma la prestazione dava esito completamente differente.
Questa tecnica delle veline rappresentava comunque un tipo di analisi pionieristica, soprattutto sul piano macroscopico. Lo studio meticoloso dei singoli fotogrammi, lavoro a cui dedicai la maggiore attenzione, si riferiva a momenti in cui veniva espressa la forza degli arti inferiori. Anche solo dalla traiettoria del peso imparai a riconoscere le anomalie relative allo spostamento in pedana. In questi casi non sviluppava un andamento lineare, ma era caratterizzato da picchi di variazione della velocità, ovvero dell’accelerazione. Nei momenti di decelerazione il corpo, dopo una breve fase di volo, ricadeva urtando a terra con i piedi, nel contempo la muscolatura della coscia interveniva prima per frenare la discesa in basso (angolo al ginocchio che si chiude) e quindi per spingere (partendo dall’angolo propriocettivo) l’intera massa verso l’alto e concludere il gesto finale di lancio. L’inerzia della massa corporea era in balia di un susseguirsi continuo di fasi di accelerazione e di decelerazione. Questo strano andamento altalenante, con i muscoli impegnati in fasi di frenata e di spinta, mi richiamò alla mente lo yo-yo, gioco costituito da un filo che si avvolge intorno a una ruzzola. Non tutti sanno che questo oggetto nasce da uno strumento impiegato nei laboratori di fisica applicata per dimostrare l’inerzia di moto e il principio di conservazione dell’energia. La ruzzola discende con moto accelerato e risale per inerzia. Mi sembrò che questo principio della fisica descrivesse in modo più o meno fedele ciò che accadeva durante le diverse fasi del getto del peso. Nel 1977 brevettai uno strumento per allenare la forza, il Rotofeed-back, basato appunto sul principio dell’inerzia. È composto da una predella fissata a terra a cui è saldata ortogonalmente una crociera dotata di una puleggia che ruota a destra e a sinistra. Mediante un cavo, esattamente come accade nello yo-yo, ai bracci sono applicati i pesi previsti per aumentare o diminuire lo sforzo. L’estremità del cavo è concepita per essere fissata a un’estremità del segmento corporeo. Quando la leva articolare si apre, per effetto della muscolatura, il cavo si srotola, per arrotolarsi su se stesso durante la flessione dell’arto. Lo svolgersi del cavo è realizzato dalla forza del muscolo che si accorcia. Il carico della puleggia acquista velocità e, prima di invertire il verso (alternativamente a destra e a sinistra) decelera. Il muscolo deve dapprima frenarlo mediante una contrazione di tipo eccentrico e poi fermarlo, quindi deve lasciarlo continuare per inerzia. Con questa macchina, tra gli anni Settanta e i Novanta, hanno lavorato i grandi atleti che ho avuto l’onore di seguire. Solo successivamente, nel 2000, sono venuto a conoscenza che la NASA, l’ente spaziale americano, aveva messo a punto una macchina a carico inerziale per favorire una più rapida ripresa del tono muscolare degli astronauti dopo le missioni in assenza di gravità. Ormai sono quasi quarant’anni che lavoro in questo modo. Il record di incremento del volume muscolare lo ottenne un calciatore di talento, Fernando De Napoli, che in soli venti giorni, dopo il fermo conseguente a un trauma muscolare, aumentò di ben 6 centimetri la circonferenza della coscia. Con il Rotofeed-back sono stato in grado di fare allenare non solo un singolo muscolo, ma il gesto tecnico specifico in varie discipline sportive. Viene potenziata la catena cinetica nella sua accezione condizionale. Questa particolarità, unica nel campo delle attrezzature per costruire la muscolatura, può anche favorire gli effetti di transfert. I risultati erano confortanti, ma la sperimentazione avrebbe richiesto ancora molto tempo. Lo dimostra il fatto che a tutt’oggi resta aperto il dibattito su quanto l’incremento condizionale della catena cinetica sia funzionale al gesto. Il problema più rilevante è dato dalla durata della fase di freno, in quanto se l’angolo alle ginocchia, per esempio nel momento in cui si prepara il salto da fermo, è abbastanza aperto, il tempo risulta più breve e l’azione della muscolatura che fissa l’articolazione (posturale) è più intensa. Nel caso in cui l’angolo alle ginocchia si chiuda troppo, il tempo della fase di freno e lo stiramento della muscolatura (quadricipite femorale, ad azione agonista) tendono ad aumentare. I benefici ottenuti con questa impostazione, in campo sportivo e riabilitativo, erano e restano molto validi. Man mano che venivano confermati i riscontri positivi cercavo subito di formulare nuove ipotesi che andavano oltre quanto era noto.
Adriano Panatta sapeva di essere un tennista di grande talento e lo dimostrò ampiamente. D’altro canto, forse per una sorta di pigrizia, non dava sfoggio delle sue eccellenti qualità fisiche. Quando, nel 1978, fui nominato responsabile della preparazione della squadra di Coppa Davis e inserito nel team del maestro ad honorem e allenatore federale Victor Crotta, dovetti sudare non poco per convincere Adriano a seguire i miei metodi nella preparazione fisica. Al contrario, con Barazzutti, Bertolucci e Ocleppo non ebbi nessun problema. Per Adriano le cose più importanti erano il gesto tecnico e il gioco, del resto della preparazione se ne poteva fare a meno. Condivideva la stessa idea del suo precedente allenatore Mario Belardinelli, che fra i suoi allievi aveva avuto anche Benito Mussol...