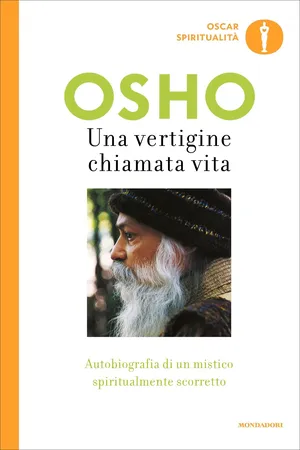Io non sono mai stato spirituale nel senso che tu dai alla parola. Non sono mai andato nei templi o nelle chiese, non ho mai letto le Scritture o seguito pratiche specifiche per trovare la verità, non ho mai adorato o pregato Dio. Nella mia vita non ho mai fatto nulla di tutto ciò; per cui puoi senz’altro dire che io non ho mai fatto alcunché di spirituale. Ma per me la spiritualità ha una connotazione totalmente diversa: richiede un’individualità onesta; non permette alcun tipo di dipendenza. Crea una libertà fine a se stessa: non importano né il prezzo da pagare né le conseguenze. Non è mai nella folla, ma è solitaria, perché la folla non ha mai trovato alcuna verità. La verità è stata trovata solo nella solitudine.
La mia idea di spiritualità ha un significato diverso dalla tua. Le storie della mia infanzia, se riesci a comprenderle, faranno riferimento a tutte queste qualità, in un modo o nell’altro. Nessuno può definirle spirituali. Io le definisco così perché, secondo me, hanno fornito tutto ciò cui un uomo può aspirare.
Mentre ascolti i racconti della mia infanzia dovresti provare a cercarvi una qualità, non nel racconto in sé, ma una qualità intrinseca che corre come un sottile filo attraverso tutti i miei ricordi. E questo sottile filo è spirituale.
Spiritualità, per me, vuol dire semplicemente trovare se stessi. Non ho mai permesso a nessuno di fare questo lavoro per me, perché nessuno lo può fare al posto tuo: lo devi fare tu, in prima persona.
1931-1939: Kuchwada, Madhya Pradesh, India
Ricordo sempre il villaggio in cui sono nato. Resta inspiegabile come mai l’esistenza abbia scelto quel villaggio… doveva essere così! Il villaggio era meraviglioso. Ho viaggiato in lungo e in largo, ma non ho mai incontrato quella stessa bellezza. Non si incontra mai una cosa identica a un’altra. Le cose vanno e vengono, ma non sono mai le stesse.
Riesco a vedere quel villaggio, piccolo e immobile… poche capanne vicino a uno stagno, e alcuni alberi svettanti, dove ero solito giocare… nel villaggio non c’era una scuola. Non era una cosa importante: per circa nove anni non venni educato, e quelli sono gli anni più importanti… superata quell’età, non si può più essere educati. Quindi, in un certo senso, nonostante io abbia diversi diplomi e lauree, sono rimasto allo stato selvaggio. Qualunque zotico avrebbe potuto ottenere le mie stesse lauree, i miei trenta e lode. Ogni anno un’infinità di imbecilli ci riesce: quelle lauree non hanno alcuna importanza…
La cosa importante è che nei primi anni della mia vita non sono stato educato. Nel villaggio non c’era una scuola, né una strada né una ferrovia, e neppure l’ufficio postale. Era una benedizione! Quel villaggio era un mondo a sé. E anche quando me ne andai, ho continuato a vivere in quel mondo, libero da ogni educazione.
Ma più che la casa, o il villaggio, ricordo le persone. Nella mia vita ho incontrato milioni di persone, ma la gente di quel villaggio supera tutti per innocenza, perché era molto primitiva, non sapeva nulla del mondo. In quel villaggio non è mai arrivato un giornale. E ora capirete come mai non esistesse una scuola, neppure elementare… era una benedizione! Nessun bambino nato in epoca moderna ha mai avuto un dono simile!
In passato, c’erano bambini che si sposavano prima di compiere dieci anni. A volte venivano sposati perfino mentre si trovavano nell’utero materno. Bastava che due amici decidessero: «Le nostre mogli sono incinte, quindi se una partorisce un maschio e l’altra una femmina, il matrimonio è combinato». A nessuno veniva in mente di chiedere al bambino e alla bambina; non erano ancora nati! E la gente manteneva la parola.
Mia madre si sposò quando aveva sette anni. Mio padre non ne aveva più di dieci, e non comprendeva che cosa stesse accadendo. Gli chiedevo spesso: «Qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più nel tuo matrimonio?». Lui rispondeva: «Andare a cavallo». Naturalmente! Per la prima volta era vestito come un re, con un pugnale al fianco, in groppa a un cavallo e con tutti che gli camminavano intorno. Si divertì tantissimo. Questo fu ciò che gli piacque di più nel suo matrimonio. Una luna di miele era fuori discussione: dove manderesti in luna di miele un bambino di dieci anni e una bambina di sette? In India la luna di miele non è mai esistita, e neppure nel resto del mondo, in passato.
Quando mio padre aveva dieci anni e mia madre sette, la madre di mio padre morì. Dopo il matrimonio, forse uno o due anni dopo, l’intera responsabilità della famiglia cadde sulle spalle di mia madre, che aveva appena nove anni. La madre di mio padre aveva lasciato due bambine e due bambini piccoli e la loro responsabilità cadde su una bambina di nove anni e su un figlio di dodici.
Il padre di mio padre non volle mai vivere nella città dove aveva il suo negozio. Amava la campagna, e quando la moglie morì fu completamente libero. All’epoca il governo dava la terra gratuitamente a chi ne faceva richiesta, perché ce n’era tantissima e scarseggiava la gente che la coltivasse. Mio nonno ebbe dunque venti ettari di terreno dal governo e lasciò il negozio nelle mani di quei bambini, mio padre e mia madre. Si divertì a creare un giardino, una fattoria e amava vivere lì, all’aria aperta. Odiava la città.
Quindi mio padre non fece alcuna esperienza della libertà dei giovani d’oggi. Non divenne mai giovane in quel senso. Era già vecchio prima di poter diventare giovane, con fratelli e sorelle più giovani cui badare e un negozio da mandare avanti. E quando ebbe vent’anni dovette combinare il matrimonio delle sorelle, provvedere al matrimonio e all’educazione dei fratelli.
Io non ho mai chiamato mia madre «mamma», perché, prima che nascessi, lei si prendeva già cura di quattro bambini che la chiamavano bhabhi, che vuol dire «zia». E poiché quattro bambini la chiamavano già così, anch’io cominciai a chiamarla bhabhi.
Io sono stato allevato dai miei nonni materni. Queste due persone anziane erano sole e volevano un bambino che sarebbe stata la gioia dei loro ultimi giorni. Mio padre e mia madre furono d’accordo: io ero il loro figlio maggiore, quello nato per primo; mandarono me.
Nei primi anni della mia infanzia non ricordo di aver avuto alcuna relazione con la famiglia di mio padre. Ho passato i miei anni più teneri con due persone anziane: mio nonno – assistito dal suo vecchio servo, che era davvero un uomo meraviglioso – e mia nonna. Tre persone… E la distanza tra noi era insormontabile: ero completamente solo. Queste persone anziane non erano la mia compagnia, non potevano esserlo. E io non avevo nessun altro, perché in quel piccolo villaggio la mia famiglia era la più ricca. Ed era un villaggio talmente piccolo – non più di duecento persone – e così povero che i miei nonni non mi permettevano di mescolarmi con gli altri bambini: erano sporchi e, naturalmente, quasi dei mendicanti; era quindi impossibile avere degli amici. Tutto ciò ebbe un profondo impatto: in tutta la mia vita non ho mai conosciuto nessuno che fosse un amico. Certo, ho fatto delle conoscenze.
In quei primi anni ero così solo che cominciai a godermela; era davvero una gioia: quella situazione non fu affatto una disgrazia per me, si dimostrò una vera fortuna. Cominciai ad apprezzare la mia condizione e a sentirmi autosufficiente: non dipendevo da nessuno.
I giochi non mi hanno mai interessato per il semplice motivo che, sin dall’infanzia, non c’era modo di giocare, né avevo dei compagni. Posso ancora vedermi in quei primi anni mentre non faccio altro che starmene seduto, da solo. La nostra casa era in una bellissima posizione, proprio di fronte a un lago, che distava alcuni chilometri… era bellissimo, estremamente silenzioso. Solo ogni tanto si scorgeva una fila di candide gru volare o fare richiami d’amore, e la pace veniva disturbata; altrimenti, il luogo era perfetto per la meditazione. E quando un richiamo amoroso d’un uccello disturba la pace… dopo, la pace diventa più profonda.
Il lago era pieno di fiori di loto e io mi sedevo, per ore, felice come se il mondo non esistesse: i fiori di loto, le gru candide, il silenzio…
I miei nonni divennero ben presto consapevoli di una cosa: la solitudine mi piaceva. Notarono che non avevo alcun desiderio di andare al villaggio per incontrare qualcuno o fare quattro chiacchiere. Anche se loro volevano dirmi qualcosa, le mie risposte erano sì o no; non mi interessava mai parlare più di tanto. Si accorsero quindi che mi godevo la mia solitudine e per loro divenne un dovere sacro non disturbarmi.
Per sette anni, nessuno provò mai a corrompere la mia innocenza: nessuno. Quei tre anziani cercavano di proteggermi in ogni modo, affinché nessuno mi disturbasse. Di fatto, man mano che crescevo, cominciai a sentirmi un po’ imbarazzato perché, a causa mia, non potevano parlare, non potevano vivere normalmente né comportarsi come tutti gli altri.
Ai bambini in genere si dice: «Sta’ zitto perché tuo padre sta pensando, tuo nonno sta riposando. Sta’ buono, siediti e sta’ zitto». Nella mia infanzia avvenne l’opposto. Adesso non posso dire come e perché; semplicemente avvenne. Il merito non è mio.
Tutte e tre quelle persone facevano continuamente gesti tra loro: «Non disturbarlo; sta così bene». E cominciarono ad amare il mio silenzio.
Il silenzio ha la sua vibrazione; è contagioso, in particolare il silenzio di un bambino quando non è forzato, quando non è dovuto al fatto che gli stai dicendo: «Se dai fastidio o fai rumore, ti picchio». No, quello non è silenzio, non crea la gioiosa vibrazione di cui sto parlando: quello di cui parlo io accade quando un bambino è silenzioso per conto suo, felice senza motivo; la sua felicità non ha cause. E crea onde travolgenti tutt’intorno.
Quindi fu solo una coincidenza se per sette anni nessuno mi disturbò, mi diede fastidio o mi preparò per il mondo degli affari, della politica e della diplomazia. I miei nonni erano più interessati a mantenermi il più naturale possibile, soprattutto mia nonna. Lei è una delle cause – queste piccole cose influenzano tutta la vita – del mio rispetto per l’intera umanità. Era una donna semplice, ignorante, ma enormemente sensibile. Disse chiaramente a mio nonno e al loro servitore: «Tutti noi abbiamo vissuto un tipo di vita che non ci ha condotto da nessuna parte. Siamo vuoti come non mai, e adesso la morte si sta avvicinando». Fu lei a insistere: «Lasciamo che questo bambino non venga influenzato da noi. Che influenza possiamo esercitare? Potremmo solo renderlo simile a noi, ma noi non siamo nulla. Diamogli la possibilità di essere se stesso».
Mio nonno – li sentivo discutere nella notte, pensando che io stessi dormendo – le diceva spesso: «Mi dici di comportarmi così, e io lo sto facendo; ma è il figlio di qualcun altro, e prima o poi dovrà andare dai suoi genitori. Che cosa diranno? “Non gli avete dato alcuna educazione, alcuna disciplina, è un vero selvaggio”».
Lei rispondeva: «Non ti preoccupare. In tutto il mondo la gente è civile, beneducata e cortese: qual è il risultato? Tu sei molto civilizzato: che cosa ne hai ricavato? Al massimo i suoi genitori si arrabbieranno con noi. E allora? Lascia che si arrabbino. Non possono farci del male, e a quel punto il bambino sarà abbastanza forte, per cui non potranno più cambiare il corso della sua vita».
Sono enormemente grato a quella vecchia. Mio nonno era sempre preoccupato: prima o poi lui sarebbe stato richiamato alla sua responsabilità: «Diranno: “Vi abbiamo affidato il bambino e voi non gli avete insegnato niente”».
Mia nonna non permise nemmeno che avessi un insegnante privato. Nel villaggio c’era un uomo che avrebbe potuto quanto meno insegnarmi i rudimenti della grammatica, della matematica e un po’ di geografia, aveva solo il quarto livello d’istruzione – in India è chiamata «istruzione primaria» – ma era la persona più colta dei dintorni. Mio nonno insisteva: «Potrebbe venire a insegnargli qualcosa. Almeno saprà l’alfabeto e un po’ di aritmetica, per cui quando andrà dai genitori non diranno che abbiamo sprecato completamente questi sette anni».
Ma mia nonna diceva: «Lascia pure che, dopo aver compiuto i sette anni, facciano tutto quello che vogliono. Per sette anni non deve avere alcuna istruzione, e noi non interferiremo». La sua argomentazione era sempre: «Tu conosci l’alfabeto: e allora? Sai la matematica: ebbene? Hai guadagnato un po’ di soldi; vuoi che anche lui guadagni un po’ di soldi e viva esattamente come te?».
Questo era sufficiente per mettere a tacere quel vecchio. Che fare? Era in difficoltà, perché non sapeva che cosa rispondere. Ed era consapevole che lui sarebbe stato considerato responsabile, non lei, perché mio padre avrebbe chiesto a lui: «Che cos’hai fatto?». E le cose sarebbero davvero andate così, se mio nonno non fosse morto prima.
In seguito, mio padre avrebbe spesso detto: «Quel vecchio è responsabile, ha rovinato il bambino». Ma a quel punto ero abbastanza forte per rispondergli chiaro e tondo: «Davanti a me non proferire mai una sola parola contro il nonno. Lui mi ha salvato dall’essere rovinato da te: questa è la tua vera rabbia. Però hai altri bambini: rovina loro! E alla fine vedrai chi è stato veramente rovinato».
Egli aveva altri figli, e altri ancora ne arrivarono. Io lo stuzzicavo: «Per favore, fa’ ancora un figlio, fanne una dozzina. Undici bambini? La gente chiede continuamente: “Quanti figli hai?”. Undici non sembra il numero giusto; dodici fa più impressione». E negli anni successivi gli dicevo: «Continua a rovinare i tuoi figli; io sono selvaggio, e tale resterò». In qualche modo sono rimasto fuori dalla morsa della civiltà.
Mio nonno materno era un uomo generoso. Era povero, ma ricco di generosità. Dava a tutti tutto ciò che aveva. Da lui ho imparato a essere generoso, lo devo ammettere. Non l’ho mai visto dire di no a un mendicante o a chiunque gli chiedesse qualcosa.
Lo chiamavo Nana, così viene chiamato in India il nonno materno. E chiamavo Nan...