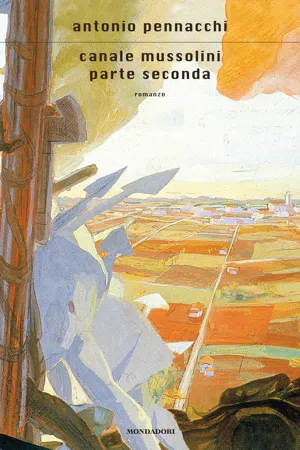La sera del 29 aprile 1945 – domenica, santa Caterina da Siena; luna ancora piena piena – mio cugino Diomede stava venendo col suo camion giallo a notte fonda sull’Appia, dall’aeroporto verso Littoria; che però oramai si chiamava Latina.
Il camion non era il Dodge che le ho detto prima – mezzo da trasporto di guerra leggero, una tonnellata e mezza; quattro ruote motrici ma due assi soli; motore a benzina super quattro tempi – anche se lui al suo primo Dodge gli ha poi voluto sempre bene. Ma era un camion leggero le ho detto, ed era passato quasi un anno e adesso di camion ne aveva quanti ne voleva. Tutti usati americani, ovviamente, tutti pitturati di giallo per non dare nell’occhio – pensava lui – agli eventuali ufficiali Usa più pignoli o magari non oliati. E questo era un camion da trasporto pesante Mack Trucks NR da 10 tonnellate. Una bestia spropositata gigantesca: un tre assi e quattro ruote motrici con cabina tozza alta squadrata che pareva quasi un 18BL nostro d’una volta; muso da far paura e motore diesel Mack-Lanova da 8505 cm3, che sviluppava 131 cavalli vapore. Ho detto tutto.
Pure se era domenica però, quel 29 aprile 1945 Diomede aveva lavorato come un matto – più o meno lecitamente – per tutta la giornata. Prima sui campi minati al mare appresso ai suoi sminatori, e appena fatto l’imbrunire all’aeroporto, con gli ultimi americani che prima di partire gli avevano svenduto sottobanco – «Lost or destroyed in war operations», avrebbero poi scritto sopra i moduli – dei gruppi elettrogeni, gru, cataste di ferro e non so quanto altro. Il terzo o quarto viaggio che faceva, oramai, nella notte.
Ma pure lavorando lavorando dalla mattina presto fino a quell’ora, Diomede aveva saputo che quel giorno – 29 aprile 1945 – la guerra finalmente era cessata per tutti anche nel resto d’Italia: «Dio sia lodà». Ed era felice come tutti, anche se aveva avuto termine purtroppo nel modo che sappiamo: cruento come ogni guerra, osceno come ogni guerra civile.
La buona novella – «I ga copà ’l Duce, i ga copà Musolin!» – era corsa di bocca in bocca, strillata con gioia per tutta Italia: «I lo ga picà coi so zerarchi come un maiale in sima a un bensinaro. E c’era anche lei, quea bruta sporca de la Petaci, che la ’ndeva in ziro co n’omo sposà, sensa gnanca ’e budande…» tutti felici, ripeto, e contenti. Oltre che scandalizzati.
Solo mia nonna, al podere 517, si fece triste: «Am dispiase! Am dispiase massa massa…»
«Bruta troia» le disse lì per lì mio nonno. Ma subito ci ripensò: «Sarà stà un sporcason, ma n’i gheva da tratarlo acsì, am dispiase anca a mi… Era uno di famiglia a momenti. Lo abbiamo ancora quell’erpice che ne ga zustà?»
«Lo ghemo sì, avesse fatto sempre il fabbro! Jèra un putin quea volta, povro fiòlo. Disea sènper che ’l gheva da tornar…» e mia nonna si fece il segno della croce, tirò triste triste fuori da un cassetto la corona del rosario e cominciò a pregare: «Requiem aeternam dona eis Domine…»
«Bruta sporca» le ridisse mio nonno, facendole dolce una carezza sul viso.
Ora come lei sa, il Duce e Claretta avevano lasciato il lago di Garda dieci giorni prima – il 18 aprile, data della loro ultima lettera – appena chiaro che non c’era più niente da fare: stava crollando giù tutto, il castello di carte della Rsi. Ma l’avevano lasciato – il Garda – ognuno per suo conto. Tutti e due per Milano, ma Claretta a casa dei suoi e lui in prefettura. Anzi, lui aveva provato in tutti i modi a distoglierla: «Varda che l’è pericoloso, non star a vegner anca ti».
Le aveva pure organizzato un aereo per mettersi in salvo in Spagna a Barcellona. Ma lei niente. Testarda. E sull’aereo ci aveva messo il padre, la madre e la sorella. Lei invece col fratello Marcello Petacci di due anni più grande – maggiore medico della marina, moglie e due figli; inviso a tutti i gerarchi e a tutta Roma quando stavano ancora a Roma, ma odiato pure nel resto d’Italia e nella Rsi perché pare facesse proprio il cognato del Duce con raccomandazioni, intrallazzi e roba varia – lei rimase a Milano. Fino all’ultimo. E il fratello con lei. Sarà stato tutto quello che si vuole, però alla sorella è rimasto vicino.
Il Duce con lei insisteva: «Vai via, vai via! Non stare a venire!»
«E sì… Così tu ti porti la Ruspi?»
«Ancora con sta Ruspi!?»
Poi finalmente il 25 aprile 1945 – in arcivescovado a Milano dal cardinale Schuster – Mussolini viene a sapere che i tedeschi si sono arresi senza dirgli niente. Si sono messi d’accordo con gli alleati e il Cln per lasciare l’Italia in santa pace, a condizione che non si portino neanche un italiano appresso.
«Traditori! I tedeschi i me ga tradì!» si mette ad urlare Mussolini.
Ma lei non ha idea le scenate e gli urli di Claretta all’ultimo minuto in mezzo a tutti, nel cortile della prefettura di Milano qualche ora dopo, nel tardo pomeriggio.
I gerarchi infatti – cessata ogni speranza di ulteriori trattative e la città già insorta – avevano organizzato una colonna di macchine con qualche soldato per andare in Valtellina e, pronti per partire, il Duce lo avevano giustamente messo dentro un’autoblindo.
Lei pure stava lì pronta a infilarsi nella colonna dentro il 1500 Alfa Romeo del fratello, che s’era portato appresso anche la moglie e i due bambini piccoli.
Pronti però, le ho detto, per partire dal cortile della prefettura di Milano – con tutta intorno la città insorta coi fiumi di fazzoletti al collo dei partigiani armati – Claretta a un certo punto s’accorge che nell’autoblindo in cui avevano messo il Duce c’era pure la Elena Curti di ventidue anni, una bellissima ausiliaria della Rsi, con tanto di pistola d’ordinanza, che lei aveva visto spesso entrare e uscire dall’ufficio di Mussolini a Salò e non le era mai piaciuta. «Tu te la fai con quella!», gli era saltata addosso gelosa ogni volta.
«Ma no, ma no».
In realtà questa Elena Curti era un’altra figlia che Mussolini aveva avuto da Angela Curti Cocciati nel 1923 – ha lasciato più figli lui che un patriarca biblico, in giro per l’Italia – e che anche terminata la relazione con la madre aveva continuato a vedere e seguire. Lei avrebbe voluto fare architettura, ma lui no: «È un lavoro da uomini» aveva detto alla madre, e le aveva fatto fare filosofia. E questa bella ragazza s’era arruolata ausiliaria nella Rsi e faceva parte dello staff di Pavolini – il numero due della Rsi, il segretario del partito fascista repubblicano – e quando però si incontravano davanti ad altra gente si davano sempre del voi. Solo a tu per tu erano padre e figlia e si davano del tu. Neanche Claretta lo sapeva e ogni volta che la vedeva, andava su tutte le furie: «Tu te la fai con quella!»
«Ma no, ma no».
Si figuri quindi quel giorno 25 aprile 1945 – nel cortile della prefettura di Milano mentre assediati d’ogni parte stavano scappando precipitando verso il loro ultimo tragico atto – quando l’ha vista di nuovo vicina all’autoblindo con tanto di pistola, bella giovane amazzone in armi di ventidue anni: «Tu te la fai con questa!» s’è messa ad urlare davanti a Pavolini, Barracu, Bombacci, Mezzasoma e tutti gli altri.
«Ma l’è me fiòla Clara, l’è me fiòla!»
E lei s’è stata zitta ammutolita – quasi più gelosa adesso che prima, anzi: «Era proprio meglio prima» – e finalmente alle otto di sera del 25 aprile la colonna è partita.
Tappa a Como. In prefettura anche qua. Conciliaboli, discussioni fra i gerarchi: «Femo questo, femo st’altro. Ndemo in Svìssera o ’ndemo in Valtellina?»
Pavolini: «Agò una Brigata Nera qua, un’altra là, soldati de sora, armati de soto».
«Vali tore alora, valli a prendere!»
«Vago e torno», riparte subito Pavolini.
«Vedrai te», si consolano per un po’ tra loro i rimasti, «apena ch’el torna lu coi suoi soldà! Altro che Valtelina, che femo» che era un ridotto che Pavolini diceva d’avere approntato munitissimo armatissimo, da cui difendersi fino all’arrivo degli angloamericani e arrendersi poi soltanto a questi, poiché – le ripeto – lo sapevano pure loro cosa li aspettava se li avessero presi invece i partigiani: «Il segreto d’ogni minestra», diceva mio zio Adelchi, «lo sa il cuoco. Lo sa soltanto lu, cosa ci ha messo dentro».
Alle 23.30 del 25 aprile, dalla prefettura di Como Mussolini telefona per l’ultima volta alla moglie Rachele: «Io seguo il mio destino. Tu metti in salvo i ragazzi in Svizzera. Sono solo, tutti mi hanno abbandonato. Perdonami il male che ti ho fatto, ma ti ho sempre amata e tu lo sai. Non ho mai amato nessuna come te», ma credo che lo dicesse a tutte.
Intanto però il prefetto di Como che li ha accolti a braccia aperte, dato da mangiare, saloni a disposizione su tutto un piano – con questi gerarchi ministri buttati sui divani a dormire stravaccati mentre fuori ogni tanto si sente qualche colpo di mitra – si viene a sapere che al piano di sotto sta trattando confabulando col Cln. Anzi, man mano che passano le ore, i gerarchi fascisti che s’avventurano nei corridoi incrociano sempre più funzionari della prefettura – fascistissimi repubblicani Rsi anche loro fino a cinque minuti prima – sempre più funzionari con la fascia «Cln» al braccio.
«Andemo ben» ha detto il Duce e capita l’antifona, addio Como e prefetto di Como: «Av salut». Alle 5.45 del 26 aprile – buio pesto, ancora – è a Menaggio con la sua auto ministeriale. L’intento è quello di passare in Svizzera. Dietro alla macchina sua, l’Alfa di Marcello Petacci con moglie, figli e sorella Claretta – «Vai vai, stagli dietro!» – e tutte le altre macchine di gerarchi appresso.
Il Duce trova ospitalità nella villa di un vicefederale, gli altri chi di qua chi di là, vagabondando ciechi confusi nell’ultimo buio della notte.
A mezzogiorno il Duce e una ventina di gerarchi e ministri si trasferiscono nella caserma della milizia confinaria di Grandola, sempre con la scorta appresso di SS che non molla mai Mussolini.
Le ausiliarie fanno da mangiare per tutti. Poi chi di qua chi di là, su una panchina in giardino, seduti a un tavolo o su un divano. E tutti ancora di nuovo: «Femo questo, femo st’altro, speremo che ’l riva presto ’l Pavolini».
Il Duce pure su una panchina in silenzio, mentre quelli ciacolavano ciacolavano.
Finché è sbottato: «Ma non avete proprio capito che è tutto finito?»
La cosiddetta colonna Pavolini era partita in effetti da Milano alle prime luci del giorno con – pare – cinquemila uomini autotrasportati e armati pure con pezzi di artiglieria, ma senza un comando unico: gerarchi e gerarchetti che discutevano fra loro e ognuno faceva quello che voleva. Scartata la Valtellina comunque – troppo distante: novanta chilometri di strade piene piene di partigiani – la direzione obbligata fu Como, per ricongiungersi al Duce.
Arrivati lì però, il Duce non c’era – stava a Grandola – e il prefetto invece stava oramai col Cln e tutti i suoi impiegati a togliere di corsa da ogni muro o scrivania i quadri e le foto di Mussolini: «Va in malora, va’».
Sconforto generale. E più passano le ore a Como a discutere cosa fare o cosa non fare, e più aumenta lo sconforto tra i fascisti: «Xè pien de partisan dapartuto qua».
Alle sette di sera di quel 26 aprile 1945 – a Grandola – il Duce si stufa di stare ad aspettare e decide di ripartire per Menaggio. La piccola colonna automobilistica si rimette in marcia sotto la pioggia battente. L’Alfa 1500 dei Petacci dietro.
Alle tre di notte – 27 aprile oramai – a Como la cosiddetta colonna Pavolini s’arrende, chi in un modo chi nell’altro, al Cln. L’unico che non s’arrende è Pavolini stesso, che lascia la città e si ripresenta da solo a Menaggio.
«E la tua colonna, Alessandro?» gli chiede il Duce.
«Son restà solo mi»....