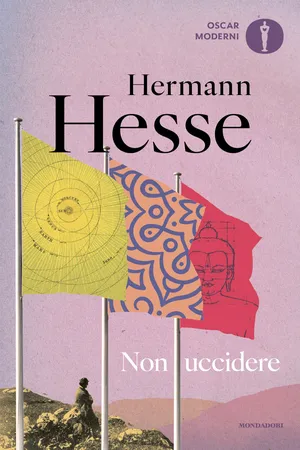
- 208 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Una significativa raccolta di scritti politici sulla guerra e la pace di straordinaria attualità e di grande interesse per il lettore d'oggi.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Non uccidere di Hermann Hesse, Francesco Saba Sardi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Literature e Literature General. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Il ritorno di Zarathustra
1919
Esistevano un tempo uno spirito tedesco, un coraggio tedesco, una prodezza tedesca, che non si esprimevano soltanto in eroici fragori e in esaltazioni di massa. L’ultimo grande pensatore di quel genere è stato Nietzsche il quale, nel bel mezzo della fondazione della Germania e della concomitante fioritura di spirito gregario, è divenuto antipatriota e antitedesco. Questo mio appello intende ricordarlo, rievocarne il coraggio, la solitudine. Anziché il belato del gregge, le cui odierne note piagnucolose non sono certo più amabili delle espressioni brutali e roboanti della «grande era», questo mio scritto intende richiamare i sensibili tra i giovani tedeschi ad alcune realtà ed esperienze dell’anima, semplici quanto incrollabili. Che ciascuno si atteggi, nei confronti del popolo e della collettività, come gli comandano la coscienza e la necessità: se venisse meno a se stesso, alla propria anima, commetterebbe un’indegnità. Ben pochi, nella Germania impoverita e vinta, hanno cominciato a rendersi conto che il pianto e le imprecazioni sono del tutto infruttuosi e si sono apprestati ad affrontare con fermezza e determinazione quel che il futuro ha in serbo. Ben pochi hanno idea della decadenza dello spirito tedesco, manifesta già molto prima della guerra. Non dobbiamo cominciare da ciò che abbiamo alle spalle, da riforme di governo e metodi politici, bensì da ciò che abbiamo davanti, dalla costruzione della personalità, se vogliamo tornare ad avere spiriti e uomini che ci garantiscano il futuro. È di questo che parla il mio piccolo scritto, inizialmente apparso anonimo in Svizzera. Sempre anonimo, ha conosciuto parecchie edizioni: non volevo infatti suscitare la diffidenza dei giovani servendomi del nome di un autore noto. Preferivo che lo valutassero senza pregiudizi, ed è quanto hanno fatto, in tal modo rendendo superflua la continuazione dell’anonimato. [Hermann Hesse in occasione della prima edizione non anonima.]
Quando, tra i giovani della capitale, si diffuse la voce che Zarathustra era ricomparso e che si faceva vedere qua e là per strade e piazze, alcuni di loro decisero di andare a cercarlo. Si trattava di reduci dalla guerra che, in una patria mutata e sconfitta, erano pieni di preoccupazioni e di inquietudini; si avvedevano infatti che erano in atto grandi eventi, il cui senso restava tuttavia loro oscuro, e che a molti parevano addirittura assurdi. I giovani in questione avevano visto in Zarathustra – erano allora adolescenti appena – un profeta e un capo, e con lo zelo dell’età avevano letto tutto ciò che su di lui si era scritto, ne avevano parlato e riflettuto, durante le loro peregrinazioni per monti e piani, oppure in notturne stanze, al lume della lampada. E Zarathustra ai loro occhi era stato sacro, come per ciascuno del resto diviene cosa sacra quella voce che per prima e con il massimo vigore lo richiama al proprio io e al proprio destino.
Trovarono Zarathustra in un’ampia strada, schiacciato contro il muro da una gran folla, intento ad ascoltare i discorsi che un capopopolo teneva alla massa accalcata dall’alto di un carro. Zarathustra prestava orecchio, sorrideva, osservava i visi dei molti presenti. E li studiava, quei volti, come un vecchio eremita osserva le onde del mare e le nuvole del mattino. Vi leggeva angoscia, vi leggeva impazienza e un infantile, lacrimevole sgomento, ma scorgeva anche il coraggio e l’odio negli occhi dei decisi e disperati, né si stancava di guardare e di ascoltare intanto il blaterio dell’oratore. I giovani lo riconobbero dal sorriso. Zarathustra non era né vecchio né giovane, non aveva l’aspetto né di un maestro né di un soldato, sembrava semplicemente un uomo – un uomo che fosse un attimo prima uscito dall’oscurità del divenire, primo della sua specie.
Fu dunque dal sorriso che lo riconobbero, dopo avere per un po’ dubitato che fosse proprio lui. Ed era un sorriso aperto, non però bonario; Zarathustra era senza malizia, ma anche senza bonarietà. Il suo era il sorriso di un guerriero, e più ancora il sorriso di un vecchio che molto abbia visto e che non tenga ormai in alcun conto il pianto. Fu così che lo riconobbero.
Quando il discorso fu finito e il popolo rumoreggiando cominciò a disperdersi, i giovani si avvicinarono a Zarathustra e lo salutarono rispettosamente.
«Sei qui, maestro» dissero balbettando «finalmente sei riapparso, ora che la miseria è al colmo. Che tu sia il benvenuto, Zarathustra! Ci dirai che cosa dobbiamo fare, ci precederai, ci salverai dal pericolo presente, del quale mai si vide l’uguale.»
Sorridendo Zarathustra li invitò ad accompagnarlo, e strada facendo così parlò agli ascoltatori: «Sono di ottimo umore, amici miei. Già, sono tornato, forse per un giorno, forse per un’ora, e ho assistito alle vostre rappresentazioni teatrali. Per me è sempre stato un vero piacere stare ad assistere a spettacoli del genere. È la cosa in cui gli uomini eccellono maggiormente».
I giovani ascoltavano e si scambiavano occhiate. A loro giudizio, nelle parole di Zarathustra c’era troppa ironia, troppa ilarità, troppa noncuranza. Come poteva parlare di teatro, quando il suo popolo versava in miseria? Come poteva sorridere e divertirsi, ora che la sua patria era vinta e in rovina? Come poteva tutto questo – il popolo, l’oratore, l’ora grave, la solennità, il rispetto di loro stessi, dei giovani – come poteva tutto questo essere per lui null’altro che pascolo per gli occhi e gli orecchi, mero oggetto di osservazione e riso? Non era venuto il momento di piangere lacrime di sangue, di gridare il proprio dolore e di lacerarsi le vesti? E, soprattutto, non era venuta l’ora, l’ora suprema dell’azione? Di compiere imprese? Di dare un esempio? Di salvare il paese e il popolo da sicura rovina?
«M’avvedo» disse Zarathustra che ne avvertiva i pensieri prima ancora che salissero loro alle labbra «che non siete soddisfatti di me, giovani amici. Me l’ero aspettato, e tuttavia ne sono stupefatto. Quando ci si attende qualcosa di simile, ecco che accanto a ciò che si aspetta si trova sempre anche l’opposto; qualcosa in noi aspetta, e qualcosa d’altro in noi spera il contrario. È quanto mi accade con voi, cari amici. Ma dite, non volevate parlare con Zarathustra?»
«Sì, è quello che vogliamo fare» esclamarono tutti bramosi.
Sorrise allora Zarathustra e proseguì: «E allora, miei cari, parlate con Zarathustra, ascoltate Zarathustra! Il quale è qui davanti a voi, e non è un oratore, non è un soldato, non è un sovrano e non è un capo di eserciti: è Zarathustra, il vecchio eremita e buffone, l’inventore dell’ultimo riso, l’inventore di tante ultime tristezze. Da me, amici cari, non potete certo apprendere come si fa a governare i popoli e a riparare le sconfitte. Io non so insegnarvi come si faccia a guidare i greggi e a saziare gli affamati. Non sono queste le arti di Zarathustra. Non sono queste le cure di Zarathustra».
I giovani tacevano, e la delusione allungava i loro volti. Procedevano accanto al profeta, avviliti e sdegnati, e a lungo non trovarono le parole con cui rispondergli. Alla fine uno di loro, il più giovane, parlò, e mentre lo faceva lo sguardo prese a lampeggiargli, e gli occhi di Zarathustra si posarono su di lui con compiacimento.
«Quand’è così» cominciò dunque il più giovane tra i giovani «orsù, dicci quel che hai da dire. Perché se sei venuto soltanto per schernire la miseria del nostro popolo, abbiamo di meglio da fare che non andarcene a spasso con te e ascoltare le tue brillanti battute. Guardaci, Zarathustra: noi tutti, per giovani che siamo, abbiamo servito in guerra, abbiamo visto la morte da vicino, e non siamo più dell’umore di dedicarci a giochi e lieti passatempi. Ti abbiamo venerato, o maestro, ti abbiamo voluto bene, ma più grande dell’amore che ti portiamo è quello per noi stessi e per il nostro popolo. È bene che tu lo sappia.»
Il volto di Zarathustra si illuminò all’udire le parole del giovane, e fissò i suoi, pieni di bontà, addirittura di tenerezza, negli occhi irati dell’interlocutore.
«Amico mio» replicò con il più cordiale dei sorrisi «sapessi quanta ragione hai a non voler accettare a occhi chiusi il vecchio Zarathustra, a volerlo sondare e toccare là dove credi che sia più sensibile! Sapessi quanta ragione hai, mio caro, con la tua diffidenza! E devi anche sapere che hai testé pronunciato parole ottime, di quelle che Zarathustra ascolta più volentieri. Non hai forse detto: “Noi amiamo noi stessi più di quanto amiamo Zarathustra”? Quanto amo, a mia volta, tanta sincerità! Così facendo mi hai adescato, hai preso all’amo me, il vecchio pesce, lo sfuggente, e tra poco penzolerò dalla tua lenza!»
Proprio in quella si udirono giungere, da una strada lontana, spari, alte grida e fragori di lotta, che echeggiavano strani e assurdi nel silenzio della sera. Ed essendosi Zarathustra avveduto che gli sguardi e i pensieri dei suoi giovani accompagnatori correvano a quella volta, quasi fossero lepri, mutò tono di voce. La quale all’improvviso risuonò come per una grande gioia – ed era tale e quale quella di quando ne avevano inteso i primi insegnamenti; sembrava una voce che non uscisse da labbra umane ma scendesse da stelle o dei o, meglio ancora, una voce quale quella che ciascuno in segreto coglie nel proprio cuore, in momenti in cui Dio è in lui.
Gli amici prestarono ascolto, e tornarono a Zarathustra con i loro pensieri e sensi, perché avevano riconosciuto la voce che un tempo, quasi calando da sacre montagne, aveva echeggiato alle loro orecchie nella prima giovinezza ed era parsa tale e quale quella di un dio sconosciuto.
«Ascoltatemi, figlioli» disse Zarathustra rivolgendosi in particolare al più giovane di loro. «Se volete udire il suono di una campana, non dovete battere su un pezzo di latta. E se volete suonare il flauto, non dovete accostare le labbra a un otre di vino. Mi capite, amici? E, miei cari, riflettete, riflettete bene: che cosa era dunque ciò che un tempo, in quelle ore di ebbrezza, avete imparato dal vostro Zarathustra? Eh? Si trattava forse di conoscenze utili per la bottega, per la strada, per il campo di battaglia? Vi ho forse dato consigli adatti a sovrani, vi ho parlato in termini regali oppure borghesi, politici ovvero mercantili? No, ve lo ricordate bene: vi ho parlato in termini zarathustrani, ho parlato il mio linguaggio, mi sono aperto davanti a voi come uno specchio, in modo che poteste scorgere voi stessi. Avete dunque imparato da me “qualcosa”? Sono stato un insegnante di lingue o un maestro di concretezze? Vedete bene, Zarathustra non è un maestro, non si può interrogarlo e apprendere da lui, lui non vi detta ricette, piccole e grandi, buone per casi di emergenza. Zarathustra è l’uomo, è l’io e il tu. Zarathustra è l’uomo di cui andate in cerca in voi stessi, il sincero, l’incorrotto – e dunque come potrebbe trasformarsi in corruttore? Molto Zarathustra ha visto, molto ha sofferto, ha schiacciato molte noci e da molte serpi è stato morso. Ma una sola cosa ha imparato, una sola è la sua sapienza, uno solo il suo orgoglio. Ha imparato a essere Zarathustra. Ed è appunto questo che anche voi volete imparare da lui, anche se tanto spesso ve ne manca il coraggio. Dovete imparare a essere voi stessi, così come io ho imparato a essere Zarathustra. E dovete disimparare a essere altri, a non essere niente, a imitare voci estranee e a ritenere vostre immagini che non lo sono. Sicché, amici miei, quando Zarathustra vi parla, nelle sue parole non cercate sapienza di sorta, non cercate arti, né ricette o abilità, ma soltanto lui stesso! Dalla pietra potete imparare che cosa sia la durezza e dall’uccello che cosa sia il canto. Da me, invece, potete apprendere che cosa sia l’uomo e il destino.»
Intanto, così parlando, erano giunti ai margini della città, e procedettero ancora a lungo tutti insieme all’ombra degli alberi che stormivano nella sera. Molte le cose che gli chiesero, sovente risero con lui, spesso di lui dubitarono. Uno di loro però ha messo per iscritto e conservato, a beneficio dei suoi amici, ciò che Zarathustra quella sera disse loro, o almeno una parte.
Ed ecco quel che costui ha registrato, memore di Zarathustra e delle sue parole.
Del destino
Così ci parlò Zarathustra.
Una cosa è data all’uomo, la quale lo rende dio e gli ricorda che egli è dio: riconoscere il destino.
È per questo che io sono Zarathustra, perché ho riconosciuto il destino di Zarathustra. Perché ho vissuto la sua vita. Pochi riconoscono il proprio destino. Pochi vivono la loro vita. Imparate a vivere la vostra vita. Imparate a riconoscere il vostro destino!
Vi lamentate tanto del destino del vostro popolo. E tuttavia, il destino di cui ci si lamenta non è il nostro, è qualcosa che ci è estraneo e ostile, è un dio straniero e un idolo malvagio che dalla tenebra ci tempesta di destino come con frecce avvelenate.
Sappiate dunque che il destino non viene dagli idoli, e così imparerete anche, una buona volta, che non ci sono idoli né dei! Come nel corpo di una donna il figlio, così il destino cresce nel corpo di ogni essere umano o, se preferite, nel suo spirito o nella sua anima. Sono sinonimi.
E come la donna è tutt’uno con il proprio figlio e ama il proprio figlio, e nulla di meglio conosce al mondo del proprio figlio, così voi dovete imparare ad amare il vostro destino e a non conoscere nulla di meglio al mondo del vostro destino. Esso dev’essere il vostro dio, poiché voi stessi dovete essere i vostri dei.
Colui al quale il destino viene dal di fuori, ne è abbattuto, così come l’animale selvatico è ucciso dalla freccia. Colui al quale il destino viene dall’interno, da ciò che è profondamente suo, ne sarà rafforzato e reso dio. Questo destino ha fatto di Zarathustra Zarathustra, ed esso dovrà fare di te stesso te stesso!
Chi ha riconosciuto il destino, mai vuole mutarlo. Cambiare il destino è un’infantile fatica, per la quale ci si accapiglia e ci si ammazza a vicenda. Voler mutare il destino è quanto si sono sforzati di fare i vostri imperatori e generali, è la fatica cui voi stessi vi siete sobbarcati. Ma che il destino non siate riusciti a mutarlo, è per voi fonte di amarezza; per voi, affermate, ha il sapore del veleno. Se non aveste voluto mutarlo, esso sarebbe caro al vostro cuore come un figlio, l’avreste fatto in tutto e per tutto vostro – e quanto dolce ne sarebbe stato allora il sapore! Un destino subito, che rimanga estraneo, è dolore, veleno, morte. Ogni azione, invece, ogni bene e ogni cosa lieta e procreativa in terra, è destino vissuto, è destino divenuto io.
Prima della vostra lunga guerra eravate troppo ricchi, o amici, troppo ricchi, grassi e ben nutriti, voi e i vostri padri, e quando avete sentito male alla pancia, quello sarebbe stato per voi il momento di riconoscere in quei dolori il destino, di udirne la buona voce. Ma invece voi, figlioli, siete montati in collera per il mal di ventre e vi siete fitti in capo che erano fame e penuria a produrre nei vostri ventri quei dolori. E allora avete fatto guerra per conquistare, per avere più spazio sulla terra, più cibo nel vostro ventre. E adesso che siete tornati a casa e non avete ottenuto un bel nulla di ciò che volevate, rieccovi a lamentarvi, rieccovi a sentire ovunque pena e dolori, rieccovi a cercare il cattivo, il pessimo nemico che vi ha inviato i dolori, rieccovi pronti a sparargli addosso, fosse pure vostro fratello.
Cari amici, non sarebbe buona cosa se rifletteste? E non sarebbe buona cosa se almeno questa volta i vostri dolori li trattaste con maggior rispetto, con maggior interesse, con un coraggio degno di adulti anziché con infantile angoscia e infantili grida? Non potrebbe infatti essere che i lancinanti dolori siano voci del destino, e che divengano dolci se quella voce voi la capite? Non pensate che così possa essere?
Vi odo anche, o amici, lamentarvi di continuo, e a gran voce, di perfidi dolori e perfidi destini che avrebbero colpito il vostro popolo e la vostra terra. Vorrete perdonarmi, giovani amici, se anche nei riguardi di questi dolori mi mostro un tantino diffidente, un po’ lento e restio a prestar loro fede! Tu e tu, e tu, laggiù, voi tutti, soffrite dunque di dolori per il vostro popolo? Soffrite per la vostra patria? Ma dov’è questa patria, dov’è la sua testa, dove il suo cuore, e in qual punto di essa volete cominciare il trattamento e la cura? E come? Ieri era ancora l’imperatore, era l’impero mondiale per cui spasimavate, di cui eravate fieri, che tenevate per sacro. Dove è oggi tutto questo? Non era dall’imperatore che venivano i dolori, altrimenti come potrebbero esserci ancora, ed essere così lancinanti, ora che non c’è più nessun imperatore? A produrli non era l’esercito né la flotta, non erano questa o quella provincia, questo o quel bottino, adesso ve ne rendete conto. Ma perché, visto che i dolori li sentite, continuate oggi ancora a parlare come prima di patria, di popolo e di simili cose, grandi e venerande, di cui si ha un bel parlare, ma che molto spesso inaspettatamente si dissolvono e non ci sono più? Chi è il popolo? È forse l’oratore o coloro che lo stanno ad ascoltare, sono coloro che con lui concordano oppure quelli che gli sputano addosso e lo minacciano con randelli? Li udite, questi colpi laggiù? Dov’è il popolo, il vostro popolo – da che parte sta? Spara o si fa sparare addosso? Attacca o viene attaccato?
Vedete, è difficile capirsi l’un l’altro, e anzi capire se stessi, quando si fa ricorso a così grandi paroloni. E se adesso voi, tu, e tu, avvertite dolori, se avvertite un malessere nel corpo o nell’anima, se siete in preda all’angoscia, se paventate un pericolo, perché dunque non volete, fosse pure soltanto per gioco e per curiosità, una buona, sana curiosità, decidervi al tentativo di formulare altrimenti la domanda? Perché riluttate a vedere se il dolore per caso non abbia sede in voi stessi? Per un certo ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Nota introduttiva
- Non uccidere. Osservazioni politiche
- Non questi toni, amici! Settembre 1914
- A un ministro. Agosto 1917
- Tenacia. Dicembre 1917
- Ci sarà la pace? Dicembre 1917
- Se la guerra dura ancora due anni. Fine del 1917
- Guerra e pace. Estate 1918
- Storia universale. Novembre 1918
- La strada dell’amore. Dicembre 1918
- Non uccidere. 1919
- Lettera a un giovane tedesco. 1919
- Dal «Credo alemanno». 1919
- Il ritorno di Zarathustra. 1919
- A proposito di antisemitismo
- Da un diario del luglio 1933
- Il “Retaggio del tempo” di Ernst Bloch. 1935
- Mosaico di lettere. I 1930-1944
- Fine del diario del Righi. Agosto 1945
- Discorso per le prime ore del 1946. 1945
- Prefazione alla nuova edizione di “Guerra e pace”. 1946
- Una lettera per la Germania. 1946
- Tentativo di giustificazione
- Mosaico di lettere. II 1945-1961
- Cenni bibliografici
- Copyright