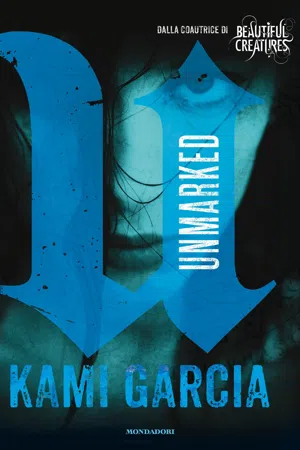Le sbarre erano l’unica cosa che ci separava.
Lui era seduto sul pavimento della cella, appoggiato contro la parete, e aveva solo un paio di jeans addosso. Gettai uno sguardo alla catena che gli teneva i polsi legati. Con la testa china, sembrava esattamente la stessa persona di sempre.
“Ma non lo è.”
Strinsi le dita intorno alle sbarre bagnate. Più volte al giorno, dall’impianto antincendio a soffitto usciva acqua benedetta. Resistetti all’impulso di aprire la porta e farlo uscire.
«Grazie di essere venuta.» Non si era mosso, ma sapevo che non aveva bisogno di vedermi per avvertire la mia presenza. «Nessun altro lo farà.»
«Stanno tutti cercando di capire. Non sanno cosa fare con...» Le parole mi morirono in gola.
«Con me.» Si alzò da terra e venne verso di me, verso le sbarre che ci dividevano.
Mentre si avvicinava, contai gli anelli della catena che gli penzolava tra i polsi. Qualunque cosa pur di evitare di guardarlo negli occhi.
Invece di allontanarmi, però, afferrai le sbarre più saldamente. Lui allungò le braccia e strinse il metallo poco sopra le mie mani.
Senza toccarle, solo vicino.
«No!» gridai.
Dalle sbarre si levò uno sbuffo di vapore, quando l’acqua santa gli ustionò la pelle segnata dalle cicatrici. Lui vi rimase aggrappato troppo a lungo, lasciando di proposito che gli si bruciassero i palmi.
«Non dovresti essere qui» sussurrò. «Non è sicuro.»
Lacrime calde presero a scorrermi sulle guance. Tutte le decisioni che avevamo preso fino a quel momento sembravano sbagliate: le catene strette intorno ai polsi, la cella impregnata di acqua santa, le sbarre che lo tenevano in gabbia come un animale.
«So che non mi faresti mai del male.»
Non fecero in tempo a uscirmi di bocca le parole che Jared si scagliò contro le sbarre, prendendomi per la gola. Feci un salto all’indietro e, mentre sgusciavo fuori dalla sua portata, le dita fredde mi graffiarono la pelle.
«Ti sbagli, piccola colomba.» La sua voce era diversa.
Lo scoppio di risa che riecheggiò sulle pareti mi fece venire i brividi. Capii ciò che tutti gli altri avevano sempre saputo.
Il ragazzo che conoscevo non c’era più.
Quello chiuso in gabbia davanti a me era un mostro.
E io ero la persona che doveva ucciderlo.
Sono davanti all’edificio in fiamme. Lenzuola coperte di cenere penzolano dalle finestre fracassate, fuori dalle stanze in cui ci sono ancora persone intrappolate. Dall’interno, si levano grida che sovrastano il fragore del fuoco e mi fanno accapponare la pelle.
Voglio attraversare il muro di fumo nero per salvarle, ma non riesco a muovermi. Abbasso gli occhi sulla mia mano tremante e capisco il perché.
Sono io che ho il fiammifero in mano.
Scattai a sedere sul letto, con il cuore che batteva all’impazzata.
“Un altro incubo.”
Erano cominciati la notte in cui le pareti della prigione mi erano crollate intorno, e da allora mi tormentavano ogni notte.
Mi premetti le mani sulle orecchie, cercando di mettere a tacere le grida.
“Era solo un sogno.”
Ciò che avevo fatto nella vita reale era ben peggio che dare fuoco a una casa piena di innocenti.
Avevo liberato un demone.
Andras, l’Autore delle Discordie. Un demone che era imprigionato da più di un secolo.
Finché, due mesi prima, non l’avevo liberato e lui aveva ucciso mia madre insieme agli altri membri della Legione della sua età. A giudicare dagli articoli di giornale che raccoglievo in maniera ossessiva, probabilmente da allora aveva ucciso molte altre persone. C’erano giorni in cui ci pensavo meno che in altri.
Ma questo non era uno di quei giorni.
Passai il pomeriggio in biblioteca a leggere articoli e a stampare tabelle e mappe meteorologiche.
All’ora di cena ero già stremata.
Mentre arrancavo nel cortile invaso dal fango, in pochi istanti la pioggia filtrò negli stivali di pelle nera che mia madre mi aveva regalato la sera in cui era morta. Tra la pioggia e le temperature invernali della Pennsylvania, la possibilità di beccarmi una polmonite stava diventando sempre più reale. Ma indossare qualcosa che mi aveva regalato lei era un rischio che valeva la pena di correre.
Altre ragazze con la gonna della divisa e gli opportuni stivali di gomma mi sfrecciavano accanto, schivando le pozzanghere come fossero mine, mentre io non ne mancavo una. Pioveva ininterrottamente dalla notte in cui avevo assemblato il Trasformatore – la chiave paranormale che aveva aperto la gabbia di Andras – e il cielo continuava a sembrare sconvolto, proprio come me.
Come avevo potuto scambiare il Trasformatore per un’arma in grado di distruggere Andras?
I dettagli di quella notte si erano impressi in maniera indelebile nella mia memoria e, come agli incubi, non potevo sfuggirvi.
Io, seduta sul pavimento della prigione, con l’involucro cilindrico del Trasformatore in mano e i dischi sparpagliati tra le gambe. Jared, Lukas, Alara e Priest dall’altra parte della porta della cella, che mi incitavano a metterlo insieme in fretta. La paura paralizzante che mi aveva presa mentre facevo scivolare al suo posto l’ultimo pezzo del congegno.
Era successo diciannove giorni prima.
Diciannove giorni da quando avevo visto i miei amici e sentito il suono della voce di Jared per l’ultima volta.
Diciannove giorni da quando, fuori dalla prigione, ero caduta, e il filo spinato mi aveva lacerato le gambe.
Diciannove giorni da quando mi ero ritrovata al pronto soccorso, con un medico che mi ricuciva le ferite mentre la polizia mi interrogava.
Dopo aver finito, il dottore mi aveva detto in tono di scusa: “Adesso sei rattoppata per bene, ma ti resteranno un po’ di cicatrici”.
Ricordo di aver riso. Le cicatrici provocate dal filo spinato non erano nulla in confronto alle cicatrici emotive che quella notte mi avrebbe lasciato dentro.
Ore dopo, mentre osservavo il temporale che infuriava contro le finestre della mia stanza d’ospedale, avevo udito delle voci fuori dalla porta. Ero riuscita a cogliere solo qualche frammento della conversazione, ma mi era bastato.
“... dei servizi sociali. Ha idea del perché sua figlia sia scappata, signora Waters?”
Una fuga, questa era la storia che avevo raccontato alla polizia.
“Mi chiamo Diane Charles, non Waters. La madre di Kennedy è morta. Io sono la zia.”
“Sua nipote è stata per lo più in una condizione di apatia, signora Charles. Dobbiamo effettuare una valutazione psichiatrica per determinare lo stato mentale di Kennedy prima di poterla dimettere e dargliela in affidamento.”
“In affidamento a me?” La voce di zia Diane si era alzata. “Quando ho accettato di diventare sua tutrice legale, Kennedy era una studentessa brillante che non era mai finita nei guai. Non so minimamente in quale faccenda sia andata a invischiarsi, ma non voglio che la porti dentro casa mia, di qualunque cosa si tratti. E se scappasse di nuovo?”
“Capisco la sua preoccupazione, ma lei è l’unica parente...”
“L’unica che siete in grado di rintracciare!” era sbottata zia Diane. “Avete almeno provato a cercare suo padre?” Il fatto che mia zia fosse disposta a lasciarmi nelle mani di un uomo che non vedevo da dodici anni metteva in chiaro quanto lei non mi volesse.
Abbassando la voce, aveva proseguito: “Io e la madre di Kennedy non eravamo legate. Mia sorella aveva dei problemi che ha evidentemente trasmesso alla figlia, e mi dispiace moltissimo. Ma io non sono attrezzata per gestire un’adolescente fuori controllo”.
In una qualsiasi altra notte, mi sarei fiondata in corridoio e avrei massacrato mia zia a parole per avere insultato mia madre. Ma su di me aveva ragione, anche se non sapeva quale fosse il vero motivo. Permettermi di vivere con lei sarebbe stata una condanna a morte.
“Non deve affrontare tutto da sola” aveva detto l’assistente sociale. “Ci sono programmi studiati per gli adolescenti a rischio. Case famiglia, collegi...”
La mattina seguente, zia Diane aveva accampato una manciata di scuse patetiche. “Voglio solo ciò ...