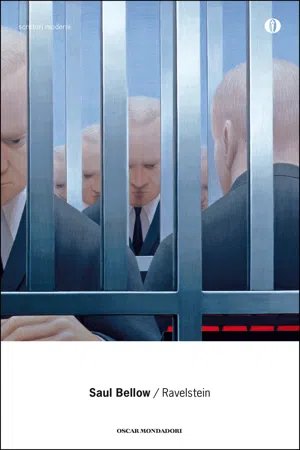Non è strano che i benefattori dell’umanità siano persone divertenti? In America, almeno, spesso è così. Chi vuole governare questo Paese lo deve divertire. Durante la Guerra civile la gente si lamentava delle facezie di Lincoln. Ma forse lui sentiva che l’eccessiva serietà era di gran lunga più pericolosa di qualunque barzelletta. I suoi detrattori, invece, dicevano che era frivolo, e lo stesso ministro della Guerra lo paragonava a una scimmia.
Tra i demistificatori e i dissacratori che hanno formato il gusto e lo spirito della mia generazione, il più illustre era H.L. Mencken. I miei compagni di liceo, lettori dell’«American Mercury», seguirono il processo Scopes leggendo le sue cronache. Mencken fu molto duro con William Jennings Bryan, con la Bible Belt e il Boobus Americanus.1 Clarence Darrow, il difensore di Scopes, rappresentava la scienza, la modernità e il progresso. Per Darrow e Mencken, Bryan il Creazionista era un’inevitabile assurdità della Farm Belt. Nel linguaggio dell’evoluzionismo, Bryan era un ramo secco dell’albero della vita. Il suo monometallismo argenteo era uno scherzo. Così pure la sua oratoria da parlamentare d’altri tempi, e i lauti pasti del Nebraska campagnolo che divorava. Che furono, dice Mencken, la sua morte. Le sue ipotesi sulla Creazione Speciale furono ridicolizzate al processo e Bryan fece la stessa fine dello pterodattilo. Goffa versione di un’idea che si affermò più tardi: rettili striscianti diventati uccelli a sangue caldo che volavano e cantavano.
Ho riempito un taccuino con le citazioni di Mencken, e più tardi ne ho aggiunte altre di dissacratori o autodissacratori come W.C. Fields o Charlie Chaplin, Mae West, Huey Long e il senatore Dirksen. C’era anche una pagina sull’umorismo di Machiavelli. Ma non voglio annoiarvi con le mie elucubrazioni sullo spirito e sull’autoironia nelle società democratiche. Non temete. Sono lieto che il mio vecchio taccuino sia sparito. Non ho alcun desiderio di rivederlo. Viene a galla brevemente come una specie di lunga nota a piè di pagina.
Ho sempre avuto un debole per le note a piè di pagina. Più di un testo, secondo me, è stato riscattato da un’intelligente o perfida nota a piè di pagina. E vedo che io stesso sto ora approfittando di una lunga nota a piè di pagina per affrontare un argomento piuttosto serio mentre mi sposto, con rapida mossa, a Parigi, in un attico dell’Hôtel Crillon. Primi di giugno, ora di colazione. L’anfitrione è il mio buon amico Ravelstein, il professor Abe Ravelstein. Mia moglie e io, pure al Crillon, abbiamo la stanza di sotto, al quinto piano. Mia moglie dorme ancora. L’intero piano sotto il nostro (un dettaglio che non ha la minima importanza, ma per un motivo o per l’altro non posso evitare di dirlo) è occupato, in questo preciso momento, da Michael Jackson e dal suo entourage. Ogni sera si esibisce in un vasto auditorium parigino. Presto arriveranno i suoi fan francesi e una distesa di facce guarderanno in su, urlando all’unisono: Maikéll Sciaksón. Un cordone di agenti trattiene i suoi ammiratori. Dentro, dal quinto piano, abbassando lo sguardo sulla scala di marmo, vedi le guardie del corpo di Michael. Una sta facendo il cruciverba dello «Herald Tribune» di Parigi.
«Fantastico, no?, trovarsi mescolati a questo circo pop» ha detto Ravelstein. Era molto felice, stamane, il professore. Aveva ottenuto dalla direzione di farsi assegnare questa suite tanto agognata. Essere a Parigi, al Crillon! Essere qui, una volta tanto, con un mucchio di quattrini. Basta con le stanze puzzolenti del Dragon Volant, o come lo chiamavano, in rue du Dragon; o dell’Hôtel de l’Académie in rue des Saints-Pères, davanti alla facoltà di Medicina. Non esiste un albergo più splendido o più lussuoso del Crillon, dove stavano gli alti papaveri dell’esercito americano durante le trattative di pace dopo la Prima guerra mondiale.
«Forte, no?» ha detto Ravelstein, con uno dei suoi gesti repentini.
Ho annuito. Il centro di Parigi era proprio sotto di noi: Place de la Concorde con l’obelisco, l’Orangerie, la Chambre des Députés, la Senna con i suoi ponti sfarzosi, palazzi, giardini. Certo, queste erano cose belle da vedere, ma oggi erano ancora più belle, oggi che a mostrarcele dal suo attico era Ravelstein, che solo l’anno prima aveva debiti per centomila dollari. Centomila e forse più. Ricordo che scherzava con me sul suo “fondo di ammortamento”.
«Ci sto affondando insieme» diceva. «Sai cosa significano queste parole nei circoli finanziari, Chick?»
«Fondo di ammortamento? Vagamente.»
Prima che Ravelstein diventasse ricco, nessuno aveva mai criticato il suo bisogno di vestiti Armani o di borse Vuitton, di sigari cubani introvabili negli Stati Uniti, di accessori Dunhill, di penne Mont Blanc d’oro massiccio o di bicchieri Baccarat o Lalique nei quali servire il vino o farselo servire. Ravelstein era uno di quei grandi uomini – grandi, non grossi – ai quali tremavano le mani quando doveva dedicarsi a piccole attività che richiedevano fermezza e precisione. La causa non era la debolezza, ma un’ardente e formidabile energia che quando si scaricava lo scuoteva tutto.
Ebbene, i suoi amici, colleghi, discepoli e ammiratori non dovevano più allentare i cordoni della borsa per pagargli quelle lussuose abitudini. Grazie a Dio, ora poteva farlo senza bisogno di complicati baratti in argenteria Jensen o Spode o Quimper tra i suoi amici accademici. Tutto questo apparteneva al passato. Ora Ravelstein era ricchissimo. Si erano fatti conoscere, lui e le sue idee. Aveva scritto un libro – difficile, ma di larga diffusione –, un libro vivace, intelligente, bellicoso, che si era venduto e si vendeva ancora in entrambi gli emisferi e da ambo le parti dell’equatore. La cosa era stata fatta in fretta, ma con la massima serietà: niente facili concessioni, né volgarizzazioni, né furbizie da intellettuale, né contrizioni, né arie aristocratiche. Ravelstein aveva tutto il diritto di avere l’aspetto che aveva in quel momento, mentre il cameriere ci serviva la colazione. Il suo intelletto lo aveva reso milionario. Non è una cosa da poco diventare ricchi e famosi dicendo esattamente quello che si pensa: e dicendolo con le proprie parole, senza compromessi.
Quel mattino Ravelstein indossava un kimono bianco e azzurro. Gli era stato regalato in Giappone, l’anno prima, quando vi aveva tenuto un ciclo di conferenze. Gli avevano chiesto se c’era qualcosa che gli avrebbe fatto particolarmente piacere ricevere e lui aveva risposto che avrebbe gradito un kimono. Questo, adatto a uno shogun, doveva essere stato confezionato apposta per lui. Ravelstein era altissimo, e non particolarmente aggraziato. L’ampio indumento non era allacciato bene e rimaneva quasi del tutto aperto sul davanti. Le gambe di Ravelstein erano straordinariamente lunghe e sproporzionate. Le mutande gli erano scivolate sotto l’ombelico.
«Il cameriere dice che Michael Jackson non vuole mangiare il cibo del Crillon» osservò. «Il suo cuoco lo accompagna dappertutto sul suo jet privato. Comunque, lo chef del Crillon si è offeso. La sua cucina andava abbastanza bene per Richard Nixon e Henry Kissinger, dice, e per un gran numero di scià, re, generali e Primi ministri. Ma questa prestigiosa scimmietta la rifiuta. Non c’è qualcosa nella Bibbia a proposito dei re con mani e piedi mutilati che vivono sotto la tavola del conquistatore, cibandosi degli avanzi caduti per terra?»
«Credo di sì. Ricordo che gli avevano amputato i pollici. Ma che cosa c’entrano il Crillon o Michael Jackson?»
Abe rise e disse che non lo sapeva. Gli era solo venuto in mente. Lassù le voci acute dei fan – adolescenti parigini, ragazzi e ragazze che urlavano all’unisono – si aggiungevano al rombo di autobus, camion e taxi.
Questo scenario storico era il nostro sfondo. Ce la stavamo spassando davanti alle nostre tazze di caffè. Ravelstein era euforico. Ciononostante parlavamo a bassa voce perché Nikki, il compagno di Abe, dormiva ancora. Nikki aveva l’abitudine, negli Stati Uniti, di guardare film di kung fu della natia Singapore fino alle quattro del mattino. Anche lì passava quasi tutta la notte alzato. Il cameriere aveva chiuso le porte scorrevoli per non disturbare il suo serico sonno. Di tanto in tanto, dalla finestra, guardavo le sue braccia tonde e le ciocche dei lunghi capelli neri che gli arrivavano alle spalle lisce. A trent’anni compiuti da poco, il bel Nikki era ancora un ragazzo.
Il cameriere era entrato portando fragoline di bosco, brioche, vasetti di marmellata e piccoli esemplari di quella che da giovane mi avevano insegnato a chiamare «argenteria alberghiera». Ravelstein scarabocchiò freneticamente il suo nome sul conto mentre addentava una ciambellina. Dei due, il più educato a tavola ero io. Quando Ravelstein mangiava e parlava, avevi l’impressione di assistere a qualcosa di biologico: era come se alimentasse l’organismo per nutrire le proprie idee.
Quel mattino era tornato a insistere che dovevo uscire dal guscio, allontanarmi dalla vita privata, interessarmi – per usare le sue parole – «alla vita pubblica, alla politica». Voleva che provassi a scrivere una biografia, e io avevo accettato. Su sua richiesta avevo steso un breve riassunto del resoconto stilato da J.M. Keynes sulle discussioni intorno alle riparazioni tedesche e alla rimozione del blocco alleato nel 1919. Ravelstein era contento del risultato, ma non pienamente soddisfatto. Pensava che avessi un problema di retorica. Io sostenevo che dare eccessiva enfasi ai fatti togliesse all’opera il suo interesse più generale.
Tanto vale sputare il rospo: al liceo avevo un insegnante d’inglese di nome Morford – “Morford il Matto” lo chiamavamo – che ci fece leggere il saggio di Macaulay sul Johnson di Boswell. Se fosse un’idea di Morford o rientrasse nel programma stabilito dalla Commissione scolastica non lo so. Il saggio di Macaulay, scritto su incarico dell’Encyclopædia Britannica nel diciannovesimo secolo, era stato pubblicato in America come libro di testo dalla Riverside Press. La sua lettura mi appassionò. Macaulay mi divertì immensamente con la sua versione della Vita, con l’“anfrattuosità” della mente di Johnson. Da allora ho letto molte critiche assennate degli eccessi vittoriani di Macaulay. Ma non sono mai guarito, né ho mai voluto guarire, dal mio debole per lui. Grazie a Macaulay vedo ancora il povero Johnson toccare convulsamente ogni lampione della strada e mangiare pudding rancidi e carne avariata.
Il problema era diventato questo: che linea adottare nello scrivere una biografia? C’era l’esempio stesso di Johnson nei suoi mémoirs dell’amico Richard Savage. C’era Plutarco, naturalmente. Quando parlai di Plutarco con un grecista, me lo demolì sostenendo che era «un semplice littérateur». Ma senza Plutarco sarebbe stato possibile scrivere Antonio e Cleopatra?
Presi poi in considerazione le Brief Lives di Aubrey.
Ma non starò a farvi tutto l’elenco.
Avevo cercato di descrivere il signor Morford a Ravelstein. Morford il Matto non era mai del tutto sbronzo durante la lezione, ma si vedeva che era un alcolizzato: aveva una faccia rossa da ubriacone. Portava tutti i giorni lo stesso vestito comprato alle svendite stagionali. Non voleva conoscerti, e da te non voleva essere conosciuto. Il suo sguardo triste, assente, da alcolista, non prendeva di mira mai nessuno. Sotto il ciglio arruffato puntava quello sguardo solo sui muri, o fuori dalle finestre, o sul libro che stava leggendo. Le due opere che abbiamo studiato con lui quel trimestre erano il Johnson di Macaulay e l’Amleto di Shakespeare. Malgrado la scrofola, la cenciosità, l’idropisia, Johnson aveva le sue amicizie e scriveva i suoi libri proprio come Morford teneva le sue lezioni, ascoltandoci quando recitavamo a memoria i versi che dicono: «Come sembrano sterili e ammuffite e piatte le abitudini di qui!». L’arcigna testa rapata, la faccia rubizza, la mano agganciata dietro la schiena. Del tutto ammuffite e piatte.
Ravelstein non mostrò molto interesse per la mia descrizione di lui. Perché lo invitavo a vedere il Morford dei miei ricordi? Ma Abe fece bene a segnalarmi il saggio di Keynes. Keynes, il potente statista-economista che tutti conoscono per Le conseguenze economiche della pace, spediva agli amici di Bloomsbury lettere e memorandum sulla propria esperienza postbellica, in particolare le discussioni sulle riparazioni tra i tedeschi sconfitti e i leader alleati: Clemenceau, Lloyd George e gli americani. Ravelstein, uomo nient’affatto prodigo di elogi, disse che questa volta avevo scritto un eccellente compendio delle note di Keynes agli amici. Come economista, Ravelstein stimava Hayek più di Keynes. Keynes, sosteneva, aveva esagerato sulla durezza degli alleati e fatto il gioco dei generali tedeschi e, in definitiva, dei nazisti. La pace di Versailles fu di gran lunga meno punitiva di quanto avrebbe dovuto essere. Le mire belliche di Hitler nel 1939 non erano diverse da quelle del Kaiser nel 1914. Ma, a parte questo grave errore, Keynes personalmente aveva moltissime attrattive. Educato a Eton e Cambridge, era stato socialmente e culturalmente ingentilito dal gruppo di Bloomsbury. Era cresciuto e si era perfezionato con la Grande Politica del suo tempo. Immagino che in privato si considerasse un “uraniano”: eufemismo britannico per omosessuale. Ravelstein osservò che Keynes aveva sposato una ballerina russa. Mi spiegò inoltre che Urano aveva generato Afrodite, ma che lei era senza madre. Era stata concepita dalla schiuma del mare. Diceva queste cose non perché ritenesse che io ne fossi ignaro, ma perché pensava che prima o poi avrei avuto bisogno di dedicarvi i miei pensieri. Così mi rammentò che quando Urano era stato ucciso dal titano Crono il suo seme si era sparso nel mare: tutto questo c’entrava, in qualche modo, con le riparazioni, o col fatto che i tedeschi, ancora sottoposti al blocco, stavano morendo di fame proprio allora.
Ravelstein, il quale per ragioni sue mi aveva fatto scoprire il saggio di Keynes, ricordava soprattutto le pagine che descrivevano l’incapacità dei banchieri tedeschi di soddisfare le richieste di Francia e Inghilterra. I francesi miravano alle riserve auree del Kaiser e volevano che l’oro fosse consegnato immediatamente. Gli inglesi dicevano che si sarebbero accontentati della moneta. Uno dei negoziatori tedeschi era ebreo. Lloyd George, perdendo l’autocontrollo, se la prese con quest’uomo e gli giocò un brutto tiro facendo, davanti a lui, una straordinaria parodia dell’ebreo: curvò la schiena, quasi si acquattò, zoppicò, sputò, pronunciò la esse come se fosse una zeta, sporgendo il deretano e camminando con i piedi piatti e rivolti all’infuori. Tutto questo Keynes lo descrisse agli amici di Bloomsbury. Ravelstein non aveva una buona opinione degli intellettuali di Bloomsbury. Non amava la loro affettazione e disapprovava le loro stravaganze da checche e quel loro – diceva – «comportarsi da finocchi». Non poteva e non voleva biasimarli per i pettegolezzi. Lui stesso amava troppo i pettegolezzi per poterselo permettere. Diceva, però, che non erano dei pensatori ma degli snob, e che la loro influenza era perniciosa. Le spie poi reclutate in Inghilterra dalla GPU o dall’NKVD negli anni Trenta erano state formate da Bloomsbury.
«Ma tu, Chick, l’hai descritta proprio bene, l’indecente parodia di Lloyd George dello youpin.»
Youpin, in francese, significa “giudeo”.
«Grazie.»
«Non vorrei essere troppo invadente» disse lui. «Ma forse converrai che sto cercando di aiutarti.»
Naturalmente comprendevo le sue ragioni. Voleva che scrivessi la sua biografia, e al tempo stesso voleva strapparmi alle mie perniciose abitudini. Mi ...