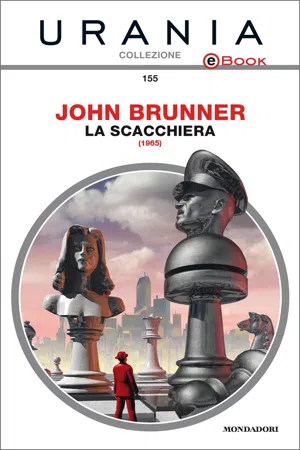Durante il volo dalla Florida, sull’aereo attaccai discorso con il mio vicino di posto o, per essere più esatti, fu lui per primo a rivolgermi la parola. Era un europeo di mezz’età, ebreo, la cui famiglia era stata costretta a fuggire per salvarsi dall’invasione nazista, al principio della Seconda guerra mondiale. Ma sebbene fosse molto fiero del suo accento europeo, al punto di ricordarmi almeno una dozzina di volte “Avrà notato il mio accento, naturalmente!” non mi riuscì di stabilire il suo esatto luogo d’origine.
Da quattro anni non faceva ritorno “in patria”, e sembrava anzi che avesse passato molto più tempo negli Stati Uniti che nell’Aguazul, ma senza dubbio amava fervidamente il suo paese d’adozione. Insisteva nel rivolgersi alla hostess in uno spagnolo atroce, peggiore del mio, benché su quella linea tutto il personale parlasse altrettanto correntemente l’inglese, lo spagnolo e il portoghese.
E quando l’aereo virò sul campo per atterrare lui quasi mi si arrampicò addosso nel tentativo di indicarmi, attraverso il finestrino, tutti i punti interessanti di Vados.
Alla fine la hostess gli ordinò severamente di allacciarsi la cintura. Dopodiché, fui in grado di chiudere la mente, se non le orecchie, contro le sue enfatiche descrizioni.
Mi astenni dal dirgli (sarebbe stato molto scortese) che, pur non avendo mai messo piede a Vados, senza dubbio su quella città ne sapevo più di lui. Sapevo che, una decina di anni prima, avevano scelto un’estensione di terra nuda e rocciosa e avevano decretato che vi sorgesse una nuova capitale. Avevano costruito strade, incanalato selvaggi torrenti di montagna entro condotti di cemento, trasportato generatori di energia solare sulle alture circostanti, un po’ a dorso di mulo, un po’ con gli elicotteri, nei punti dove neppure i muli riuscivano ad arrivare. Ora, Vados era una fiorente città di mezzo milione di abitanti.
Inoltre ne avevo studiato la struttura essenziale, che si era sviluppata organicamente partendo da quattro grandi piazze e da tre principali arterie di traffico: superstrade elevate a sei corsie, che facevano capo ad Astoria Negra e a Puerto Joaquin, sulla costa, e a Cuatrovientos, il centro petrolifero su cui si basava fondamentalmente la ricchezza dell’Aguazul, e quindi di Vados.
Ma, osservandola nella sua realtà mentre l’aereo scendeva verso l’aeroporto ricavato nel fianco del monte, avvertii un po’ l’eccitazione del mio vicino di posto. Non avevo mai visto niente, credo, di così compiutamente “ventesimo secolo”.
“Dieci anni fa” mi dicevo “qui non c’erano che deserto, roccia, sterpaglia. E adesso, guarda lì!” Mi sentii percorrere da un brivido di ammirazione, e la mia faccia dovette tradire quei sentimenti, perché il mio vicino di posto fece un risolino.
— Magnifico, vero? — disse, sogghignando soddisfatto, quasi toccasse a lui il merito di quelle guglie aggraziate, di quegli splendidi viali, di quei parchi rigogliosi.
Magnifico, sì. Però... Se quello che riluceva fosse stato tutto oro, io non sarei stato lì. Esitai, incerto se dargli spiegazioni oppure no, e alla fine non dissi niente.
Quando ci salutammo, alla dogana, il mio compagno di viaggio volle assolutamente stringermi la mano e lasciarmi il suo biglietto da visita. Il cognome era Flores, e c’erano due indirizzi: uno di New York, in Madison Avenue, e l’altro di Vados.
Flores. “Blum”? Chissà. “Rosenblum”? Forse. Con gli anni, il suo tanto vantato accento europeo si era come addolcito, fino a perdere le sue caratteristiche e a diventare cosmopolita.
Era combattuto tra il desiderio di continuare a decantare la sua patria di adozione con me che ero straniero, e la necessità di prendere posto nella fila dei residenti, alla dogana, facendo così valere i suoi diritti di nazionalità. Alla fine, quest’ultima ebbe la meglio. Prima che ci separassimo, m’indicò con la mano un ritratto collocato in modo non appariscente, ma ben visibile, alle spalle dei funzionari della dogana.
— Grand’uomo, quello! — disse con importanza. — L’uomo dal quale prende nome la città, naturalmente. “El Presidente” Vados!
A quanto sembrava, ero l’unico straniero arrivato con quel volo, e la precedenza veniva data alla gente del luogo. Mi diressi verso una panca, sul lato opposto della sala, accesi una sigaretta, disponendomi ad aspettare.
La sala era tranquilla, grazie alle pareti rivestite di materiale isolante; sebbene all’esterno il sole battesse infuocato sulle piste di cemento grigio, là dentro faceva fresco. La luce penetrava attraverso le veneziane verdi, e non una sola mosca ronzava nell’aria immobile. A quelle latitudini, era senza dubbio un risultato.
Per ammazzare il tempo, mi misi a osservare il ritratto. M’interessava l’uomo che, ancora vivo, aveva dato il suo nome a una capitale. Per di più, sia pure indirettamente, era il mio nuovo datore di lavoro. Ufficialmente avrei dovuto rispondere del mio operato al consiglio municipale, ma Vados era sindaco della città, oltre che presidente della repubblica, e in consiglio, dicevano, si faceva esclusivamente quello che voleva lui.
Il ritratto, che, naturalmente, non aveva didascalia, mostrava “el Presidente” in un semplice abito bianco. Una sottile cravatta nera sembrava dividere il suo petto in due metà esatte. Il corpo massiccio aveva un portamento eretto e militaresco, impressione rafforzata dall’alta statura. Era stato fotografato mentre fissava dentro l’obiettivo per cui, mentre sedevo là, a studiarlo, provavo l’impressione che fissasse me. Era una foto ben fatta, addirittura parlante. La faccia sembrava pallidissima, in contrasto con i baffetti neri e i capelli scuri e lisci. Vados aveva tra le mani un bastone da passeggio dal pomo dorato, e lo reggeva come se volesse torcerne in direzioni opposte le due estremità e farne una spirale.
Juan Sebastian Vados. Un uomo fortunato, astuto. E un grand’uomo, così si era espresso Flores. Un individuo brillante, senza dubbio: da più di vent’anni, ormai, reggeva le sorti di Aguazul, e il risultato di quei vent’anni erano la prosperità e il benessere, per non parlare di Ciudad de Vados, il capolavoro della sua amministrazione.
Mi accorsi che era il mio turno. Gettai la sigaretta in una vaschetta di sabbia e mi diressi al banco della dogana. Un facchino fece rotolare i miei bagagli su un nastro trasportatore fino all’altezza del funzionario che mi aveva fatto cenno di avvicinarmi. Il funzionario era un uomo olivastro, dalla severa uniforme nera con i gradi in argento; le sue dita erano scolorite dal gesso azzurro che usava per stampigliare il visto sulle valigie dei viaggiatori.
Diede una scorsa alla lista dei passeggeri e disse in tono annoiato: — Quiere Ud. decirme su nombre?
— Boyd Hakluyt — dissi io, ed estrassi di tasca il passaporto. — Habla Ud. inglés?
Posò il gomito sul banco, la mano tesa. — Sì. Americano?
— No, australiano, ma sono stato per un certo periodo negli Stati Uniti.
Studiò perplesso il mio passaporto australiano. Probabilmente era il primo che vedeva. — E che cosa ha portato il señor nell’Aguazul? — domandò come se fosse sinceramente interessato alla cosa. — Turismo, sì?
Mentre prendeva il mozzicone di gesso azzurro per vistare i miei bagagli, gli feci notare che, al contrario, dal giorno seguente avrei preso servizio a Vados.
Socchiuse le palpebre. La mano che stringeva il gesso si fermò a mezz’aria. — Ah, sì? E qual è la professione del señor?
— Sono un analista del traffico — risposi. — Specializzato in problemi quali, per esempio, come fare muovere le auto più in fretta lungo strade particolarmente battute, come impedire alla folla di bloccare le uscite nelle stazioni delle metropolitane...
Assentiva, impaziente. — Yo comprendo — scattò, nemmeno avessi lasciato capire di considerarlo poco dotato mentalmente. — E che cosa fa qui a Vados?
— Dovrò studiare un problema di traffico, appunto, e suggerire una soluzione.
Era la verità e, mentre lo dicevo, avvertivo nuovamente un fremito di soddisfazione: Ciudad de Vados era una vera pietra di paragone in fatto d’ultramodernità, per quanto riguardava l’urbanistica e l’analisi del traffico. Essere scelto per migliorare quello che già rasentava la perfezione rappresentava un po’ il coronamento trionfale di una carriera.
Naturalmente, apportare miglioramenti era divenuto possibile, ormai: erano passati dodici anni da quando i piani erano stati approvati, e in dodici anni si erano fatti altri progressi. In particolare, neppure i calcolatori più perfetti del mondo potevano eliminare tutte le pecche da un piano di viabilità: la sperimentazione diretta era il solo modo d’individuare eventuali difetti. E tuttavia...
Il funzionario sembrava sbalordito almeno quanto me. Ma disponeva di un modo per uscire dal dubbio. Gettò il gessetto in aria e lo riacchiappò, come per tagliare la testa al toro. — Dovrò esaminare i suoi bagagli, señor Hakluyt.
Sospirai, domandandomi che cosa l’avesse indotto a cambiare idea. Ma l’esperienza mi aveva insegnato che si perde meno tempo a non sollevare obiezioni. Così dissi soltanto: — Tutto quello che ho con me è mia proprietà personale. Ho consultato apposta il vostro consolato di Miami per essere sicuro di non portare niente che fosse vietato.
— Puede ser — disse lui, senza compromettersi, e prese le chiavi delle valigie.
Quello che soprattutto l’insospettì, durante l’ispezione, fu la quantità di vestiario che avevo portato con me. Non era possibile, andava ripetendo, che avessi bisogno di tanta roba; e io a spiegare fino alla noia che, soggetto a spostamenti com’ero, durante il lavoro, avevo bisogno di tutto se volevo essere sempre decente.
— Allora il señor Hakluyt è un uomo molto ricco? — insisté lui, mutando la sua linea di attacco.
Resistendo alla tentazione di rispondere per le rime, scossi la testa.
— Il señor non è ricco, eppure ha tanto bagaglio — disse ancora lui, quasi sottoponendo a se stesso un paradosso filosofico. — Vuole dirmi, il señor, quanto sarà pagato per il lavoro che farà a Vados?
Era troppo. — Crede proprio che questo la riguardi? — ribattei.
Scoprì i denti, con il fare di un giocatore che mostra un quinto asso. Da quell’istante avvertii per lui una profonda antipatia. — Forse il señor Hakluyt non si rende conto che sono un funzionario di polizia — disse mellifluo. — Ma lo sono... ed è perciò illegale rifiutarsi di rispondere a una mia domanda.
Cedetti. — Sarò pagato ventimila dolaros, più le spese.
Chiuse l’ultima delle mie valigie, tracciò su tutte una croce col gesso azzurro. Poi si spolverò le dita come se stesse spazzando via qualcosa di più di un po’ di polvere di gesso. — C’è da sperare, allora, che il señor sia generoso, con il suo denaro. Forse è questa la ragione per cui non è già un uomo ricco.
Girò sui tacchi e si allontanò.
L’ispezione aveva preso tanto tempo che anche l’ultimo torpedone dell’aeroporto era ormai partito per il centro della città. Nel mio spagnolo stentato, convinsi un facchino a cercarmi un taxi; e a caricarvi i miei bagagli. Nell’attesa, andai a cambiare alcuni dollari americani per rifornirmi di dolaros: fruscianti, nuove banconote rosse e gialle recanti l’effige del presidente, nominalmente alla pari col dollaro statunitense, ma con un valore di acquisto effettivo pari a ottantacinque cents. Rappresentavano un monumento a uno dei primi grandi risultati conseguiti da Vados: la riforma monetaria, portata a termine fin dal primo anno del suo avvento al potere. Si diceva che avesse chiamato dollaro la sua nuova unità monetaria nella speranza che diventasse valuta pregiata quanto il corrispettivo nordamericano; già l’essersi avvicinato a quell’obiettivo costituiva, per un paese latinoamericano, una specie di miracolo.
Al momento di dare la mancia al facchino, mi ricordai dell’osservazione del funzionario e, a scopo sperimentale, diedi all’uomo due dollari. Aspettai una reazione, ma inutilmente. Probabilmente venivo giudicato alla stregua di un turista incapace di dare un valore alla moneta locale, forse perché inconsciamente convinto che non fosse denaro vero. Tentai di dimenticare l’intera faccenda.
Tuttavia, solo quando la vettura prese a scendere dal monte dov’era costruito l’aeroporto riuscii veramente a non pensarci più. La strada descriveva una curva ampia per addolcire la discesa e, poiché l’aria era limpida e il sole splendeva vivido, avevo su tutta l’area una perfetta veduta a volo d’uccello. Riuscivo a distinguere perfino Puerto Joaquin, a una sessantina di chilometri di distanza, simile a una macchia scura nel punto dove la terra confinava con l’oceano.
Ma, dopo un’occhiata superficiale, smisi di fissare in lontananza. Ero troppo affascinato da Ciudad de Vados che si stendeva giù in basso.
La città aveva qualcosa d’impressionante che nessuna mappa o planimetria riusciva a convogliare. Ora che non c’era Flores a distrarmi, obbligandomi a guardare questo e quello, ero in grado di assorbire tutta la magnificenza dell’insieme.
In un certo senso, era difficile definire come coloro che avevano progettato quella città erano riusciti a darle una vitalità organica simile a quella di una gigantesca macchina. Vi si avvertiva una potenza tenuta a freno, che prometteva fervore d’attività. Al tempo stesso quella potenza era uguagliata da una perfezione funzionale che era sinonimo di economia, semplicità, unità senza uniformità. In sostanza, era tutto quello che gli urbanisti idealisti avessero mai sperato.
Dissi all’autista di fermarsi un momento al margine della strada e scesi a guardare giù dall’orlo di uno sperone, attraverso l’aria tersa. Riconoscevo a colpo d’occhio quasi tutto quello che vedevo: là, la zona residenziale, più in là il centro degli affari, più in là ancora gli uffici governativi, e poi i parchi, i musei, il teatro dell’opera, le quattro grandi piazze, i viadotti sormontati dalle super-autostrade.
Fantastico. In superficie, almeno, non una grinza.
Mi fermai sulla sporgenza rocciosa, il tempo di fumare mezza sigaretta, poi risalii nel taxi e dissi all’autista di portarmi in città. Mentre scendevamo rapidamente, io continuai a fissare fuori del finestrino.
Poi, qualcosa si parò tra il finestrino e il panorama, e io girai la testa appena in tempo per vedere una specie di capanna parcheggiata... non sembrav...