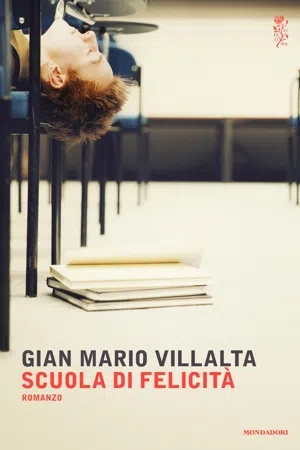Cosa fa un insegnante quando non fa lezione? Si lamenta. Ma no! Ha una quantità di cose da fare. Quando non deve tornare a scuola nel pomeriggio perché c’è la Riunione di Dipartimento, o il Consiglio di Classe, il Collegio Docenti, gli Scrutini, la Commissione per i Libri di Testo, la Commissione per le Prove Comuni, la Commissione per la Qualsivoglia, il Ricevimento Generale, i Recuperi, gli Sportelli o i Corsi di Preparazione (di che? di tutto: Olimpiadi di Matematica, Certificazione della Lingua, Certamen Ciceroniano, Gare di Atletica Regionali…). Quando non deve tornare a scuola per un qualsiasi dannato motivo, un insegnante fa una di queste due cose: 1) si adopera per colmare il divario tra il suo presunto ceto di appartenenza e il suo reale stipendio (un secondo lavoro, ripetizioni private, la cura della casa e dei figli invece di pagare altri per farlo; oppure investe in relax, salute e ginnastica in cambio dell’analista, del fitness club e dei viaggi che non si può permettere); 2) corregge compiti, prepara lezioni, compila registri, ma soprattutto perde un pacco di tempo (in telefonate, uscite inutili, internet) affinché correggere compiti, preparare lezioni e compilare registri diventi un lavoro esasperante e infinito.
Io no. Ho sposato una donna ricca. Quanto ricca l’ho scoperto cinque anni fa, dopo che è morta e mi sono ritrovato suo unico erede.
Quando ho rimesso un po’ di ordine nella mia vita, dopo la mazzata e lo sbando della «disgrazia» (così l’hanno sempre chiamata gli altri), sono stato tentato di licenziarmi, ma poi ho scoperto che la routine forzata dell’insegnamento mi forniva una specie di corrimano con il quale aiutarmi, gradino dopo gradino, a risalire. Così ho passato i due anni più difficili. In seguito ho chiesto una riduzione di orario, per avere un giorno libero in più (e una classe in meno). E poi, soprattutto, mi dedico a una mia passione: la ricerca filosofica. Mi tiene occupata la mente. E c’è una signora a tempo pieno, regolarmente assunta, che tiene in ordine la casa.
All’inizio faceva la spesa e mi preparava anche i pasti. Poi ho capito che non sto a tavola volentieri con una persona in piedi che aspetta i miei comandi. E la spesa la so fare da me. Così abbiamo concordato gli orari dei suoi impegni in modo che, più libera lei, sono diventato più libero anch’io. Adesso abbiamo raggiunto quasi la perfezione: lei viene quando sono a scuola e ci incontriamo sì e no una volta alla settimana, per definire le strette necessità e approvare le sue proposte.
Mia madre e mio padre stanno in Germania, in buona salute, ma lontani da sempre. Da quando ero bambino li sento ripetere che presto chiuderanno la gelateria e torneranno a casa. Dicono ancora “casa”, hanno quasi ottant’anni e sono via da sessanta, è ridicolo. Mi hanno cresciuto i nonni, i genitori di mia madre. Sono vissuti abbastanza a lungo, dopo che me ne sono andato. E anche poi, quando andavo a trovarli o telefonavo, ho continuato a rivolgermi a mia nonna chiamandola “màa”.
Dopo un anno dall’inizio dell’insegnamento ho incontrato Francesca, che è diventata tutta la mia vita. Non sentivo il bisogno di altri legami. Considerato l’inizio, la lunga solitudine dell’infanzia e della prima giovinezza, si sarebbe potuto pensare che avrei trovato difficoltà nel legarmi a qualcuno. Invece con Francesca ero felice. Frequentavamo delle persone, ma non era una necessità. Ci bastavamo. Anzi, eravamo di più.
Subito dopo la morte di Francesca sono andato a vivere in un albergo. Poi ho comprato la casa dove abito, molto bella, non grandissima, con il giardino. Ho smesso di fare tutto quello che facevo da consorte di una donna che aveva un posto di rilievo nel ranking sociale di questa città di provincia. A tutti quelli che mi dicevano che dovevo “rifarmi una vita” ho sempre risposto che non me l’ero fatta io da solo, la vita che avevo prima, e quindi non avrei saputo come e che cosa “rifare”. Poi ho smesso di cercarli, e loro di cercare me.
E scrivo.
L’unica volta che ho fatto vedere i risultati del mio impegno a un conoscente, un piccolo editore, perché me l’ha chiesto lui, mi ha risposto che sono “assolutamente fuori mercato”. Non si è più fatto vivo. E non mi dispiace. Se verrà, e quando verrà il momento, se ne avrò voglia, pubblicherò la mia opera omnia come piacerà a me.
Prima che iniziassero certe complicazioni, e il susseguirsi degli eventi, veloce e frastornante, mi coinvolgesse senza lasciarmi la mente libera per riflettere, ero rassegnato al fatto che ormai dall’insegnamento non mi sarebbe arrivato più niente, se non la soddisfazione di fare bene il mio lavoro.
Vedevo Giuliani, timido e serio, con un gran ciuffo di capelli sul viso ostinato, portare sempre con sé la chitarra dentro una pesante custodia nera. Giuliani, sempre corretto ma privo di carisma, che si lasciava prendere da rabbie improvvise e soffocate. Non era bravo a suonare, lo sapevano tutti. Portava quell’ingombrante custodia nera come una croce, un macigno a cui aggrapparsi, una scatola dove contenere e difendere una parte di sé.
Vedevo Giuliani e mi interessava soltanto che facesse bene nelle mie ore di lezione, si comportasse correttamente e fosse incoraggiato dai risultati.
Vedevo Biasotto, Santarossa, la Giggì (Gigliola De Marchi) sempre debordante dai vestiti troppo stretti, vedevo Raffo, vedevo Popa. Mihail Popa, rumeno, arrivato in Italia a nove anni, formidabile traduttore dal latino, lo vedevo diventare sempre più sicuro del suo italiano e questo mi gratificava. Vedevo anche The Pop – così chiamavo Mihail – inseguire con le sottomarche dei discount la moda e i vezzi dei suoi compagni, sempre sorridente, salvo arrossire all’improvviso per qualcosa che veniva detto là, nel branco, e io non riuscivo a intercettare. Così come vedevo che Samantha Ragagnin ricattava i compagni per farsi passare le versioni e offrirsi al posto suo quando era l’ora di interrogare. La vedevo fingere tragedie e svenimenti, tentare qualsiasi faticoso espediente pur di evitare quello studio che le sarebbe costato meno impegno. Ma Samantha Ragagnin metteva ordine in classe, faceva da paciere, negoziava tra i diversi gruppetti le soluzioni più facili e utili per tutti.
Vedevo nascere e finire amicizie, vedevo la paura di non essere all’altezza negli occhi di qualcuno di loro a inizio di ogni ora.
Ma il mio compito era far sì che tutto andasse bene, che imparassero a leggere e disporre della loro lingua per iscritto quanto bastava, come dicevo spesso, a “indirizzare una lettera al sindaco senza doversene vergognare”.
Erano troppo lontani dalla mia età, dal mondo che potevo comprendere, dai desideri che li accendevano a lampi intermittenti. Anzi, mi disgustavo a volte, perché ritenevo che fossero in totale ostaggio delle smanie istantanee dei media. Di più, credevo che di veri desideri fossero del tutto incapaci, e patissero solamente l’esaltazione per un’ultima novità dopo l’altra, inghiottiti nel vespaio brulicante dei legami virtuali e della music.
Parevano calati da chissà dove in un mondo senza passato, indifferenti a tutto ciò che non era l’ultima aspirazione di tutti. Non era possibile altra sintonia, per me, che non fosse quella concreta e condivisibile del compito ben fatto, della nozione appresa con certezza. Per ottenere questo mi impegnavo, cercavo di capire meglio la loro situazione di vita, le loro capacità e i loro caratteri. Al di là di tali confini non osavo procedere e non provavo il desiderio di farlo.
Per queste ragioni, quando ci furono i primi segnali delle agitazioni in arrivo, non ero affatto preparato.
Un giorno ho sentito, senza intenzione (ero appoggiato alla colonna dell’atrio mentre facevo “sorveglianza”), uno dei miei studenti dire: «Quello, dopo la morte della moglie, è andato in pezzi. Un mio cugino, che ce l’ha avuto, mi ha raccontato di com’era prima. Adesso gli interessa soltanto portare in fondo la lezione. Sarà bravo, e giusto, come dicono, ne sa a pacchi di tutto, però viene in classe per fare la sua ora di teatro e poi non c’è più».
Ho fatto scivolare con calma la schiena sul lato opposto della colonna e mi sono allontanato senza voltarmi.
Questi sono gli studenti: ti tagliano al vivo gli abiti indosso.
E allora eccomi qui seduto nel mio studio, dopo che ho finito di raccontare una mattinata più o meno normale di scuola quotidiana, proprio quella mattinata, quando per la prima volta ho percepito che per alcuni dei miei studenti stava succedendo qualcosa. Che cosa? Forse niente. A volte si hanno delle sensazioni, dei presentimenti, che poi se ne vanno. Se mi sono ricordato di quella mattina è forse per via dei ciliegi selvatici e della sorpresa che avevano creato: un evento inatteso che aveva lasciato un po’ scoperti, un po’ fuori ruolo, Giani, la Pigotta e Bedin.
Adesso direi che avrei potuto accorgermi di qualcosa già in precedenza dai loro discorsi, certo, ma soprattutto c’era in quei giorni una nuova calma, una serietà, quasi che qualcuno di loro fosse cresciuto di due o tre anni all’improvviso. Anche un senso di superiorità. Ma sbaglio a chiamarlo così. Sarebbe meglio dire, se non fosse già rivelare qualcosa, che si percepiva il segno di una esperienza che li faceva credere speciali. Anzi, li vedevo diventare speciali. Ecco, è proprio questo. Qualcosa di intenso e di – perché no? – luminoso. E come si mostrava? Da un gesto, da un particolare dell’abbigliamento: quando, per esempio, fuori da ogni moda accettata, la Pigotta ha cominciato a portare un fazzoletto colorato, quello che un tempo era detto “tabaccone”, annodato al collo. Le stava così bene, quel colpo di colore sul viso pallido, spigoloso, ma con le labbra piene e gli occhi bellissimi, che nella scuola ha fatto moda. Oppure dalle poche parole di intesa, dalle domande che facevano, anche da questo, certo, percepivo segni, indizi. Ma, dopo averci pensato bene, posso dire che sarebbe stato tutto abbastanza normale, succede sempre che ci pare di capire o di indovinare qualcosa, crediamo di poter afferrare quello che sta accadendo, ci immaginiamo di entrare in sintonia con la costruzione del loro mondo, e poi ci sfugge, tutto diventa un’interrogazione, un voto, una cena di fine anno scolastico. Sarebbe rimasto tutto dentro lo scatolone dei dieci mesi di scuola passati insieme, come ogni anno, se una sera Giani non mi avesse chiamato dopo le undici per chiedermi aiuto.
«Prof, sono Tommaso…»
«Sì?»
«Giani, sono Giani.»
«Sì, Giani, dimmi.»
La voce tratteneva una concitazione, o una preoccupazione, qualcosa che non voleva tradire. Respirava forte.
«Prof, abbiamo bisogno che ci venga a prendere, c’è Gianluca che sta male.»
«Bedin? Avete chiamato i suoi?»
«Prof, sto chiamando lei.»
«Se è grave è meglio un’ambulanza, vi raggiungo all’ospedale.»
«Prof, se non vuole non importa…» Delusione nella voce, stizza.
«Non hai capito, non sono un medico… dove siete?»
«Sulla strada di Val di Croda, sopra Budoia. Trecento metri sotto lo Chalet.»
«… Ci vorrà mezz’ora, minimo.»
«Fa niente. Per favore… aspettiamo.»
Ho detto che stavo partendo.
Questo avveniva circa tre settimane dopo l’“epifania dei ciliegi selvatici”.
È stato un anno difficile e convulso per la mia scuola, questo 2013-14.
Eh già!, a scuola il conto degli anni procede così: 2011-12, 2012-13, 2013-14… come per il campionato di calcio. L’anno comincia a settembre. E finisce con luglio.
Fosse per me, Ferragosto sarebbe il giorno perfetto per festeggiare il Capodanno.
Tutta la vita che io mi ricordo l’ho passata andando scuola. E poi, come dico a volte in una battuta, “non sono mai stato veramente promosso”. Per chi lo capisce, è solo un esempio di come l’esperienza dell’insegnante sia particolare: per tutti gli altri, la scuola resta dentro quel forziere di tentativi, fantasie e costrizioni che è l’inizio dell’esistenza, e finire i cinque anni di superiori, o l’università, significa cominciare quella che si ritiene la propria vita vera. Per me, in quei primi anni Ottanta, quando fiorivano nuove cattedre e piovevano supplenze annuali, finire gli studi ha voluto dire iniziare un nuovo anno scolastico.
Dicevo che è stato un anno complicato, per prima cosa da un dato oggettivo, prima temuto e poi certo: il crollo delle iscrizioni. L’allarme è arrivato, a inizio di anno, in coincidenza con il cambio di Dirigenza, che ha portato effetti imprevedibili e imbarazzanti. Poi c’è stata l’adozione obbligatoria del registro elettronico. In seguito è esploso il caso Dicidomine, grazie al quale siamo finiti su tutti i giornali e la Bardella, la nuova Dirigente, è andata in tivù per difendere il buon nome dell’Istituto. Poi tutto il resto.
Ma è meglio andare con ordine, per quanto possibile.
La prima ragione di un Collegio Docenti straordinario è stata la perdita di due classi prime, a causa delle mancate iscrizioni, e la prospettiva che la situazione sarebbe peggiorata nella stagione successiva.
Nei dieci anni precedenti tutti volevano studiare in un li...