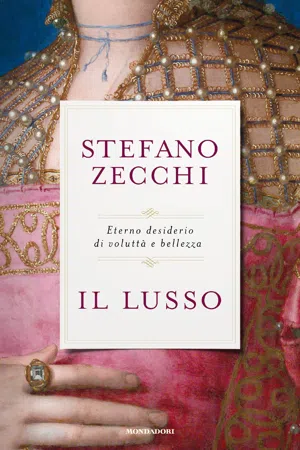L’origine magica
Consideriamo il lusso generalmente come qualcosa di materiale, oggetti, creazioni di ogni tipo, con cui si cerca di esprimere bellezza. Ma non è sempre stato così. La sua origine è lontanissima, si perde nella notte dei tempi e spiega bene quale sia la sua caratteristica simbolica, una qualità che anche oggi gli si dovrebbe riconoscere.
Appartiene alla natura dell’uomo conservare ciò che è prezioso, tesaurizzarlo e affidare a questo «tesoro» il messaggio per raccontare il suo senso della vita e per ricordare, col trascorrere delle epoche, la cultura di una civiltà che ha creato bellezza, che l’ha amata e lasciata in eredità affinché non venisse dispersa la propria identità. Ciò spiega l’origine immateriale del lusso, la sua radice rituale, magica, religiosa, e nel contempo consente di comprendere che, separato dalla sua origine cultuale e immateriale – come spesso accade nella storia, soprattutto nella nostra modernità –, esso perde il suo autentico significato, cadendo facile preda delle critiche moralistiche.
Nei suoi studi di antropologia, in particolare nel Saggio sul dono, uscito per la prima volta in Francia nel 1923-24 sulla prestigiosa rivista «L’Année sociologique», Marcel Mauss ha illustrato come nelle società primitive il lusso venisse associato al dono, che rappresentava simbolicamente e concretamente lo strumento essenziale per lo scambio cerimoniale. Il lusso è dono, non è possesso: dunque, un’idea opposta a quella di accumulazione di beni di valore. Quando il capo della tribù si trovava a dover dare prova del suo prestigio e del suo potere in competizione con il capo di un’altra tribù, gli faceva un dono molto importante, perché attraverso quel dono tanto suntuoso intendeva testimoniare la propria grandezza. Ma, a sua volta, chi lo riceveva, sia come alleato sia come eventuale avversario, non poteva dimostrarsi inferiore. Ecco allora che lo contraccambiava con qualcosa di più grande, dal valore chiaramente superiore. Ma il capo tribù, che per primo aveva offerto il dono, ora, ricevendone uno più importante del suo, si sentiva sfidato e replicava facendone uno ancora superiore. Lo scambio non finiva qui, perché la sfida tra i capi tribù continuava attraverso regali che cercavano di gareggiare e oltrepassarsi in valore.
Questo scambio cerimoniale ha delle regole perfettamente rispettate, un cerimoniale tramandato da un’immutabile tradizione, che in nessun caso può essere interpretato come una forma di commercio o un qualunque altro genere di traffico mercantile: esso rispecchia un rituale magico e simbolico, che può portare perfino alla dissoluzione materiale della ricchezza di una tribù. E infatti, nelle società del potlatch, come appunto vengono chiamate queste comunità che praticano lo scambio rituale del dono, il capo può arrivare allo sperpero dei beni del villaggio al solo scopo di mostrarsi più potente del rivale.
Basandosi sulle ricerche di Mauss e di Bronisław Malinowski, che nell’opera Argonauti del Pacifico occidentale (1922) aveva illustrato come in Melanesia, nelle isole Trobriand, avvenisse un particolare scambio simbolico di doni, il kula, il filosofo Georges Bataille, nel suo famoso libro La Part maudite (1949), ha sostenuto nel modo più convincente come il potlatch sia la manifestazione originaria del lusso, che sovverte ogni regola dell’economia di mercato: il valore non è nell’accumulazione ma nella dissipazione, la ricchezza non è nel possesso ma nella privazione. Con la sua vertiginosa fantasia, Bataille arriva a ipotizzare una società anticapitalista che ha nel potlatch il proprio fondamento per superare le disuguaglianze economiche e le differenze sociali. Attraverso il concetto di potlatch si definirebbe così un nuovo ordine di potere, in cui il comando è assegnato non a chi è in grado di accumulare ricchezze ma a chi è in grado di dissiparle.
Se mettiamo da parte la visione economico-sociale di Bataille e riprendiamo la questione relativa all’origine del lusso, osserviamo che grandi antropologi, non soltanto Malinowski e Mauss, ma, per esempio, anche Franz Boas o Claude Lévi-Strauss, hanno dimostrato che il dono è un lusso che si manifesta attraverso uno scambio cerimoniale in cui è essenziale la perdita, la dissipazione di ciò che ha valore.
Innanzitutto, considerare la ritualità del dono come un’origine del lusso significa rifiutare la tesi secondo la quale esso sia qualcosa di superfluo dal punto di vista della vita di una comunità, o un’entità economica in eccesso, che non costituisce nessuna necessità e nessun bisogno per l’economia di un gruppo sociale. Il lusso, in questa arcaica concezione di «sperpero suntuario», trasforma la materialità del dono in un’idea magica e, analogamente, la ricchezza e il prestigio politico, che da essa conseguono, diventano simbolici e immateriali.
In secondo luogo, il concetto di lusso-dono cancella dall’uomo quel sentimento (o tendenza) naturale – assolutamente prevedibile e comprensibile per il modo in cui oggi pensiamo e viviamo il benessere e la ricchezza – che lo porta a possedere e conservare ciò che gli è utile e necessario.
Si può supporre che le ricerche sul dono di quei grandi antropologi, da Mauss a Malinowski, siano confinate in epoche così lontane da rivestire soltanto un interesse culturale: una convinzione che porta fuori strada e non fa riflettere con sufficiente attenzione su quanto lo scambio simbolico e suntuario del dono, che dissipa ricchezza per dimostrare prestigio sociale, lasci invece le sue tracce nella storia di tutte le civiltà del pianeta. Si pensi al significato rituale di un suntuoso banchetto per festeggiare un importante avvenimento come un matrimonio o una nascita, in cui non è dominante il rapporto tra persona e cose ma la relazione sociale che s’instaura attraverso il rito cerimoniale. Il dono-lusso «oltrepassa» l’oggetto, mette in ombra la materialità del rapporto tra persona e cosa, essendo la sua funzione quella di celebrare (o esaltare) il valore della relazione tra persona e persona, tra persona e comunità, a cui è estrinseca, nell’occasione, l’accumulazione della ricchezza.
L’orafo Cardillac, nel racconto di Hoffmann, avrebbe condiviso quest’idea originaria del lusso che apparteneva alle tribù primitive del potlatch: le cose preziose non devono mai essere considerate beni di scambio economico. Per quelle tribù esse avevano un significato simbolico, magico, rituale; per l’orafo Cardillac possedevano il valore incommensurabile di un’originaria bellezza nata dal genio di un artista, e nessun prezzo avrebbe potuto minimamente rispecchiarne il valore. Non vi è una grande differenza di pensiero tra le tribù del potlatch e Cardillac: tempi, culture, sentimenti diversi concordano nel rifiuto di laicizzare il senso del lusso, perché ciò comporterebbe l’annullamento di qualsiasi idea «sacrale», immateriale, dei suoi oggetti, ed è proprio l’incapacità di cogliervi questo mondo di significati, intrecciati alle ritualità di scambio del dono, che confina il lusso in una dimensione esclusivamente venale.
Malinowski ha illustrato come alcune popolazioni melanesiane scorgessero nelle cose di grande valore forme viventi pervase da un potere spirituale; e Marcel Mauss ci ha spiegato attraverso i suoi studi che gli indiani del Nordovest americano credevano che monili rari dalle dimensioni particolari racchiudessero il potere di rendere invisibili i capi tribù che li indossavano. Una magia, tuttavia, che aveva un termine preciso, perché quei monili non potevano trasmettere «per sempre», a chi li portava, la forza segreta della loro magia: essi avrebbero continuato a irradiare quel loro potere, ma solo a una condizione, quella di essere donati ad altri o distrutti.
L’oggetto eccezionale, lussuoso, non è soltanto un dono che conferisce prestigio, autorevolezza, potere, ma possiede come sua fondamentale funzione quella di stabilire un contatto tra mondo terreno e mondo spirituale. L’oggetto lussuoso si smaterializza, assume un significato magico nelle tribù primitive; oggi, se inteso correttamente, si svincola dal valore economico, testimonia il senso di una civiltà che rifiuta di essere considerata soltanto per la quantità materiale prodotta, che non accetta l’idea di cultura, in cui il valore è stimato attraverso la cosa misurabile, calcolabile, con un costo di realizzazione e un prezzo di vendita.
Troppo elementare intendere in modo materialistico e deterministico il lusso come un eccesso di ricchezza prodotto dai modelli economici e dai sistemi di mercato che si sono succeduti nella nostra società; il lusso, nella sua originaria visione, è avvolto da una concezione religiosa che, nel tempo, si trasforma e diventa pensiero metafisico di un oggetto di grande qualità, creato dalla genialità dell’artigiano. Una metafisica che fa passare in secondo piano sia la stessa materialità che costituisce l’oggetto, sia il prezzo che ne consente il possesso. Il lusso diventa magia moderna della bellezza assoluta che si fa cosa, che si fa comportamento, stile, che si fa pensiero, ereditando l’antica, millenaria idea del dono suntuario che animava la vita delle tribù del potlatch.
La classicità
Nel passaggio dalla visione magica del lusso a quella razionale della filosofia classica greca, in particolare di Platone e Aristotele, incomincia a delinearsi quell’idea convenzionale di intendere il lusso che arriva fino ai giorni nostri. Abbiamo già avuto l’occasione nel precedente capitolo di accennarne i temi essenziali che lo condannavano con un giudizio morale. Riprendendoli con maggiore attenzione, osserviamo che le tesi sono semplici e così ben argomentate da costituire una base di riflessione molto difficile da mettere in discussione. Il lusso viene associato al superfluo, a ciò che non è necessario né alla vita della polis, né a quella della famiglia. Questo concetto viene trattato in particolare nel II libro della Repubblica, in cui Platone spiega l’origine della formazione della polis. Essa nasce e si sviluppa «perché ciascuno di noi non basta a se stesso» (369b); ci sono bisogni (kreia) comuni: «il primo e maggior bisogno è quello di provvedersi il nutrimento per sussistere e vivere … Il secondo è quello di provvedersi l’abitazione, il terzo il vestito e simili cose» (369c). La polis ha le proprie origini nella necessità, tema fondamentale per comprendere il significato del lusso, e «il suo nucleo essenziale sarà composto da quattro o cinque persone … L’agricoltore, il muratore, il tessitore, il calzolaio» (369d-e). Ognuno di loro metterà a disposizione la propria abilità, la propria techne, e ciò comporterà l’ampliamento dello spazio delle necessità: l’agricoltore avrà bisogno del fabbro che gli costruisca l’aratro, il muratore di un carpentiere… La techne svilupperà le figure professionali necessarie innanzitutto alla sopravvivenza della polis, e poi alla sua crescita. Queste figure opereranno nell’ambito delle proprie competenze, rimanendo tuttavia entro il limite dei bisogni necessari alla vita della polis, perché l’andare oltre è lusso, è corruzione. Il contenimento dei bisogni in ciò che davvero è utile ai cittadini definisce una caratteristica essenziale della giustizia. Giustizia, nella polis, è il perimetro di ciò che è necessario. «Questa è la polis vera… una polis sana» (372e), cioè quella che prospera nella corretta relazione tra il necessario, i bisogni reali, il rifiuto del superfluo.
L’obiezione a questa visione della polis è pronunciata da un personaggio che Platone introduce nel suo libro affinché, dialogando con Socrate, provi a metterlo in difficoltà, replicando alle sue idee. Glaucone, infatti, ritiene che lo stato di necessità, considerato da Socrate il fondamento della città virtuosa, sviluppi una «polis di porci» (372d), in cui si vive dello stretto necessario, mangiando ciò di cui si ha esclusivamente bisogno e adoperandosi solo per garantire la sussistenza del porcile. Nella replica a Glaucone, Socrate introduce il concetto di lusso: egli interpreta quella critica non soltanto come un’obiezione al modello di costruzione virtuosa della polis, rispettosa delle necessità, ma come la volontà di affermare il diritto alla trasgressione del limite – appunto quello imposto dalle oggettive necessità di vita all’interno della città – e pretendere «una polis gonfia di lusso» (399a).
Una concezione, questa, che associa immediatamente, e senza possibilità di trovare delle eccezioni, l’idea di lusso alla corruzione e alla cura necessaria per la «purificazione», cioè per la sua abolizione. La cura è l’educazione: per esempio, per quanto riguarda i soldati, si tratta di formarli a una vita rigorosa e rispettosa delle assolute necessità di sopravvivenza per escludere tutte quelle opportunità che porterebbero alla corruzione morale e fisica. I soldati hanno il compito di salvaguardare la polis e l’incolumità dei suoi cittadini: una vita nel lusso li renderebbe fiacchi, incapaci di difendere innanzitutto se stessi e, quindi, non idonei a svolgere il loro compito. Il lusso rende effeminati e codardi. In greco, la parola coraggio (andreia) e la parola uomo (andra) hanno la stessa radice: il lusso, disgregando l’uno (il coraggio), degenera l’altro (l’uomo).
Nella polis descritta da Platone, deve essere estirpato come una malattia o corretto come una dannosa deviazione dell’anima ciò che genera i desideri superflui, quelli che non sono necessari a soddisfare i reali bisogni della collettività. Il lusso si manifesta come un sopravvento del desiderio sulle reali necessità di vita della polis, che è virtuosa soltanto nella moderazione, qualità etica essenziale conseguibile se i suoi bisogni sono prestabiliti e rappresentano una norma uguale per tutti. Ma ciò non significa che i desideri siano banditi, che possano essere soffocati nel cuore delle persone. Essi sono inestirpabili, ma non vanno tra loro confusi. A tal fine, Platone distingue tra desideri necessari e non necessari (558-61): i primi, fondamentali, si riconoscono perché la loro soddisfazione reca immediati vantaggi alla comunità, non essendo superflui. Per chiarire questa tesi, Platone associa in una stessa relazione concettuale la «necessità» alla «natura», osservando che è la nostra natura a soddisfare i desideri necessari, nel senso che essi appaiono necessari proprio perché a soddisfarli sono esigenze naturali, bisogni reali e vitali.
Platone porta come esempio il desiderio di cibo, uno dei tre bisogni fondamentali (gli altri due sono la casa e gli abiti) che consentono la genesi stessa della polis. Ma desiderio non necessario diventa il cibo in sovrabbondanza, non richiesto da una sana condotta di vita, dannoso sia al corpo sia alla mente. Mentre i desideri necessari non si possono sopprimere, quelli inutili sono eliminabili attraverso la cura, attraverso l’educazione che insegna a riconoscere i veri bisogni di cui vive e con cui cresce la polis.
Tuttavia è interessante osservare che, pur in questa chiara analisi platonica sulla forma dei desideri, emerge proprio nel secondo libro della Repubblica una sottintesa valutazione positiva anche dei cosiddetti desideri non necessari. Infatti, nonostante il lusso sia una cosa negativa associata al superfluo, alla corruzione, alla degenerazione femminea dell’uomo, al degrado della convivenza sociale, tuttavia esso esprime l’incontenibile dinamismo di quei desideri umani (quelli designati come non necessari) che non si possono confinare nella semplice e immediata relazione bisogno-soddisfazione. Questa insaziabilità dei desideri non necessari richiede un convinto progetto educativo per correggere l’umana tendenza all’eccesso, e una programmata responsabilità politica per limitare e contenere le esuberanze del desiderio che portano a un’esistenza lussuosa, pericolosa per la vita della polis.
Se dunque il lusso va condannato, nelle stesse parole di Platone, pur permanendo il giudizio negativo, si registra un’apertura: esse sottolineano, anche, che il lusso è una presenza ineludibile nella vita dei cittadini, una presenza che per essere adeguatamente fronteggiata e ridimensionata esige un’idea di eticità che stabilisca una relazione dialettica con il lusso stesso e non presuma di estirparlo dai sentimenti dell’uomo. Proprio questa dialettica, in cui compaiono in modo contraddittorio i desideri necessari e quelli superflui, continuerà a essere presente nella nostra cultura.
Per Aristotele la polis non è il prodotto di un accordo tra uomini, non è la conseguenza di un contratto sociale: essa è naturale, e la natura di ogni cosa è la sua stessa essenza (Metafisica V.4). «La comunità perfetta di più villaggi costituisce la città, che ha raggiunto quello che si chiama il livello dell’autosufficienza: sorge per rendere possibile la vita e sussiste per produrre le condizioni di una buona esistenza» (Politica 1252 b). La «buona esistenza» è identificata con una vita autosufficiente: la contemplazione è la forma di vita più autosufficiente che si possa raggiungere, e a questa condizione, che è valore sommo, si deve conformare la polis. Come Platone, anche Aristotele sottolinea il contrasto tra una comunità che si basa su bisogni necessari e quella che, incline al lusso, è desiderosa di vivere nell’inessenziale. Aristotele tuttavia critica l’idea di Platone secondo il quale la polis si sia formata per una condizione di necessità e non per realizzare il «sommo bene».
La divergenza tra i due filosofi sui principi che costituiscono la polis è importante per capire quale significato Aristotele attribuisca al lusso. La vera ricchezza, egli afferma, consiste nell’avere mezzi sufficienti per una «buona esistenza», e tutto ciò che è necessario a tal fine deve essere considerato un compito dell’uomo, in particolare del politico (1257 b). La nozione di vita lussuosa contrasta con quella di «buona vita naturale» per l’uso illimitato dei mezzi da essa richiesti, assolutamente non necessari per una «buona esistenza»: l’accumulazione di ricchezze non solo è contraria alla natura, ma porta a travisare anche il senso di ciò che è vera ricchezza.
«Luxus». Il lusso nell’epoca di Roma
Nella celebre Lettera XC di Seneca, diretta al suo giovane allievo Lucilio, il filosofo mette in guardia dai pericoli generati dalla passione per le nuove tecniche, artes ludicrae, «arti» che tendono a modificare tradizioni e costumi di vita con soluzioni «tecniche» in grado di agevolare l’esistenza, rendendola più gradevole e comoda. Tra le nuove «arti» erano divenuti molto popolari i sistemi di riscaldamento delle case attraverso la circolazione di aria calda, ma nuova arte era anche la lavorazione di marmi impiegati soprattutto per le finitur...