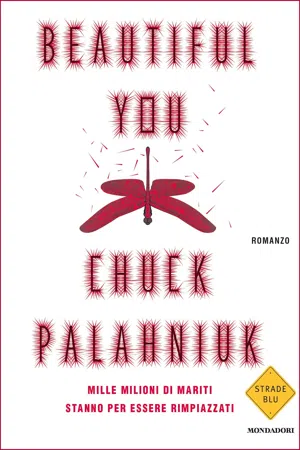Benché Penny stesse subendo un’aggressione, il giudice restò a guardare. La giuria indietreggiò. I giornalisti presenti si fecero piccoli piccoli. Nessuno in aula intervenne a difenderla. Lo stenografo continuò scrupolosamente a digitare sulla tastiera per mettere a verbale le parole di Penny: “Qualcuno mi aiuti, mi sta facendo male! Fermatelo, vi prego!”. Quelle dita efficienti trascrissero un “No!”. Poi una lunga onomatopea mugolante, gemente, urlante, seguita da un elenco delle invocazioni di Penny.
Le dita pigiarono sui tasti un “Aiuto!”.
Poi un “Basta!”.
Le cose sarebbero andate diversamente se in tribunale ci fossero state altre donne, ma di donne non ce n’erano. Negli ultimi mesi tutte le donne erano come sparite. Erano totalmente scomparse dalla scena pubblica. Gli spettatori della disperata resistenza di Penny – il giudice, i giurati, il pubblico – erano tutti maschi. Un mondo di soli uomini.
Lo stenografo digitò: “Ti prego!”.
Poi ancora: “Ti prego, no! Non qui!”.
A parte lui, Penny era l’unica a muoversi. Aveva i pantaloni scompostamente abbassati alle caviglie. Le cose di sotto erano state strappate per mostrarla a chiunque avesse il coraggio di guardare. Lei mulinava le braccia e le gambe nel tentativo di sfuggire. Seduti in prima fila i disegnatori ufficiali cercavano con tratti rapidi di rendere il suo brancolare alle prese con l’aggressore, con gli indumenti laceri sventolanti e i capelli ingarbugliati che sferzavano l’aria. Alcune mani esitanti si levarono tra il pubblico, tutte armate di cellulare per una foto furtiva o qualche secondo di filmato. Tutti gli altri sembravano pietrificati dalle grida di lei, dalla sua voce straziata che riecheggiava in quel vasto spazio altrimenti silenzioso. Non era neanche più il grido di una sola donna che veniva stuprata; quello che risuonava come in un vortice di suoni distorti era il grido di nove, dieci donne che venivano aggredite. Di un centinaio. Il mondo intero stava urlando.
Sul banco dei testimoni, Penny opponeva resistenza. Si sforzava in ogni modo di chiudere le gambe e di scacciare il dolore. Sollevò la testa per cercare lo sguardo... di chiunque. Un tale si prese la testa tra le mani, tappandosi gli orecchi, e serrò le palpebre avvampando in faccia come un bambino spaventato. Penny guardò il giudice, che sospirò partecipe ma si guardò bene dall’usare il martelletto per ripristinare l’ordine. Un piantone chinò la testa e mormorò alcune parole nel microfono che aveva appuntato al petto. Con la pistola nella fondina, passava nervosamente da un piede all’altro, trasalendo a ogni grido di Penny.
Altri sbirciavano contegnosi l’orologio o un SMS, come se si vergognassero per lei. Come se lei non dovesse strillare e sanguinare in pubblico. Come se quell’aggressione e quelle sofferenze fossero colpa sua.
Gli avvocati parevano rattrappirsi nei loro costosi gessati. Si fingevano occupati a scartabellare. Persino il fidanzato di Penny era immobile, a bocca aperta, totalmente incredulo di fronte a quella violenza bruta. Qualcuno doveva aver chiamato un’ambulanza, perché due infermieri arrivarono di corsa lungo il corridoio centrale dell’aula.
Tra i singhiozzi, dimenandosi per autodifesa, Penny cercò di non perdere i sensi. Se solo fosse riuscita ad alzarsi in piedi, avrebbe potuto scavalcare il banco e tentare la fuga. L’evasione. Il tribunale era affollato come un autobus all’ora di punta, ma nessuno che bloccasse il suo aggressore o cercasse di trascinarlo via. I presenti, anzi, avevano fatto uno o due passi indietro e continuavano ad arretrare il più possibile verso le pareti, lasciando lei e il suo stupratore in un vuoto sempre più vasto, nella parte anteriore dell’aula.
Gli infermieri si fecero largo tra la calca. Non appena le furono accanto, Penny, boccheggiante e agitata, ebbe una crisi di nervi, ma quelli riuscirono a calmarla, dicendole di rilassarsi. Che era al sicuro. Il peggio era passato lasciandola raggelata, madida di sudore, in preda a brividi di spavento. Da ogni parte, muri di facce, rivolte verso punti in cui gli sguardi non potessero incrociare altri sguardi colmi della loro stessa vergogna.
Gli infermieri la sistemarono su una barella, e uno dei due stese una coperta sul suo corpo tremante, mentre l’altro allacciava le cinghie di sicurezza. Solo a quel punto, il giudice batté il martelletto a dichiarare sospesa la seduta.
L’infermiere addetto alle cinghie domandò: «Sai dirmi che anno è?».
Penny si sentiva la gola riarsa, infiammata a furia di gridare. La voce le uscì rauca, ma l’anno era quello giusto.
«Sai dirmi il nome del presidente?» domandò l’infermiere.
Penny stava quasi per rispondere “Clarissa Hind”, ma si trattenne. La presidente Hind, prima e unica presidente donna degli Stati Uniti, era morta.
«E sai dirci il tuo nome?» Gli infermieri, ovviamente, erano entrambi maschi.
«Penny» rispose lei. «Penny Harrigan.»
I due, chini su di lei, restarono di sasso, riconoscendola. Le loro espressioni professionali svanirono per un attimo trasformandosi in sorrisi estasiati. «Mi pareva che avessi una faccia nota» disse uno, squillante.
L’altro schioccò le dita, scocciato perché non gli venivano in mente le parole. Buttò lì: «Tu sei... sei quella del “National Enquirer”!».
Il primo puntò un dito contro Penny, legata e inerme, esposta a tutti gli sguardi maschili. «Penny Harrigan» gridò come se fosse un’accusa. «Tu sei Penny Harrigan, la “Cenerentola del Nerd”.»
I due sollevarono la barella all’altezza dei fianchi. La folla si aprì per lasciarli procedere verso l’uscita.
Il secondo infermiere annuì. «Quello che hai mollato non era, tipo, l’uomo più ricco del mondo?»
«Maxwell» aggiunse il primo. «Si chiama Linus Maxwell.» Scosse la testa, incredulo. Dopo lo stupro subito in un tribunale federale affollato, senza che nessuno levasse un dito per fermare l’aggressore, ora per soprammercato Penny veniva additata come un’idiota da due portantini.
«Avresti dovuto sposarlo!» continuò a meravigliarsi il primo fino all’ambulanza. «Cara mia, se avessi sposato quel tizio, ora saresti più ricca di Dio...»
Cornelius Linus Maxwell. C. Linus Maxwell. Per via della sua reputazione di playboy, i tabloid lo chiamavano spesso “Climax-Well”. Il megamiliardario più ricco del mondo.
A lei, invece, gli stessi tabloid avevano dato il soprannome di “Cenerentola del Nerd”.
Penny Harrigan e Corny Maxwell. Si erano conosciuti un anno prima. Pareva un’altra vita. Tutt’altro mondo.
Un mondo migliore.
In tutta la storia dell’umanità non c’era mai stata epoca migliore per essere donne. Penny lo sapeva.
Crescendo, se l’era ripetuto come un mantra: “In tutta la storia dell’umanità non c’è mai stata epoca migliore per essere donne”.
Il suo mondo precedente era perfetto, o quasi. Si era da poco diplomata alla law school, classificandosi ai primi posti tra i compagni di corso, ma era stata respinta due volte all’esame di avvocato. Due volte! Non dubitava di sé – non del tutto, almeno, ma un’idea aveva cominciato a tormentarla. Penny era resa inquieta dal pensiero che forse, dopo tutte le sofferte vittorie del movimento di liberazione della donna, diventare un avvocato volitivo e ambizioso non era poi un gran trionfo. Non più, perlomeno. Come proposito non era certo più audace dell’idea di fare la casalinga negli anni Cinquanta. Un paio di generazioni prima, la società l’avrebbe incoraggiata a diventare madre e casalinga. Ora, invece, la spinta era tutta orientata verso una professione: avvocato; o medico; o ingegnere aerospaziale. In ogni caso, la validità di quei ruoli aveva a che fare più con le mode e la politica che con Penny come individuo.
Da studentessa universitaria si era dedicata anima e corpo a guadagnarsi l’approvazione dei docenti al dipartimento di Studi di genere della University of Nebraska. Aveva abbandonato i sogni dei genitori per i dogmi dei professori, ma nessuna delle due prospettive si era dimostrata veramente sua.
La verità era che Penelope Anne Harrigan era sempre stata una brava figliola – obbediente, brillante, diligente – che faceva quel che le veniva detto di fare. Si era sempre rimessa ai consigli altrui. Nel profondo, però, aspirava a qualcosa di più dell’approvazione dei genitori o di chi li aveva rimpiazzati. Con buona pace di Simone de Beauvoir, Penny non aveva voglia di far parte della terza ondata di un bel niente. E, con tutto il rispetto per Bella Abzug, non voleva neanche essere una post-qualcosa, non aveva voglia di replicare le vittorie di Susan B. Anthony e Helen Gurley Brown. Voleva una scelta al di là dell’alternativa tra casalinga e avvocato, tra madonna e puttana. Un’opzione non invischiata nei residui persistenti di un sogno d’epoca vittoriana. Penny voleva qualcosa di follemente al di là dello stesso femminismo!
A tormentarla era il pensiero che forse era stata qualche causa profonda a impedirle di superare l’esame di avvocato. Una parte sommersa di lei non voleva esercitare quella professione, e lei continuava a sperare che qualcosa intervenisse a salvarla dai suoi sogni prevedibili e modesti. L’ideale da lei perseguito era quello di una donna radicale di un secolo prima: diventare avvocato... competere alla pari con gli uomini. Come ogni sogno di seconda mano, però, per lei era un peso. Altri dieci milioni di donne lo avevano già realizzato. Penny voleva un sogno tutto suo.
Non lo aveva trovato come figlia beneducata né ripetendo a pappagallo l’ideologia rilegata in pelle dei suoi professori. Si consolava pensando che tutte le ragazze della sua generazione dovevano essere alle prese con quella stessa crisi. Avevano tutte ereditato un patrimonio di libertà e avevano il dovere morale, nei confronti del futuro, di prospettare una nuova frontiera per la prossima generazione di donne. Di dissodare nuova terra.
Finché tale sogno tutto nuovo, inedito, originale non avesse amabilmente fatto capolino, Penny avrebbe con ostinazione perseguito quello vecchio: una posizione al livello più basso in uno studio legale, dove servire brioche, andare a raccattare sedie e sgobbare in vista di un nuovo esame di avvocato.
Aveva venticinque anni e temeva che potesse essere già troppo tardi.
Non si era mai fidata dei suoi impulsi e istinti naturali. Tra le sue paure più grandi c’era quella di non riuscire a scoprire e sviluppare le proprie intuizioni e doti più profonde. I suoi doni speciali. Temeva di sprecare la vita perseguendo obiettivi stabiliti per lei da altri. E invece voleva acquisire un potere e un’autorità – una forza primitiva, irresistibile – che trascendessero i ruoli di genere. Sognava di impadronirsi di qualche magia pura, più antica della stessa civiltà.
Mentre cercava il coraggio per tentare una terza volta l’esame di avvocato, Penny cominciò a lavorare da Broome, Broome & Brillstein, lo studio legale più prestigioso di Manhattan. A dire il vero, non era un’associata a pieno titolo, ma non era neanche una stagista. Okay, a volte doveva correre da Starbucks, al piano terra, a prendere una mezza dozzina di bicchieri di latte e cappuccini di soia semidecaffeinati, ma non tutti i giorni. Altre volte veniva spedita a recuperare sedie per qualche grande riunione. Però non era una stagista. Penny Harrigan non era avvocato, non ancora, ma di certo non era una volgare stagista.
Le giornate erano lunghe da BB&B, ma a volte anche elettrizzanti. Un giorno, ad esempio, sentì rimbombare una specie di tuono tra le torri della Lower Manhattan. Era il rombo di un elicottero che atterrava proprio sul tetto del loro palazzo. All’eliporto, sessantasette piani più in alto, era arrivato qualcuno di straordinariamente importante. Penny si trovava al piano terra, alle prese con una fragile scatola di cartone contenente una mezza dozzina di bicchieroni di caffè bollente. Stava aspettando un ascensore. Si vide riflessa nelle porte di acciaio levigato che aveva di fronte. Non una bellezza. Ma neanche brutta. Né bassa né alta. I capelli erano a posto, puliti e posati ordinatamente sulle spalle di una sobria camicetta Brooks Brothers.
Gli occhi castani erano grandi e sinceri. Un attimo dopo, la sua faccia paciosa dalla pelle chiara scomparve.
Le porte scorrevoli dell’ascensore si aprirono, e una mischia di omoni – tipo squadra di football americano alla carica, tutti in identici completi blu navy – emerse dalla cabina. Quasi stessero sgombrando il campo per la maestosa avanzata del loro quarterback, si fecero largo a forza tra la folla impaziente. Costretta a scansarsi, Penny non poté fare a meno di protendere il collo per vedere chi stessero proteggendo. Chiunque avesse una mano libera la sollevò, armata di telefonino, per scattare foto o riprendere la scena dall’alto. Penny non riuscì a penetrare con lo sguardo la muraglia di serge blu, ma alzò gli occhi e vide il volto noto negli schermi dei tanti apparecchi di registrazione. L’aria risuonava di clic elettronici. Scariche elettrostatiche e parole che uscivano dai walkie-talkie. Da dietro la muraglia umana giungevano, ovattati, dei singhiozzi.
La donna inquadrata sui display di una miriade di telefonini si stava asciugando le guance con l’angolo di un fazzoletto, i cui pizzi e merletti erano già umidi di lacrime e sporchi di mascara. Nonostante gli occhiali da sole smisurati, quel volto era inconfondibile. Ci fosse stato qualche dubbio, sarebbe stato fugato dallo sfolgorante zaffiro blu adagiato tra i suoi seni perfetti. A voler credere ai tabloid in esposizione alla cassa del supermarket, era lo zaffiro puro più grande di tutti i tempi, quasi duecento carati. Quella pietra aveva ornato il collo di antiche regine egizie, di imperatrici romane, di zarine russe. Penny non riusciva a immaginare...