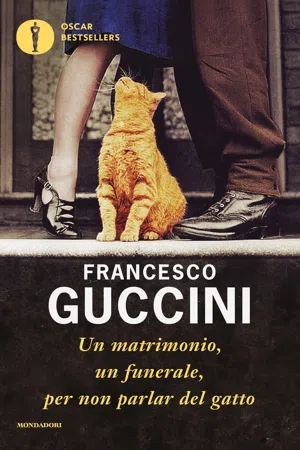La comitiva arrivò davanti alla casa dei miei nonni, il mulino, alle dieci e trenta della domenica mattina.
Un gruppo era partito dalla Casa Nuova (Canova, in lingua locale), un poderetto di contadini ben in alto oltre il fiume. Erano scesi da una mulattiera che oggi non esiste più, si preferiscono le strade percorribili da un’automobile. Qualche traccia si trova ancora ma il resto, non più battuto da piedi umani, si è inesorabilmente infrascato.
Gli altri della comitiva venivano addirittura da più lontano, da un altro paese situato ben oltre il crinale, dove la Toscana finisce e comincia l’Emilia. Erano in giro, soprattutto i secondi, da più di un’ora, ma il percorso non era finito: passato il fiume sul ponte (il Pontaccio) e arrivati al mulino, bisognava prendere la mulattiera che porta in paese, lì passare la Statale 64 e prendere l’altra mulattiera che raggiunge la chiesa.
Perché quello era un corteo matrimoniale: sposi, testimoni, parenti e amici stavano andando in chiesa per celebrare le nozze di Coriolano e... il nome della sposa proprio non lo ricordo.
I genitori di Coriolano erano contadini, e si erano insediati in quel piccolo podere, agricoltura di sopravvivenza, un orto, un po’ di grano e granturco, un maiale, qualche gallina e conigli e un paio di vacche da latte e da lavoro, ma lui aveva cambiato direzione, aveva fatto un passo in avanti da un punto di vista sociale e lavorava come operaio metalmeccanico in una fabbrica di Porretta, la Daldi (l’Adaldi, in voce locale). Questa fabbrica, ora in parte decaduta dai fasti di quei tempi, dava lavoro e pane a tutti i giovani della vallata e delle vallate attorno. Lavorare all’Adaldi, come dicevano, significava un posto sicuro e sicure condizioni economiche, mentre la montagna, come oggi, queste sicurezze tanto non le offriva. C’era anche una certa differenza rispetto al lavoro dei campi: otto ore poi a casa, in tempo, eventualmente, per un po’ d’orto; un mese di ferie, mutua e assicurazione e pensione. Altro che spaccarsi la schiena su quella terra maledetta. Quando al pomeriggio smettevano di lavorare si vedeva la strada riempirsi di operai che salivano in bicicletta e aspettavano un camion che passasse di lì per aggrapparsi al cassone e farsi portare a un qualunque bivio dove, lasciata la bicicletta da qualche parte, proseguire a piedi anche per un bel pezzo di strada o mulattiera per raggiungere la propria casa.
Coriolano, conosciuta una ragazza di quel vicino paese, date le migliori condizioni economiche raggiunte, aveva deciso di sposarsi.
Era una domenica di giugno o luglio del 1948.
Davanti a tutta la numerosa comitiva c’era un tizio con una fisarmonica a tracolla che suonava allegramente. Dietro di lui alcuni amici dello sposo, che avevano in tasca una bottiglia di liquore, probabilmente grappa di rigorosa fabbricazione casalinga. Estraevano anche un bicchierino, di quelli usati una volta per il rosolio, poco più grandi di un ditale, e offrivano da bere a chi incontravano. L’allegria di questi personaggi (suonatore e amici) non era evidentemente dovuta soltanto alla lieta occasione, ma di certo anche al fatto di avere già attinto da quella bottiglia. Assieme al gruppo di amici c’era anche un tizio con un paniere pieno di zuccherini, tipico dolce nuziale di queste montagne, consistente in una ciambellina ricoperta da una glassa di zucchero e aromatizzata all’anice. Anche gli zuccherini erano offerti a tutti quelli che incrociavano il corteo.
Veniva poi il futuro sposo, che dava il braccio a una donna della sua famiglia. Era sbarbato a puntino e fresco di barbiere (si notava il biancore della pelle appena rasata a contrastare l’abbronzatura del viso e del collo), probabilmente odoroso di una qualche lozione. Mi piacerebbe immaginarlo oggi vestito, nonostante il caldo, con un completo di velluto verde a coste larghe, quello che per i vecchi d’allora sarebbe stato per anni il vestito buono, quello con cui un giorno sarebbero stati seppelliti, ma quasi sicuramente lo sposo aveva un fiammante doppiopetto di qualche sarto locale a coprire la classica camicia bianca da festa, strozzata in gola da una qualche assurda cravatta. Dietro ancora, a pochi passi, al braccio del padre, la sposa, con un abituccio bianco e un mazzo di fiori in mano. C’era forse anche qualche amica, ma il grosso femminile della famiglia era rimasto a casa per preparare il pranzo di nozze.
Io e mia prozia ci accodammo al corteo; lei era stata invitata (e io di conseguenza, non mi sarei fatto mancare certamente un’occasione mondana simile) non so bene per quali lontani motivi di parentela con lo sposo, ma soprattutto perché, avendo da giovane fatto la cameriera a Genova presso una ricca famiglia, era considerata esperta in questioni di etichetta o del come imbandire una tavola.
Ci incamminammo verso la chiesa. Alle prime case del paese la gente usciva e applaudiva facendo gli auguri, il fisarmonicista suonava, gli amici offrivano un cicchetto e qualche zuccherino. Nessuno sentiva la fatica della salita, nemmeno la sposa, che se l’era fatta a piedi fin lì venendo di là dal crinale.
Nella chiesa, che sembrava incredibilmente grande allora (e com’è piccola adesso), ci accolse un piacevole fresco. L’altare splendeva di luci che si riflettevano sull’ottone dei vasi, bossoli di cannone dell’ultima ancora vicina guerra, artisticamente sbalzati da industriose mani artigiane e ricolmi di fiori.
Gli sposi, accompagnati dai testimoni, andarono verso l’altare, il resto della gente si accomodò fra i banchi. Le donne, come usanza, presero posto sulla destra, dalla parte del misterioso antro del confessionale, sovrastato da un organo muto da un secolo almeno. Gli uomini andarono sulla sinistra, dalla parte di un sovrastante pulpito dal quale non ho mai visto apparire nessun predicatore. Soltanto il padre del prete, ogni tanto, appariva, provenendo da vie le più segrete (non c’era accesso esterno visibile) per ascoltare la messa e la predica domenicale del figlio. Di fianco all’altare, nella cappella di destra, protetta da una teca di cristallo, c’era la statua a grandezza naturale e colorata in bianco, azzurro e rosa di santa Filomena, allora protettrice del paese. Dico “allora” perché negli anni Sessanta qualcuno, alla Santa Sede o giù di lì, aveva scoperto che la santa non aveva testimonianze storiche accertate, così era stata tolta dal calendario. La tradizione narrava che Filomena, principessa figlia del re di Corfù, si fosse recata a Roma, tredicenne, per chiedere all’imperatore Diocleziano di desistere dal muovere guerra al suo Paese. Diocleziano si sarebbe invaghito di lei (non aveva nient’altro da fare?) e l’avrebbe chiesta in sposa ma, di fronte a un fermo rifiuto, l’avrebbe fatta uccidere.
È improbabile che Diocleziano fosse un pedofilo, anche se a quei tempi le femmine maturavano prima; è più probabile che Filomena fosse una delle tante persone uccise durante le feroci repressioni dei cristiani volute dall’imperatore. Comunque nel ’48 Filomena era ancora patrona del paese e, dalla sua teca, ragazza non tredicenne ma robusta ventenne, guardava benevola gli sposi.
Che furono finalmente sposati. Al momento culminante la cantante ufficiale di tutte queste liete cerimonie, non una professionista ma una comune fedele, intonò l’Ave Maria di Schubert (era il suo pezzo forte, e credo l’unico del repertorio) con voce dolce e commossa. Appena fuori riprese la musica della fisarmonica e gli sposi furono accolti con lancio di confetti che noi ragazzetti ci ammazzammo per raccattare e metterci nelle tasche. Poi riprendemmo il cammino, che consisteva nello scendere fino alla Statale, passarla, scendere dalla mulattiera verso il mulino, raggiungere il ponte, prendere la mulattiera che saliva fino al crinale, varcarlo e raggiungere la casa della sposa. Ce la cavammo in poco più di un’ora.
Là ci attendevano, all’aperto, delle tavole imbandite. In quei tempi certi pranzi si facevano solo in alcune occasioni: i matrimoni, Natale, Pasqua, la festa del santo patrono e la cena per i macchinisti e le opere finita la trebbiatura del grano. Non erano molte le occasioni, e tutti ci accingemmo di buon grado alla bisogna.
Prima, però, volli portare agli sposi un mio pensiero. Avevo scatolato a morte mia prozia per avere un regalo da portare, mi sembrava scorretto arrivare lì a mani vuote, così la prozia, presa dalla disperazione, mi aveva dato uno spazzolino da denti (avvolto in cellophan) e un barattolino di dentifricio in polvere, tutta roba lasciata lì dai soldati americani in tempo di guerra.
Pensandoci oggi, quel dono non era proprio di grande eleganza, anzi, avrebbe potuto anche risultare un po’ offensivo, ma lo accettarono ringraziando sentitamente. Penso però che quello spazzolino e quel dentifricio in polvere siano rimasti intonsi e dimenticati dentro a qualche cassetto nella camera nuziale.
Mangiammo. Ma cosa mangiammo?
Qui la memoria non mi assiste, però credo che ci fossero i piatti tipici di ogni festività paesana, tortellini in brodo (anche se era estate), poi lesso con le salse, arrosto di pollo e di coniglio con patate arrosto e insalata, dolci di vario tipo. Io, ragazzetto, mangiai certo qualcosa, ma gli adulti si strafogarono, forse due piatti di tortellini, forse doppia porzione di lesso e d’arrosto, le bazze unte, le ganasce che si muovevano come macine a distruggere cibo, a ingurgitare l’ingurgitabile, le mani che afferravano carne e la portavano alla bocca, che condivano insalata e patate.
Bevemmo. Ma cosa bevemmo? Io veramente, bambino, soprattutto acqua, ma gli adulti si fecero di vino toscano, com’è qui chiamato il Sangiovese della piana di Pistoia e zone limitrofe; poi, con le ciambelle e i dolci, qualcosa di bianco e frizzante, di provenienza emiliana, tenuto in fresco nel pozzo. Anche io, insieme al dolce, ne ebbi un piccolo bicchiere.
Il vino scioglieva la lingua, era allora usanza che, durante il pranzo di nozze, qualcuno (più poeta degli altri) lanciasse i “brindisi”, brevi composizioni che proverò a descrivere come due quinari e un endecasillabo, rimati ABB, ma non sempre le regole metriche erano rispettate. Penso che mi impressionarono molto, se due me li ricordo ancora. Uno era di gentile e amorosa castigatezza: “Il giglio è bianco, rossa è la rosa, viva Coriolano con la sua sposa”; l’altro più audace e maliziosamente intrigante: “Il giglio è bianco, la rosa è gialla, viva il letto che questa notte balla”. I brindisi erano seguiti da cori di “Viva gli sposi!” e battimani.
Gli adulti finirono con un caffè e liquori di vario tipo, grappa e strane misture autarchiche che allora si trovavano in ogni casa.
Era tutto finito? No di certo, perché, dopo una piccola pausa per digerire, ci alzammo tutti e ci incamminammo di nuovo, ripassammo il crinale e prendemmo la mulattiera diretti alla casa dello sposo.
Qui tutto ricominciò dal principio: ci attendevano altre tavole imbandite, per la cena. Ci rimettemmo a sedere e iniziammo di nuovo là dove eravamo rimasti: riprendemmo a mangiare. Non so cosa, non ricordo bene, ricordo il sole del tardo pomeriggio che colpiva rado le tavole festanti e un curioso dessert escogitato da mia prozia che suscitò stupore e ammirazione in tutti. A fine pasto furono portate in tavola quelle che sembravano uova al tegame, ma che in realtà erano mezze albicocche a simulare il tuorlo e una glassa bianca per l’albume. Fu un trionfo.
E dopo, il ballo. Il tizio della fisarmonica si guadagnò i due pasti (e una eventuale mancia) cominciando a suonare valzer, polche e mazurche. Si ballò fino a notte inoltrata. Vidi, quella notte, una cosa eccezionale: un vecchietto (sicuramente molto più giovane di me oggi) che ballava il trescone con un bicchiere di vino in equilibrio sulla testa, per dimostrare la sua abilità di ballerino ma, soprattutto, che non era ubriaco. Fu l’ultima volta che vidi ballare il trescone tradizionale da queste parti.
Chissà se Coriolano e la sua sposa hanno fatto il viaggio di nozze. Forse sì, si sono spinti a Firenze, o a Venezia, o addirittura a Roma, per qualche giorno, poi a casa a ricominciare la solita vita di lavoro e abitudini; le quotidiane giornate di sempre.
Pensandoci oggi, non ho più saputo niente, dopo quel matrimonio, di Coriolano e sua moglie, di tutti gli altri invitati, della gente che aveva partecipato a quel giorno di festa.
Come se quel matrimonio non fosse mai esistito, fosse stato una fantasia, un parto della mia mente, un sogno fra i tanti che un’immaginazione infantile può concepire. Tutto scomparso, tutto svanito via chissà dove.
Qualche tempo fa parlavo con un conoscente. «Ma tu lo ricordi un certo Coriolano?» gli ho chiesto.
«Sicuro. Lo conoscevo bene, era in officina con me. Ma ora è morto, è già un pezzo che è morto. Anche la moglie. Erano vecchi.»
Ci sono rimasto male. Poi, pensandoci, credo che quasi tutti quelli di quel matrimonio non ci siano più, il suonatore di fisarmonica, il ballerino di trescone, gli amici dello sposo, i testimoni, il prete che li ha sposati e la donna che per loro ha cantato l’Ave Maria. Apparsi un momento e ora tutti scomparsi, senza lasciare traccia di sé, come è scomparsa quell’epoca, quel modo di essere e di vivere.
Di quel giorno è rimasto solo qualcuno dei ragazzetti che si erano ammazzati per raccogliere i confetti lanciati a festeggiare gli sposi, in quella giornata d’estate del 1948.