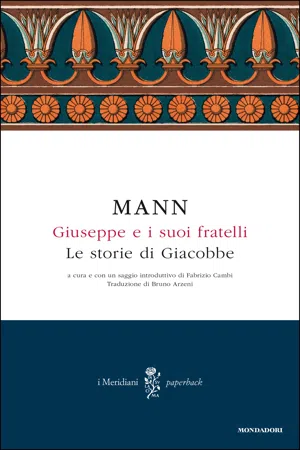
- 546 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Giuseppe e i suoi fratelli - 1. Le storie di Giacobbe
Informazioni su questo libro
«In Giuseppe e i suoi fratelli si è voluto vedere un romanzo sugli Ebrei, anzi per gli Ebrei. La scelta dell'argomento veterotestamentario non fu certo un caso. Essa era senza dubbio in segreta, testarda e polemica relazione con tendenze del tempo che mi ripugnavano visceralmente, con il razzismo giunto in Germania a livelli inauditi, che costituisce una componente fondamentale del volgare mito fascista. Scrivere un romanzo che è una sorta di monumento allo spirito ebraico era attuale, proprio perché appariva inattuale. Ed è vero, il mio racconto si attiene con una fedeltà sempre per metà scherzosa ai dati della Genesi e spesso va letto come esegesi e amplificazione della Torah, come un midrash rabbinico.» Thomas Mann
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Giuseppe e i suoi fratelli - 1. Le storie di Giacobbe di Thomas Mann in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788804649410eBook ISBN
9788852063886LE STORIE DI GIACOBBE
Capitolo primo
Al pozzo
ISHTAR
Fu al di là delle colline a nord di Hebron, un po’ a oriente della strada che veniva da Urusalim, nel mese di Adar,1 in una sera di primavera. La luna era così luminosa che si sarebbe potuto leggere al suo chiaro, e il fogliame dell’albero – un annoso e robusto terebinto dal tronco breve e dai rami sporgenti, che si levava tutto solo – appariva, con i suoi fiori a grappolo minutamente lavorati dalla luce, come avvolto da un velo scintillante e tuttavia nitidissimo. Il bell’albero era sacro: alla sua ombra si potevano ottenere in vario modo ammaestramenti, sia per bocca umana (chi, infatti, aveva da comunicare, per averne fatto esperienza, qualche cosa sulla divinità adunava gli uditori sotto i suoi rami) sia per voce divina. Più volte persone che, appoggiato il capo al suo tronco, vi si erano assopite, avevano ricevuto in sogno profezie e ammonimenti, e una tavola di pietra per sacrifici, dalla lastra annerita, dove ardeva una piccola fiamma dall’esile fumo, testimoniava che là si era soliti bruciare offerte in occasione delle quali la direzione del fumo, un presago volo di uccelli e perfino segni celesti avevano confermato spesso nel corso del tempo che gli atti devoti compiuti ai piedi dell’albero godevano di una speciale attenzione dall’alto.
C’erano molti alberi tutt’intorno, pur se nessuno così venerando come quello che sorgeva là solitario; alberi della stessa specie, come pure fichi dalle larghe foglie e lecci le cui radici aeree scendevano dai tronchi fino al suolo fittamente calpestato e il cui verde perenne, una tinta a mezzo tra il verde cupo delle conifere e quello chiaro delle piante annuali, imbiancato dalla luna, formava ventagli spinosi. Dietro gli alberi, verso mezzogiorno, in direzione della collina che nascondeva la città e anche un tratto su per il pendio c’erano abitazioni e stalle, e di là si udiva talvolta nel silenzio della notte il cupo muggito di un bue, il forte sbuffare di un cammello, lo stentato lamento di un asino. Ma verso mezzanotte la vista era libera: dietro un muro di cinta, eretto con pietre rozzamente squadrate e muscose in duplice strato, che faceva assomigliare il luogo intorno all’albero degli oracoli a una terrazza con un basso parapetto, si apriva, nella luce dell’astro già alto nel cielo e pieno per tre quarti, giù fino all’ondulata linea delle colline che chiudevano l’orizzonte, una vasta pianura popolata di olivi e cespugli di tamarischi e solcata da sentieri campestri che più oltre diventava un pascolo brullo su cui fiammeggiava ogni tanto un fuoco di pastore. Ciclamini rosa e violacei sbiancati dalla luna fiorivano sul parapetto del muro, bianchi crochi e rossi anemoni tra il muschio e l’erba, ai piedi degli alberi. Aleggiava là intorno profumo di fiori e di erbe aromatiche, odore di piante fradice, legno bruciato e letame.
Il cielo era stupendo. Un ampio alone avvolgeva la luna, la cui luce, benché mite, era così intensa che fissarla faceva quasi male agli occhi e le stelle, semenza gettata e sparsa nell’aperto firmamento, apparivano qua più rade, là più fitte e disposte in configurazioni scintillanti. A sud-ovest spiccava chiaro, vivente fuoco azzurro-bianco, raggiante pietra preziosa, Sirio-Ninurtu e con la stella Procione, situata un po’ più in alto a sud, sembrava formare un’unica figura nel Cane minore. Mardug, il re, sorto subito dopo il tramonto del sole per brillare tutta la notte, l’avrebbe eguagliato in magnificenza se la luna non ne avesse superato lo splendore. E c’era Nergal,2 non molto lontano dallo zenit, un po’ a sud-est, il nemico dai sette nomi, l’Elamita apportatore di peste e di morte, che noi chiamiamo Marte. Ma prima di lui si era levato sopra l’orizzonte Saturno, il costante e il giusto, e brillava a sud sul meridiano. Sfarzosa, con la sua rossa luce principale, si presentava la nota figura di Orione, anche lui cacciatore, ben cinto e armato, volto verso occidente. Pure laggiù ma più a sud si librava la Colomba. Dall’apice della sua altezza Regolo si affacciava nella costellazione del Leone, verso cui già salivano i Tori del Carro, mentre il fulvo Arturo nel Bovaro indugiava ancora basso a nord-est e la luce dorata del Capro con la costellazione dell’Auriga era già scesa profondamente verso la sera e la mezzanotte. Ma più bella di queste, più fiammeggiante di tutti i segni precursori e di tutto l’esercito dei Kokabim3 era Ishtar, la sorella, sposa e madre, Astarte, la regina che seguiva il sole nel profondo Occidente. Mandava raggi argentei che si sperdevano nell’aria, una tremula merlettatura di fuoco, e una fiamma più lunga sembrava incombere su di lei, simile a punta di lancia.
FAMA E PRESENTE
Due occhi, due bruni occhi usi a distinguere tutto questo e a osservarlo con intendimento, erano levati verso l’alto e specchiavano tanta molteplice luce. Vagavano lungo la diga dello zodiaco, il solido baluardo che domina e soggioga le onde celesti e presso cui vegliano i regolatori del tempo; lungo l’ordine dei sacri segni, che dopo il breve crepuscolo di quelle latitudini cominciavano, l’uno dopo l’altro, rapidamente a mostrarsi: dapprima il Toro, poiché al tempo in cui quegli occhi vivevano – trovandosi il sole al principio della primavera nel segno dell’Ariete – questa compagine era sprofondata insieme a lui. Gli esperti occhi sorrisero poi ai Gemelli che dalla loro altezza cominciavano a volgersi verso occidente; scivolando quindi verso oriente trovarono la Spiga nella mano della Vergine. Ma poi tornarono al cerchio luminoso della luna, al suo scintillante scudo argenteo, irresistibilmente attratti dal suo puro e delicato splendore.
Erano gli occhi di un ragazzo seduto sull’orlo di un pozzo che, cinto da un muro e sormontato da un breve arco di pietra, apriva la sua umida profondità non lontano dall’albero sacro. Conducevano al pozzo consunti gradini circolari, su cui poggiavano i piedi nudi del giovane, stillanti al pari dei gradini dove da poco era stata versata dell’acqua. Da un lato, dov’era asciutto, erano posati la sua veste, una tunica con un largo disegno color rosso ruggine su fondo giallo e i sandali di cuoio di bue, simili a scarpe, poiché i due bordi morbidamente ricadenti avvolgevano calcagno e caviglia. Le ampie maniche della lunga camicia di tela, candida ma rozza, erano legate intorno ai fianchi e la pelle bruna del torace fin troppo tornito e massiccio in rapporto alla testa quasi di fanciullo e alle spalle che, alte e squadrate, ricordavano il tipo egizio, cosparsa d’unguento brillava nella luce lunare. Dopo essersi lavato con l’acqua freddissima della cisterna, fatte parecchie abluzioni con un secchio e un ramaiolo – gradito ristoro dopo una giornata torrida e, al tempo stesso, adempimento di una prescrizione religiosa – il ragazzo si era unto con olio di oliva profumato, attingendo da un vasetto di vetro lucido e non trasparente che aveva accanto. Nel far ciò non si era tolto dal capo la corona di mirto mollemente intrecciata né l’amuleto che da una collana di bronzo gli pendeva sul petto: un sacchettino in cui erano cucite fibre di radici miracolose.
Sembrava che pregasse perché, levato il volto verso la luna che lo illuminava intero, i gomiti aderenti ai fianchi, gli avambracci alzati, le palme delle mani aperte e protese verso l’alto, si dondolava lievemente, ora da una parte ora dall’altra, cantilenando suoni e parole, a fior di labbra… Alla mano sinistra portava un anello di maiolica azzurra e le unghie dei piedi e delle mani mostravano tracce di una tinta rosso mattone di henné che egli, come i giovanotti eleganti del paese, si era messo in occasione delle recenti feste cittadine, per piacere alle donne che stavano a guardare dai tetti; ma avrebbe potuto rinunciare all’aiuto dei cosmetici, affidandosi soltanto al leggiadro sembiante che Dio gli aveva dato. Per l’ovale ancora infantilmente pieno e soprattutto per la languida espressione degli occhi neri e leggermente obliqui, quel volto era davvero grazioso. Persone belle credono di dover incrementare ancora di più la loro natura e “farsi belle”, forse per una specie di obbedienza al compito di procurare diletto loro affidato, ponendosi al servizio – impegno cui si potrebbe attribuire un senso religioso e riconoscerne anche la validità – delle doti loro concesse dalla natura. L’agghindarsi e il truccarsi dei brutti è invece di un genere triste e farsesco. La bellezza infatti non è mai perfetta, e della propria inadeguatezza a un ideale che lei stessa si è data si fa uno scrupolo, e questo è ancora una volta un errore, giacché il segreto della bellezza consiste proprio nell’attrattiva che emana da ciò che non attinge la perfezione.
Intorno al capo del giovane, che vediamo dinanzi a noi vivo e reale, leggenda e poesia hanno intessuto un’autentica corona irradiante una fama di bellezza, ma la presenza del giovane, la sua vivente figura, ci inducono a meravigliarci un poco di quella fama, sebbene a soccorrerla congiurino, abbagliandoci mitemente, i tremuli incanti della notte lunare. Quali cose non sono state dette e ripetute nel volgere dei tempi, nella poesia e nella leggenda, negli apocrifi e negli pseudoepigrafi, per celebrare la sua bellezza! Potrebbero farci sorridere, noi che guardiamo la realtà direttamente con gli occhi. Si è insistito, ed è il meno, sul fatto che il suo volto avesse offuscato lo splendore del sole e della luna. Si è affermato, alla lettera, che il giovane doveva coprirsi la fronte e le guance di un velo, affinché il cuore del popolo non ardesse di fiamme terrene dinanzi all’inviato di Dio, e che quanti lo avevano veduto senza velo “profondamente assorti in beata contemplazione” non avevano più riconosciuto il giovane. La tradizione orientale non esita a dichiarare che la metà di tutta la bellezza esistente sia toccata in sorte a questo giovinetto e l’altra sia stata distribuita fra il resto dell’umanità. Un cantore persiano, particolarmente autorevole, si spinge oltre questa enunciazione iperbolica ricorrendo all’immagine eccentrica di un’unica moneta del peso di sei once in cui sarebbe stata fusa tutta la bellezza del mondo: di queste sei once cinque, così canta nella sua mistica esaltazione il poeta, sarebbero toccate a lui, il portento, l’essere incomparabile.
Una tal fama, tracotante e smodata perché sottratta ormai a ogni vaglio, ha per chi guarda qualche cosa di sconcertante e di seducente e costituisce un pericolo per una obiettiva osservazione della realtà. Sono molti gli esempi che testimoniano della forza di suggestione emanante da una stima esagerata, forza capace di aggregare moltitudini e da cui il singolo si lascia abbagliare volontariamente, anzi con una specie di ebbro furore. Circa vent’anni prima del momento in cui si inizia la nostra storia, un uomo, uno stretto parente, come ancora udremo, di questo giovane, vendeva nella regione di Charran, in Mesopotamia, pecore da lui stesso allevate e tanto famose che la gente pagava a lui prezzi irragionevoli, per quanto ciascuno vedesse bene che non di pecore celesti, miracolose si trattava bensì di normali, comuni pecore, seppure di eccellente qualità. Ecco una prova di quanto sia forte il bisogno umano di lasciarsi soggiogare dalla suggestione! Ma se da un lato non siamo disposti a lasciarci abbagliare dalla fama postuma perché siamo in grado di confrontarla con la realtà, dall’altro non dobbiamo però smarrirci nella direzione opposta e abbandonarci a una ricerca esasperata di difetti. Un entusiasmo postumo come quello da cui sentiamo minacciata l’obiettività del nostro giudizio non nasce, ovviamente, dal nulla, deve avere le sue radici nella realtà e, come si può dimostrare, esso fu in gran parte già tributato alla persona in vita. Per comprendere tale fenomeno dobbiamo innanzi tutto familiarizzarci con un certo gusto arabo per il fantastico e il misterioso, un certo criterio estetico particolare, l’unico praticamente valido in quei luoghi e, se osserviamo il giovane da tale punto di vista, egli era veramente bello e leggiadro, tanto da venire preso più volte, al primo sguardo, quasi per un dio.
Vogliamo dunque sorvegliare le nostre parole e, senza indulgere per debolezza alle dicerie o all’ipercritica, dichiarare da subito che il volto del giovane adoratore della luna presso il pozzo era amabile anche nei suoi difetti. Le narici del suo naso, per esempio, piuttosto corto e molto dritto, erano troppo grosse; ma poiché in questo modo le alette sembravano dilatate, la fisionomia acquistava un non so che di vivace, di appassionato, una fuggevole ombra di alterigia che ben si accordava con l’amabilità degli occhi. Né vogliamo censurare l’espressione di altera sensualità che labbra tumide abitualmente evocano. È un’espressione che può ingannare, e inoltre, proprio per la forma delle labbra, dobbiamo attenerci al punto di vista del paese e della gente cui apparteneva il giovane. Tuttavia ci riterremmo autorizzati a trovare troppo arcuata la regione tra il naso e la bocca, se proprio da ciò non fosse dipesa una conformazione particolarmente graziosa degli angoli della bocca: in essa, infatti, per il solo sovrapporsi delle labbra, senza contrazione alcuna di muscoli, spontaneamente, nasceva un tranquillo sorriso. La fronte era liscia nella parte inferiore sovrastante le sopracciglia forti e ben disegnate, ma rientrante in alto, sotto folti capelli neri stretti da un nastro di pelle chiara e ornati da una corona di mirto che gli cadevano indietro sul collo, come un sacchetto piatto, lasciando peraltro libere le orecchie, su cui non avremmo nulla da ridire se i loro lobi non fossero stati troppo carnosi e allungati, evidentemente a causa degli orecchini d’argento troppo grandi che gli avevano messo fin da bambino.
Che cosa faceva dunque il giovane? Pregava? La sua attitudine era troppo comoda per la preghiera. Sarebbe dovuto stare in piedi. Il suo mormorio e la cantilena a mezza voce, con le mani alzate, sembravano piuttosto un sommesso colloquio con il nobile astro, un conversare con esso in uno stato di assenza. Cantilenava, dondolandosi: «Abu – Chammu – Aoth – Abaoth – Abirâm – Chaam – mi – ra – am… ».
In questa litania improvvisata si confondevano fra loro tutte le possibili e più vaste associazioni di idee; mentre dava alla luna vezzeggiativi babilonesi, la chiamava Abu, padre, e Chammu, zio, fra questi nomi metteva anche quelli di Abram, l’avo, vero o presunto, e modificando e ampliando questo nome ne aggiungeva un altro, quello di Chammurabi,4 il legislatore, nome leggendario che significa “il mio divino zio è eccelso”. Ma c’erano, oltre a questi, dei suoni con un particolare significato che si riferivano, più o meno direttamente, all’idea di padre e che spingendosi oltre la cerchia della religione astrale diffusa in Oriente, nella patria dei suoi antenati, oltre la cerchia dei ricordi familiari provavano, con un balbettio ancora incerto, a dar nome all’Essere nuovo, in divenire, oggetto, tra i suoi congiunti più prossimi, di appassionate investigazioni, meditazioni, discussioni spirituali…
«Jao – Aoth – Abaoth… » recitava la sua cantilena. «Jahu, jahu! – Ja – a – we – ilu, Ja – a – um – ilu.» E mentre quella nenia continuava, con le mani alzate, movimenti ritmici della testa e del corpo, sorrisi d’amore alla luna che tutto bagnava con la sua luce, nel volto di quel giovane solitario si poteva notare qualcosa di strano, di quasi terribile. Le sue devozioni, il suo colloquio lirico, o che altro fosse, sembravano rapirlo altrove, e il crescente oblio di sé in cui quelle parole e quei gesti lo cullavano, degenerare in qualcosa di vagamente inquietante. Non aveva dato molta voce al suo canto, né molta avrebbe potuto darne. Era aspra e immatura quella voce, ancora acuta, ancora quasi infantile, con l’insufficiente risonanza organica propria dei giovani. Ma adesso ogni tono venne a mancargli, la voce si spegneva soffocata e convulsa, il suo «Jahu, jahu!» era ormai l’ansante sussurro che saliva da un polmone vuoto d’aria, che egli tralasciava di riempire, e in quel momento il suo corpo si alterò: il petto si afflosciò, il muscolo addominale cominciò uno strano movimento di rotazione, il collo e le spalle si alzarono contraendosi, le mani tremarono, il muscolo estensore del braccio si protese come una corda, e in un attimo il nero dei suoi occhi scomparve: il bianco vuoto della sclerotica brillò sinistramente nella luce lunare che lo colpiva in pieno.
A questo punto bisogna dire che nessuno si sarebbe aspettato una tale anomalia nel contegno del giovane. Il suo accesso o attacco nervoso o quale altro nome si voglia dargli faceva l’effetto di qualcosa in stridente contrasto con la sua natura, che destava al tempo stesso preoccupazione e sorpresa; discordava troppo fortemente da quell’impressione di affabilità, di assennatezza, di urbanità che al primo sguardo e in modo così persuasivo suscitava la sua persona simpatica e senza dubbio un po’ troppo vanitosa. Se si trattava di una cosa seria, c’era da chiedersi a chi spettasse la cura di quell’anima, che in questo caso poteva forse considerarsi chiamata, ma era certamente in pericolo. Se invece era solo gioco o capriccio – e che, almeno in parte, fosse anche questo sembrò risultare dal comportamento del giovane adoratore della luna nelle circostanze che seguirono – la cosa doveva suscitare non poca inquietudine.
IL PADRE
Dalla parte della collina e delle abitazioni si sentì gridare il suo nome: «Giuseppe! Giuseppe!», due, tre volte, da distanza sempre più ravvicinata. Ma egli udì, o almeno ammise di aver udito, solo la terza chiamata; si sciolse allora rapidamente da quel suo stato, mormorando: «Eccomi!». Gli occhi tornati all’usuale sede, lasciò cadere le braccia, il capo, e sorrise vergognoso, abbassando il mento sul petto. Era la voce del padre, una voce mite, sempre commossa e leggermente querula, che lo chiamava. Era ormai vicina. Sebbene avesse già scorto il figlio presso il pozzo, il padre chiese ancora: «Giuseppe, dove sei?».
Poiché indossava lunghe vesti e poiché la luna, nella precisione illusoria e nella fantastica chiarità della sua luce, ingrandisce esageratamente gli aspetti delle cose, Giacobbe o Jaakow ben Jizchak, come scriveva quando doveva firmare con il suo nome, appariva di una grandezza maestosa e quasi sovrumana, là, fra il pozzo e l’albero degli ammaestramenti, più vicino a questo, che con l’ombra delle foglie punteggiava le sue vesti. L’ascendente della sua figura – lo sapesse egli o no – era accresciuto ancora di più dalla sua postura. Si appoggiava infatti al lungo bastone, afferrandolo molto in alto, così che l’ampia manica della sopravveste o mantello – una stoffa di mussolina di lana dalle grandi pieghe, con righe sottili dai colori smorti – ricadeva dal braccio sollevato sopra la testa e adorno al polso di un braccialetto di rame. Giacobbe, fratello gemello di Esaù e a lui preferito, contava allora sessantasette anni. La sua barba rada, ma lunga e ampia (unendosi ai capelli delle tempie, gli scendeva dalle guance in ciocche poco folte e così, fluente in tutta la sua ampiezza, gli cadeva sul petto) brillava argentea nella luna. Era una barba che cresceva libera, non arricciata né curata in alcun modo, in cui risaltavano le labbra sottili. Profonde rughe partivano dalle alette del naso affilato e si perdevano nella barba. I suoi occhi, sotto una fronte per metà coperta, a mo’ di cappuccio, dallo scialle fatto di un panno cananeo dai colori scuri, cadente in pieghe sul petto e rigettato sopra le spalle, i suoi occhi piccoli, bruni, lucidi, con borse flaccide percorse da venature delicate sotto le ciglia,...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Mito ed epicità. La conquista dell’umano in «Giuseppe e i suoi fratelli» di Fabrizio Cambi
- GIUSEPPE E I SUOI FRATELLI
- Prologo discesa agli inferi
- Le storie di giacobbe
- Tavola delle sigle e delle abbreviazioni
- Storia del testo
- Note
- Copyright