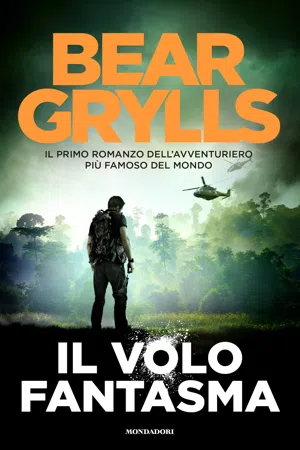I suoi occhi si aprirono.
Lentamente.
Ciglio dopo ciglio, lottando contro la spessa crosta di sangue che li teneva incollati l’uno all’altro. Un poco per volta, come crepe nel vetro, davanti ai bulbi oculari iniettati di sangue si aprirono delle fessure. Gli sembrò che la luce intensa gli bruciasse la retina, come se qualcuno gli puntasse un laser dritto negli occhi. Ma chi? Chi erano i nemici... i suoi aguzzini? E dove diavolo si trovavano?
Non riusciva a ricordare nulla di nulla.
Che giorno era? Anzi, che anno era? Com’era finito lì, dovunque si trovasse?
La luce del sole faceva un male d’inferno ma almeno, a poco a poco, stava ricominciando a vedere.
Il primo oggetto reale che Will Jaeger riuscì a distinguere fu lo scarafaggio. Gli balzò davanti agli occhi, sfocato, mostruoso e alieno, riempiendo per intero il suo campo visivo.
Per quanto riuscisse a capire, aveva la testa poggiata di lato a terra. Cemento. Coperto da una densa poltiglia marrone, Dio solo sapeva cosa fosse. Da quella posizione, lo scarafaggio sembrava avanzare deciso a infilarsi nella sua orbita oculare sinistra.
L’insetto fece vibrare le antenne in direzione di Jaeger e all’ultimo istante sparì, strisciando rapidamente oltre la punta del suo naso. E poi, lui sentì che gli si arrampicava lungo la guancia.
Lo scarafaggio si fermò da qualche parte vicino alla tempia destra... il punto più lontano dal pavimento, il più esposto.
Iniziò a esplorare con le zampe anteriori e le mandibole.
Come se stesse cercando qualcosa. Assaggiando qualcosa.
Jaeger sentì il primo morso, gli affondò nella carne: mascelle d’insetto che si facevano strada. Udì il sibilo, il sordo schioccare delle fauci che si serravano strappando lembi di carne morta. E poi – mentre un urlo muto gli si levava dalle labbra – si accorse che ce n’erano a decine, che gli stavano marciando addosso... come se fosse un cadavere.
Jaeger lottò per trattenere i conati, mentre una domanda gli rimbombava nel cervello: perché non riusciva a sentire le sue urla?
Con uno sforzo di volontà sovrumano, mosse il braccio sinistro.
Fu un movimento minimo, ma fu come se stesse provando a sollevare il mondo intero. A ogni centimetro, le articolazioni della spalla e del gomito lanciavano un grido di agonia, il ridicolo sforzo a cui li obbligava scatenava uno spasmo nei suoi muscoli.
Si sentì come uno storpio.
Per Dio, cosa gli era successo?
Che gli avevano fatto?
Serrando i denti e concentrandosi esclusivamente sulla sua forza di volontà, accostò il braccio alla testa, trascinando la mano lungo l’orecchio per sfregarlo disperatamente. Le dita sfiorarono... delle zampe. Animalesche zampe d’insetto, squamose, irsute, che vibravano e si contorcevano mentre lo scarafaggio si sforzava di entrare ancora più a fondo nel suo canale auricolare.
Tirateli fuori da lì! Tirateli fuori! Tirateli FUOORIII!
Gli venne da vomitare, ma le sue viscere erano vuote. Non c’era che una disgustosa pellicola secca, cadaverica, che gli ricopriva le pareti dello stomaco, la gola, la bocca, persino le narici.
Merda! Le narici! Stavano cercando di infilarsi anche lì!
Jaeger urlò di nuovo. Più a lungo. Più disperato. Non è così che voglio morire, Dio, ti prego, non così...
Più e più volte scavò con le dita nei suoi orifizi, gli scarafaggi scalciavano e sibilavano con tutta la loro rabbia d’insetto mentre li tirava fuori.
Finalmente, qualche scampolo di suono si fece strada fino alla sua coscienza. Dapprima, le sue urla iniziarono a riecheggiargli nelle orecchie sanguinanti. E poi si accorse che, misto a esse, c’era un altro suono... qualcosa di ancor più terrorizzante delle decine di insetti intenti a banchettare col suo cervello.
Una voce umana.
Gutturale. Crudele. Una voce che traeva piacere dal dolore.
Il suo carceriere.
Quella voce spalancò le dighe dei ricordi. La prigione di Black Beach. Il carcere alla fine del mondo. Un luogo in cui la gente veniva mandata per subire orribili torture e poi morire. Jaeger era stato sbattuto là dentro per un “crimine” che non aveva commesso, su ordine di un dittatore folle e sanguinario. Era stato allora che il vero orrore era cominciato.
In confronto all’inferno in cui si era svegliato, Jaeger avrebbe preferito persino la pace oscura dell’incoscienza. Qualunque cosa al posto delle settimane trascorse sotto chiave, in un luogo peggiore della dannazione... la sua cella. La sua prigione.
Costrinse la sua mente a ritirarsi verso le morbide, informi, mutevoli sfumature di grigio che l’avevano protetto, prima che qualcosa – che cosa? – lo trascinasse in quel presente indicibile.
I movimenti del suo braccio destro si fecero più contenuti.
Infine ricadde a terra.
Lasciare che gli scarafaggi banchettassero col suo cervello: persino quello era preferibile.
Poi la cosa che l’aveva svegliato lo colpì un’altra volta – un’ondata di acqua gelida in faccia, come lo schiaffo di un’onda marina –, solo che l’odore era totalmente diverso. Non il profumo ghiacciato, puro e rinvigorente dell’oceano, ma un tanfo fetido, il tanfo salmastro di un orinatoio che non vedeva una goccia di disinfettante da anni.
Il suo torturatore rise di nuovo.
Si stava divertendo parecchio.
Svuotare il secchio del piscio in faccia al prigioniero: che c’era di meglio?
Jaeger sputò il liquido disgustoso. Sbatté le palpebre per farlo uscire dagli occhi che bruciavano. Almeno, lo schizzo putrefatto aveva scacciato gli scarafaggi. La sua mente si mise a cercare le parole giuste, l’insulto perfetto da sputare in faccia al carceriere.
La dimostrazione che era vivo. Un gesto di resistenza.
«Vai a...»
Jaeger aprì la bocca, gracchiando il tipo di insulto che gli avrebbe assicurato una frustata con la canna dell’acqua che aveva imparato a temere.
Ma se non avesse opposto resistenza sarebbe finito. Resistere era tutto ciò che gli rimaneva.
Eppure non riuscì a finire la frase. Le parole gli si bloccarono in gola.
All’improvviso, un’altra voce si intromise, una voce così familiare – fraterna – che per qualche infinito istante credette di sognare. L’incantesimo iniziò dolcemente, ma a poco a poco crebbe di intensità e volume, una cantilena ritmata e colma, in qualche modo, della promessa dell’impossibile...
«Ka mate, ka mate. Ka ora, ka ora.
Ka mate, ka mate! Ka ora, ka ora!»
Jaeger avrebbe riconosciuto quella voce ovunque.
Takavesi Raffara: come faceva a essere lì?
Quando giocavano insieme nella squadra di rubgy dell’esercito britannico, era Raff a guidare l’Haka, la tradizionale danza di guerra maori che dava inizio alla partita. Sempre. Si sfilava la maglia, serrava i pugni e si faceva avanti per guardare gli avversari dritto negli occhi, con le mani che battevano il petto massiccio, le gambe come due tronchi d’albero a far da colonne, le braccia come arieti pronti all’assalto. Il resto della squadra, Jaeger incluso, lo fiancheggiava: erano impavidi, inarrestabili.
Raff aveva gli occhi fuori dalle orbite, la lingua gonfia, il volto contratto in uno spasmo di slancio guerriero, mentre scandiva ogni verso come un tuono.
«KA MATE! KA MATE! KA ORA! KA ORA!»
Morirò? Morirò? Vivrò? Vivrò?
Raff si era dimostrato altrettanto inarrestabile quando si erano trovati fianco a fianco sul campo di battaglia. Il miglior compagno che si potesse immaginare. Maori di nascita e membro del commando dei Royal Marines per destino, Raff aveva combattuto assieme a lui ai quattro angoli della terra: era come un fratello per Jaeger.
Jaeger ruotò gli occhi verso destra, nella direzione da cui proveniva il canto.
Riuscì appena a scorgere una sagoma ai limiti del suo campo visivo, all’estremità destra delle sbarre. Imponente. In confronto a lui, pure il carceriere sembrava un nano. Il suo sorriso fu come un limpido raggio di sole che irrompeva dopo il buio di una tempesta apparentemente eterna.
«Raff?» Quell’unica parola gli uscì con voce stridula, segnata da un’incredulità appena sospesa.
«Sì, sono io.» Quel sorriso. «Ti ho visto in condizioni peggiori, amico. Come quando ti ho dovuto trascinare fuori da quel bar di Amsterdam. Comunque, è meglio darti una ripulita. Abbiamo un volo della British Airways per Londra, prima classe.»
Jaeger non rispose. Cos’erano quelle parole? Come poteva Raff essere lì, in quel posto, apparentemente così vicino?
«Meglio mettersi in marcia» lo esortò Raff «prima che il tuo amico, il maggiore Mojo, cambi idea.»
«Ah, Bob Marley!» Il torturatore di Jaeger diede una pacca sulla spalla di Raff, imponendosi una giovialità scherzosa nonostante lo sguardo malevolo. «Bob Marley, sei un portento.»
Raff sorrise da un orecchio all’altro.
Jaeger non aveva mai visto nessuno che fosse in grado di sorridere a qualcuno e di lanciargli allo stesso tempo un’occhiata capace di far gelare il sangue. Il riferimento a Bob Marley doveva avere a che fare con la capigliatura di Raff, capelli lunghi, intrecciati, nel tradizionale stile maori. Come molti avevano imparato sul campo di rugby, Raff non apprezzava che si mancasse di rispetto all’acconciatura che aveva scelto.
«Apri la cella» ruggì. «Io e il mio amico Jaeger ce ne andiamo.»