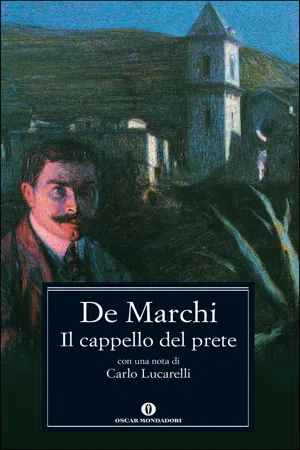Il barone Carlo Coriolano di Santafusca non credeva in Dio e meno ancora credeva nel diavolo; e, per quanto buon napoletano, nemmeno nelle streghe e nella iettatura.
A vent’anni voleva farsi frate, ma imbattutosi in un dotto scienziato francese, un certo dottor Panterre, perseguitato dal governo di Napoleone III per la sua propaganda materialistica ed anarchica, colla fantasia rapida e violenta propria dei meridionali, si innamorò delle dottrine del bizzarro cospiratore, che aveva anche una testa curiosa, tutta osso, con due occhiacci di falco, insomma un terribile fascinatore.
Per qualche anno il barone, detto “u barone”, lesse dei libri e prese la scienza sul serio: ma non sarebbe stato lui, se avesse per amore della scienza rinunciato alle belle donne, al giuoco, al buon vino del Vesuvio, e ai cari amici. Il libertino prese la mano sul frate e sul nichilista, e dalla fusione di questi tre uomini uscì “u barone” unico nel suo genere, gran giuocatore, gran fumatore, gran bestemmiatore in faccia all’eterno. Nulla, e nello stesso tempo amabile camerata, idolo delle donne, coraggioso come un negro, e a certe lune fantastico come un bramino.
Noi qui parliamo del barone della sua prima maniera quando non aveva più di trent’anni. Napoli allora era tutta una festa garibaldina, bianca, rossa e verde. Le donne abbracciavano i bei soldati nella via e alzavano i bambini sulle braccia, perché Garibaldi li battezzasse nel nome santo d’Italia. Innanzi al ritratto dell’eroe si accendevano i lumi e si appendevano corone di fiori, come davanti a san Gennaro e alla Madonna Santissima.
Santafusca prese una parte breve e brillante nelle ultime scaramucce di quel tempo e fu anche ferito alla fronte. Gliene rimase una cicatrice sopra il ciglio…, ma i bei tempi erano passati.
Oggi l’uomo aveva quarantacinque anni, una gran barba nera, un volto abbruciato dal sole e dai liquori, una gran voglia di godere la vita e una miseria profonda.
Non godeva più credito né presso gli amici, né presso i parenti, ch’egli aveva disgustati colla sua vita dissipata e colla sua bestiale empietà.
Al frate, al nichilista, al libertino si aggiungeva ora un pitocco disperato, costretto a quarantacinque anni a mendicare dieci lire alla sua guardarobiera, se voleva pranzare e bere un cognac.
Al club avevano pubblicato il suo nome nell’albo degli insolvibili, e poiché non pagava più i debiti del giuoco, tutti lo fuggivano ora come la lebbra.
Sì, il barone Carlo Coriolano di Santafusca si sentì veramente la lebbra addosso quel dì che il canonico amministratore del Sacro Monte delle Orfanelle gli mandò a dire per l’ultima volta che, se entro la settimana non restituiva una cartella di quindicimila lire, il Consiglio d’Amministrazione avrebbe denunciata la cosa al Procuratore del Re.
I Santafusca per antico diritto avevano parte nell’Amministrazione del Sacro Monte, e nella sua qualità di patrono e di consigliere “u barone” aveva più volte pescato nelle strette del bisogno in fondo alla cassa dell’istituto, dando false o poco solide garanzie. Ora i gruppi erano venuti al pettine.
Il canonico diceva chiaro:
«Se vostra eccellenza non rende a questa pia Casa la cartella di lire quindicimila, il Consiglio sarà nella dolorosa necessità di portare il fatto davanti ai Tribunali.»
Davanti ai Tribunali “u barone” non sarebbe mai andato, questo era certo. Eravamo al lunedì santo e c’eran davanti quasi quindici giorni alla fatale scadenza. In quindici giorni un uomo d’ingegno, che non ha voglia ancora di farsi saltare le cervella, deve trovare la maniera di non andare in prigione.
Quale prigione avrebbe potuto tenerlo dentro? O che non ha più boschi la Calabria ed è proprio finita la razza dei briganti?
Non era la prima volta che un Santafusca aveva battuta la campagna e un suo avolo, don Nicolò, era stato con Fra Diavolo sei mesi su per le rupi della Majella ai tempi dei tempi: ma con tutto ciò il barone sentiva che un uomo in quindici giorni non ha tempo neppure di diventare un brigante.
Bisognava adunque trovare qualche altro espediente più spiccio e meno melodrammatico. Fuggire? Non era il caso di pensarci, perché quando si è poveri si viaggia male. Chiedere un prestito? A chi, se non c’era più un cane che gli volesse dare un quattrino? Giocare, tentar la sorte? Nessuno voleva mescolare con lui un mazzo di carte, e poi, non sempre chi giuoca vince.
Non rimaneva che la sua villa di Santafusca, lontana un cinque chilometri da Napoli, che poteva fruttare ancora qualche migliaio di lire, a patto però di vendere fino all’ultimo chiodo, perché un terzo era ipotecato già al marchese di Vico Spiano, un terzo era una rovina e l’altro terzo rappresentava un rifugio, un tetto, un asilo d’un pover uomo sulla terra.
Anche vendendo ciò che rimaneva di netto, non avrebbe potuto raggranellare quindicimila lire e dopo egli sarebbe rimasto un vagabondo intero, nudo nato, senza nemmeno un guanciale per posare il capo.
Se un barone di Santafusca, si noti, contava ancora per qualche cosa nel mondo e se poteva sperar di trovare ancora un cento lire per la fame e per la sete, questo credito, per quanto avariato, gli proveniva da quel vecchio palazzo, che imponeva ancora un certo rispetto al volgo e che sosteneva colla catena della tradizione un uomo ridotto ormai a far la parte di Pulcinella.
Bisognava trovare le quindicimila lire e già eravamo giunti al giovedì santo senza alcun risultato.
Finalmente gli venne in mente prete Cirillo.
Chi era prete Cirillo?
Non v’era donnicciuola o pescivendola o camorrista delle Sezioni di Pendino e di Mercato che non conoscesse “u prevete”, che abitava nei quartieri più poveri, in una soffitta chiusa in mezzo ai comignoli delle case, ove non mai scende l’occhio benedetto del sole, e non regna sovrano che il vizio ed il puzzo del pesce, che il popolino frigge sugli usci e nella via.
A vederlo camminare per le strade, non si sarebbe data una buccia di arancia per quel pretuzzo tutto cappello, vestito di un abito polveroso, sotto un mantello verdognolo e ragnoso che faceva da staccio al vento, con un viso tinto proprio come il pesce fritto.
Le mani erano lunghe, magre, lucide, come i fusi d’ulivo, con unghie più forti degli uncini che tirano nel porto i barili e i sacchi del merluzzo.
Le gambette, asciutte come gli stinchi dei santi, andavano a finire in due scarpe sconquassate, grandi come i burchielli che fanno il servizio di cabotaggio tra Napoli e Messina.
Prete Cirillo era un uomo pieno di denari, che egli aveva radunati un poco coll’usura prestando ai pizzicagnoli, ai pescivendoli, ai galantini della Sezione, e molto colle vincite al lotto. Si diceva che “u prevete” avesse i numeri e, coll’aiuto di certi calcoli cabalistici trovati da lui su un libro vecchio, vincesse al lotto ogni volta che gli piacesse di vincere. A qualcuno aveva anche regalati dei numeri buoni, ma il negromante era geloso e non si lasciava pigliare da tutti.
È in casa del prete Cirillo che noi troviamo ora “u barone”, che durante le feste di Pasqua non aveva perduto il suo tempo.
“U prevete” offrì una sedia di legno colle paglie rotte, andò a chiudere l’uscio ben bene, e tornò a sedere davanti a un tavolino ingombro di carte e di libri vecchi. Allora disse “u barone”:
«Avete pensato, don Cirillo?»
«Ci ho pensato.»
«E la villa l’avete veduta?»
«L’ho vista, eccellenza.»
«Vi piace?»
«Poco mi piace, ma non son lontano dall’acquistarla. Vi do ventimila lire, eccellenza.»
«Voi fareste bestemmiare un eremita, don Cirillo. S’era detto quarantamila in principio, poi trenta, ora dite venti, per il sangue di…» “U barone” cominciò a sfilare bestemmie.
«Ebbene ve ne darò trenta,» interruppe il prete che non amava le brutte parole «ma voi dovete dimostrarmi che la casa è netta da ogni ipoteca.»
«Io vi ho giurato che essa è netta come questa mano e un gentiluomo non giura due volte.»
«Un gentiluomo non ha bisogno di giurare. Bastano i documenti.»
«Voi condurrete con voi il vostro notaio.»
«La villa non l’acquisto per me e nemmeno coi denari miei. Che cosa devo farne io, povero servo di Dio, di una villa?»
«Uh, chi vi crede? si dice che avete il pagliericcio pieno d’oro.»
«Guardate, in nome di Dio, se questa è la casa del ricco Epulone.»
«Si dice che voi avete i numeri del lotto.»
«Anche questa è una calunnia della gente ignorante e beffarda. Se io avessi i numeri, sarei ricco, e, se fossi ricco, non vivrei di una piccola messa e sui poveri morti in mezzo a una gente che mi perseguita.»
«Non è vero che voi vincete un terno o un quaterno tutte le settimane?»
«O pazienza di Dio! e voi potete credere, eccellenza, a queste favole, voi un uomo di mondo? Una volta sola per salvarmi dalle minacce dei miei nemici ho regalato dei numeri buoni che hanno vinto, e da quel dì non ho più pace, nemmeno sull’altare. Sì, fin nella chiesa sento la voce delle donne che dicono: “Oh pe l’ammore de Dio, damme tre nummere! Fallo pe san Gennaro beneditto!”.»
Prete Cirillo parlava con affanno, con paura, con sincerità, aprendo le dieci dita di legno, tremolanti in aria.
«Io posso salvarvi da queste persecuzioni» disse il barone.
«Questo gennaio una masnada di camorristi mi ha sequestrato il corpo e mi ha tenuto rinchiuso in un sotterraneo, minacciandomi di morte e battendomi colle catene, se io non davo i numeri.»
«Li avete dati?»
«Ho invocato tanto la Madonna del Carmine e il divino Spirito che mi illuminassero e mi salvassero. Li ho dati.»
«Son venuti?»
«Tutti.»
“U barone” alzò la testa e una grande maraviglia gli gonfiò gli occhi. A guardarsi intorno c’era proprio da credere d’essere nella casa del mago.
«Fu la bontà divina che mi ha voluto salvo e non già qualche virtù cabalistica, come crede la gente: ma da quel giorno la mia pace è morta. Le mie scale son sempre assediate di poverelli che vogliono li nummeri e devo spesso rifugiarmi in luogo sacro per non essere preso un’altra volta, incatenato e torturato.»
«Ebbene, io vi aiuterò, don Cirillo, ma voi dovete essere più giusto e star saldo alle quarantamila lire.»
«Voi aiutate me, io aiuto voi, eccellenza. Voi salvate me dalle mani dei tristi, io salvo voi… dalla prigione.»
“U barone” si mosse dalla sedia e girò intorno gli occhi spaventati, alzando un poco un certo bastone di canna col manico d’argento, a cui di tanto in tanto appoggiava la bocca.
«Non è forse vero che voi dovete per la domenica in albis restituire una somma che non trovate più né in cielo, né in terra?»
«Voi siete un padre inquisitore» mormorò il barone torbido.
«Io dovevo prendere le mie informazioni, non è giusto? Non per questo rinuncio ad aiutarvi; anzi, vi dico, aiutiamoci insieme. Voi avete...