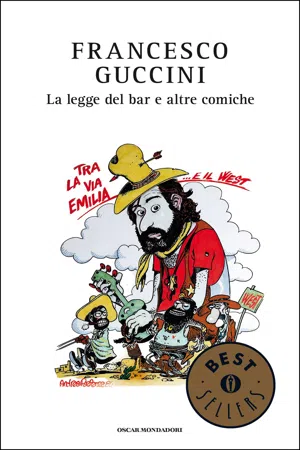I “cori” si dividono anzitutto in:
a. Cori trentini propriamente detti;
b. Cori non trentini, ma che venderebbero l’anima per essere trentini.
I cori trentini propriamente detti
Sono formati da una trentina di robusti giovanotti trentini propriamente detti che hanno il viso cotto dalle intemperie e si chiamano tutti Bepi e a volte, ma in casi più rari, Bepin. Vestono con camicie di flanella scozzesi e pantaloni di velluto al ginocchio, calzettoni di lana di colori sgargianti e scarponi da montagna.
Bevono solitamente quantità alluvionali di vino e di grappa, che chiamano, con curioso vocabolo, sgnapa. Dopo queste bevute è di rigore fingere di ubriacarsi sordidamente e cantare canzoni oscene per terze. Nel corso di queste canzoni nominano sovente mitici personaggi del Trentino detti putele. Se usano copricapo, indossano un caratteristico berretto grigioverde con piuma, definito capelo da alpin.
Esclamazione preferita: da sobri “ostreghetta” (ostrichetta?); dopo abuso di bevande alcoliche: non riportabili, per evidenti motivi di pubblica morale.
Repertorio caratteristico: è quanto mai vasto e differenziato. Ne daremo alcuni esempi:
- La montanara, Le belle montagne, O monti, o monti, I nostri bei monti, Su per quelle montagne, La catena delle Alpi, Fior de le nostre montagne, Pastor dei monti, Macongranpenalerecagiù, ecc.
- Circa quattrocentoventi canzoni della guerra ’15-18.
- Un paio almeno di ninna-nanne (per esempio: Dormi bambin su le montagne, Nina-nana a la montagnard).
I cori non trentini
Sono formati da una trentina di distinti signori (professionisti, artigiani, impiegati per lo più; scarseggiano misteriosamente i domatori di leoni, i preti operai e i pescatori di cozze); questi hanno il viso pallidissimo tipo lavoro al chiuso per undici mesi, e si chiamano tutti rag. Paolozzi o sig. Stupazzoni, ma darebbero via l’anima per potersi chiamare Bepi o Bepin.
Vestono ciascuno secondo la propria professione, e cioè con camicie di flanella scozzesi e pantaloni di velluto al ginocchio, calzettoni di lana di colori sgargianti e scarponi da montagna (utilissimi per arrampicarsi sugli sportelli bancari).
Bevono solitamente quantità alluvionali di vino e di sgnapa. (Un componente di coro, nel ’57, la chiamò in un momento di debolezza “grappa” e fu radiato da tutti i cori d’Italia fino al ’68. Purtroppo il poveretto non sopravvisse fino al giorno della riabilitazione. Cogliamo l’occasione per ricordare ai responsabili di cori di non essere così drasticamente severi con i componenti del proprio gruppo – vedasi Pene corporali – un po’ d’umanità non guasterebbe!)
Dopo queste bevute si ubriacano sordidamente e cantano canzonacce goliardiche di dubbio gusto per quinte, seste, e intervalli di nona. Nel corso di queste canzoni nominano sovente mitici personaggi cittadini detti putele. Si travestono sovente da edelweiss e parlano fra loro uno stranissimo gergo consistente in un tentativo di veneto penosamente intercalato da pesantissime inflessioni locali.
Esclamazioni preferite: da sobri non riportabili per evidenti ragioni di pubblica morale; dopo abuso di bevande alcoliche “ostreghetta” (oh piccola strega?).
Repertorio caratteristico: è quanto mai vasto e differenziato. Ne daremo alcuni esempi:
- Un paio almeno di ninna-nanne (per esempio: Nina-nana a la montagnard e Dormi bambin su le montagne).
- Quattrocentoventi canzoni circa della guerra ’15-18.
- La montanara, Monte Caprin, Monte Cimin, Monte Camin, Monte Sgnapin, La sù quell’alte cime, Oh, i bei edelwais, Edelwais de le montagne, Edelwais montagnard, La catena degli Appennini, ecc.
Direttamente connesso con l’aspetto folcloristico e tradizionale del repertorio (quanto mai vasto e differenziato) è quell’aspetto di un coro che definiremo “problema della sua denominazione” o più semplicemente:
Nomi di un coro secondo la sua tipologia
Non è spesso facile trovare l’adatto nome per un coro: come abbiamo già avuto modo di constatare la vastità e la differenziazione di repertorio, per non parlare della diversità intrinseca dei singoli componenti fanno del “nome del coro” uno dei più vasti e curiosi esempi di come la fantasia umana possa sbizzarrirsi. In effetti, un eventuale elenco di nomi di cori sarebbe quanto mai vasto e differenziato.
I trentini propriamente detti sono, più che aiutati, ispirati nello scegliere il nome per il loro gruppo dalla bella rigogliosa natura che li circonda.
Non sarà difficile quindi trovare nei cori trentini propriamente detti nomi ispiratissimi e toccantissimi come Gruppo Corale rag. Amilcare Paolozzi, Società Filarmonica Corale sig. Stupazzoni, Gruppo amici del bel canto in coro don Eusebio Smazzolati, Gruppo Coro Corale da fare assieme Bepi Bepin, ecc. Già più difficile, con meno agganci alla realtà quotidiana, la scelta del nome del coro per il coro non trentino, ma qui forse una maggiore proprietà e ricercatezza di linguaggio supplisce agli, ahimè, scarsi riferimenti naturali trovabili in una città.
Così i cori non trentini si chiamano con nomi astratti di fantasia come per esempio: Coro Monte Cimin, Coro Monte Canin, Coro Monte Caprin, Coro Monte Sgnapin, Coro Monte Bepi o Bepin, Coro Edelwais, Coro Cima, Coro Croda, Coro Cengia, Coro Picco, Coro Alpenstock, Coro Cordata, ecc.
A questo punto delle nostre note, purtroppo necessariamente scarne, molti lettori saranno invogliati a entrare a far parte di un coro, o in mancanza di esso, a costruirsene uno con le proprie mani. Niente di più facile. Non sarà mai come un coro acquistato in una dispendiosa “boutique”, ma quanta soddisfazione in più!
Per i trentini propriamente detti non esistono problemi di sorta. Infatti, come molti sanno, esiste da tempo nel Trentino l’arruolamento obbligatorio al coro, della durata di venticinque anni che sostituisce a tutti gli effetti di legge il normale servizio militare fatto nelle altre parti d’Italia.
Dopo il normale servizio si può decidere per un’eventuale rafferma al coro, con possibilità, per i più meritevoli, di promozione a segretario del coro (vedi) o addirittura a facente funzioni maestro (vedi).
Per gli altri, esistono possibilità di reinserimento nella vita civile, dopo un corso semigratuito di riabilitazione psico-fisica. Interessanti anche le possibilità di impiegarsi come interpreti presso i tanti cori non trentini. Per tutti i non trentini, invece, daremo qui di seguito qualche utile consiglio sul:
Come organizzare un coro
La prima cosa da fare per organizzare un coro è trovare un maestro che lo diriga. I maestri che possono dirigere un coro si dividono in:
- maestro trentino propriamente detto;
- maestro propriamente detto;
- facente funzioni maestro.
Per diventare maestro trentino propriamente detto bisognerà possedere i seguenti requisiti:
- essere trentino propriamente detto;
- chiamarsi Bepi o Bepin;
- essere figlio o nipote di Amilcare Paolozzi;
- avere fatto la guerra ’15-18;
- possedere il più “vecio capelo da alpin”;
- riuscire a farsi fuori quindici fiaschi e ventisei grappe in mezz’ora senza fare una piega;
- avere scritto almeno una ninna-nanna dal titolo Ninanana a la montagnard;
- riuscire a gridare più forte di tutti la frase: “Vegni qua, bocia, che femo una cantada”;
- avere la faccia cotta dalle intemperie;
- avere la camicia più scozzese e i calzettoni più colorati.
Come si sarà notato, non è considerato indispensabile conoscere la musica. Questo requisito non è richiesto nemmeno per il maestro propriamente detto.
Questi invece dovrà possedere i seguenti requisiti:
- Possedere un nome da maestro da coro.
Il maestro da coro deve avere un nome semplice e vigoroso, che suoni bene con le parole “armonizzato da”, o che possa, una volta diventato per motivi misteriosi o appoggi scandalosi, famoso, dare il nome a un secondo o successivi cori. Abbiamo già visto infatti in quali difficoltà ci si imbatte per trovare un nome adatto a un nuovo gruppo corale. Nomi adattissimi per maestri da coro sono per esempio: Amilcare Paolozzi, Bepi o Bepin, Eusebio Smazzolati, ecc.1
- Possedere un ampio e fluente gestire.
Come già osservato, non è assolutamente indispensabile conoscere la musica per dirigere un coro, anzi, il conoscerla, potrebbe essere di serio impaccio e portare a gravi inconvenienti, poiché è noto come i componenti dei cori non solo non conoscano la musica ma ne diffidino.
Il maestro quindi dovrà dirigere con movimenti del corpo, torsioni e smorfie facciali, capriole, salti acrobatici e accenni a passi di danza classica o no, insomma, con tutto ciò che attraverso il gesto serva a trasmettere i sentimenti del suo animo e i lampi della sua intelligenza alle menti dei coristi, non sempre, ci duole ammetterlo, fra le più aperte.
Per esempio: occhi socchiusi tipo coma profondo, bocca a cul di gallina, mani con palme rivolte in basso fatte oscillare in su e in giù, non significano, come un profano potrebbe erroneamente intendere, probabilmente in mezzo a quei funghi c’era un’amanita fhalloides e sto malissimo, ma trasmetterà immediatamente ai sagaci coristi il messaggio musicale “Qui fate piano per l’amor di dio che i vicini hanno già minacciato tre volte di chiamare il 113”.
Altro esempio: viso paonazzo infarto, vene del collo come corde da rimorchiatore, bocca a galleria d’autostrada, pugni rivolti al cielo mossi su e giù con ira significheranno “Qui tirate fuori quel po’ di fiato che avete o vi spacco la faccia”. Ancora: mani in tasca, posizione di completo rilassamento su seggiola, sigaretta all’angolo della bocca, occhiate distratte lanciate su giornale a fumetti posto sul leggio significano: “Qui fate un po’ come vi pare tanto questo pezzo lo ha armonizzato un altro e a me non me ne frega niente”.
Naturalmente, pur non conoscendo la musica, è indispensabile per il maestro fingere di conoscerla perfettamente. Non sarà difficile raggiungere questo scopo ricorrendo a pochi ma efficaci trucchi che avranno buon gioco sulla buona fede e la misconoscenza musicale dei coristi.
Dovrà quindi, ripetutamente, guardare a caso un gruppo di coristi a scelta e urlare ad alta voce con ira: “Chi ha calato quel sol di un sesto di tono!?”. Naturalmente egli non solo non può sapere chi ha calato quel sol, egli non ha neanche la più pallida idea di cosa sia un sol.
Questo audace bluff però lo renderà importante e ben visto agli occhi dei coristi, i quali sosterranno a loro volta i “bluff” del maestro fingendo di conoscere la musica. Così se il maestro affermerà distrattamente che in quel tal passaggio c’è un intervallo di terza rinforzato di nona terzarolato ai velacci e sgalbedrato al vapore, essi si guarderanno bene dal dire “Che sciocchezze!”, ma dandosi di gomito e ridacchiando con aria complice diranno “Mi sembrava bene!” oppure “In un primo momento non mi sembrava così terzarolato ma poi...” e saranno pronti a sostenere tutto ciò fino alla morte per tortura.
Naturalmente, essendo che la “società nemici del sol” non è ancora stata fondata, il maestro non dovrà ripetere la frase suddetta in continuazione, ma variarla ogni tanto per non insospettire. Così, potrà audacemente mutarla con combinazioni a scelta del tipo “Chi ha alzato quel fa di un terzo di tono?!”. Quello che importa soprattutto è fingere ira e estrema sicurezza. Può accadere, ma solo in casi rari (ne è segnalato uno nel ’32 in provincia di Bergamo) che un corista, per eventuali trascorsi da sacrestano o nell’Arma, abbia una leggera e confusa infarinatura musicale, sufficiente però a fargli scoprire questi semplici ma efficaci trucchi. Basterà tenerlo d’occhio, e ubriacarlo spesso o corromperlo con piccole somme di denaro. Se recidivo – si ricorrerà alle Punizioni corporali (vedi).
Per quanto riguarda invece il facente funzioni maestro, egli sarà scelto direttamente fra i componenti del coro. Sarà il maestro stesso a nominarlo, scegliendolo non tanto per una sua spiccata attitudine musicale (come abbiamo visto, difficilmente riscontrabile fra i coristi) ma piu...