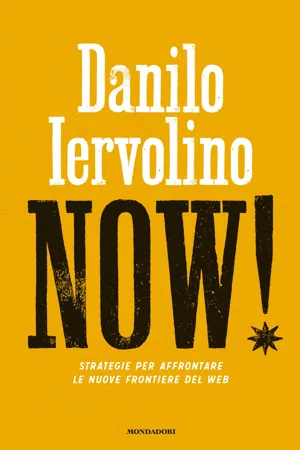Chi è nato prima: l’uomo o la macchina? La risposta è certa: è nata prima la macchina, e niente e nessuno, sulla terra, ha saputo più dell’uomo utilizzarla in maniera sublime o atroce.
Secondo il vocabolario Treccani, il sostantivo «macchina» identifica «in senso storico e antropologico, qualsiasi dispositivo o apparecchio costruito collegando opportunamente due o più elementi in modo che il moto relativo di questi trasmetta o anche amplifichi la forza umana o animale o forze naturali (come quelle prodotte dall’acqua e dal vento), e capace di compiere operazioni predeterminate con risparmio di fatica o di tempo».
Semplificando, appare evidente che qualsiasi forma di vita animale evoluta abbia adoperato macchine semplici, così come è incontrovertibile che l’uomo sia comparso milioni di anni dopo la stragrande maggioranza delle specie animali –estinte e non– che hanno popolato e popolano tuttora il nostro pianeta.
Cos’è, oggi, una macchina? Anzi, la macchina?
La definizione sopra riportata non basta più. La macchina non è un sistema di pulegge e funi, non un meccanismo fatto di giunti, snodi e bracci, né un insieme di circuiti, bensì... un concetto.
Oggi, «macchina» è sinonimo di «Web», di quell’organismo sintetico eppure vivo a cui, volenti o nolenti, siamo indissolubilmente connessi.
Vita chiama vita, vita genera vita, così è accaduto che una creatura vivente, l’uomo, per la prima volta nella storia dell’evoluzione naturale si sia riprodotta generando una progenie composita, il cui genoma, a questo punto, si compone di un misto di geni naturali e artificiali.
Parlo di vita reale.
E ancora di una seconda, reale anch’essa: l’e-life.
La nostra società ha amplificato e differenziato il concetto di esistenza; oggi possiamo parlare di esistenza in Rete, di una duplice occasione di esistere.
Il concetto di second life non mi è mai piaciuto, l’ho sempre sentito alieno, estraneo, artificioso.
Vedo la e-life, la vita sul Web, come un’esistenza che va vissuta con lo stesso impeto di quella organica, in maniera ubiqua, portandosi addosso e dentro la macchina che abbiamo generato e che, adesso, fa parte di noi.
Una macchina, il Web, che, nella contemporaneità, è sia figlia sia genitrice, capace di generare vita e pensiero.
L’osmosi tra le due fa sì che i percorsi non presentino una doppia velocità, una per la vita «vera» e una per l’e-life, dato che l’esistenza in quanto tale, organica, non ci blandisce con promesse impossibili da mantenere, non c’inganna.
Gli equivoci li creiamo noi, con le nostre aspettative.
Oggi possiamo trovare la stessa cosa nel Web. Non ha blandito nessuno, non ha fatto promesse impossibili da mantenere: il valore di Internet avrebbe potuto essere raccontato, sbandierato, gonfiato, venduto e svenduto ai quattro venti, raccontato dagli eccessi della tecnologia, artefatto... Non è accaduto.
La macchina non ha promesso niente che non potesse mantenere.
Come la vita reale, organica, l’e-life ci consente di vivere un universo fatto di due vite che s’intersecano, offrendo possibilità immense. Opportunità. Non promesse fasulle.
La macchina ha prodotto isolamento?
È vero.
Ha reso infelici e disadattati alcuni individui?
Verissimo.
Ha fatto sì che qualcuno perdesse affetti e amici?
Certo.
In misura non maggiore e non minore di come accade nella realtà.
La macchina, ripeto, non va subìta, bensì vissuta.
E nella vita reale queste cose accadono allo stesso modo che nell’e-life, nel «sistema integrato uomo-macchina».
Le forme di vita organica si evolvono.
Indiscutibile.
La macchina no, il Web non lo fa.
Falso!
Il Web si evolve con la stessa potenza dell’individuo che interagisce con esso durante la propria e-life; riceve forza e la restituisce almeno con la stessa spinta. Come accade nel nostro mondo. Il Web è un «habitat mentale di sviluppo». Un concetto semplice, che contiene un potere incalcolabile.
Potrei continuare per pagine e pagine, ma preferisco concentrarmi sul messaggio che penso sia contenuto nella composita, favolosa bottiglia che sto tratteggiando.
Il rapporto profondo tra uomo e macchina è indissolubilmente legato all’aspirazione a vedere oltre: uno sforzo immane, costante, condotto attraverso i secoli mediante l’intima connessione reciproca tra immaginazione e realizzazione.
La macchina, oggi, rappresenta sempre più la prova che il sogno millenario di una scienza simbiotica, capace di fondere elementi umani, vivi, con tecnologia spinta all’estremo, è una realtà generata e spinta dalla fantasia. Il sogno, quindi, diventa elemento tangibile del quotidiano, un fattore da esaltare, un’idea propulsiva per lo slancio verso il nuovo, senza, però, dimenticare i valori portanti del nostro essere uomini: il rispetto per gli altri, i doveri verso se stessi e nei confronti delle regole della convivenza civile.
Ormai non è più possibile definire banale o semplicistica la considerazione della tecnologia come prodotto dell’uomo in base alla tradizionale logica causa-effetto, pena il ritrovarsi confinati nel regno dell’incongruenza ottusa, miope. Uomo e macchina interagiscono attraverso complessi rapporti, influenzandosi reciprocamente e prefigurando il superamento dell’imponente frontiera che li vedeva comunque separati.
Oggi, ora, in questo momento, è possibile pensare in maniera realistica a una tecnologia che diventa trama e ordito della quotidianità, filo che percorre i nostri abiti cucendoci addosso un’innovazione che scompare, fondendosi con la persona. Diventando persona.
Chiariamoci: senza l’uomo, sarebbe stato impensabile che la tecnologia potesse far ingresso sulla scena o, ancor di più, arrivare a dominarla.
Quando diciamo «uomo» ci riferiamo a un soggetto collettivo di cui non è possibile individuare le singole volontà che compongono l’insieme: quindi possiamo leggere l’innovazione tecnologica contemporanea come un aggregato di impulsi inscindibili tra loro e provenienti da una pluralità, formato non solo da istanze tecniche, ma anche da necessità culturali, sociali, economiche, comportamenti in linea con la sostenibilità.
Più che difficile, risulta inutile tentare di individuare con precisione cause e fonti del progresso tecnologico, ma ciò non deve alimentare il paradosso che vorrebbe la tecnologia dotata di propulsione propria.
Leonardo considerava «la sapienza figliola dell’esperienza», collegava l’evoluzione e il progresso all’elemento umano che, sperimentando e apprendendo, alimenta l’intelletto capace di produrre progresso e nuova tecnologia.
Non può esservi tecnica che, da sola, s’evolva, produca qualcosa o, lasciando lo stadio della somiglianza con l’uomo, giunga a essere uomo. È assolutamente vero che, più tecnologia c’è, più è facile che se ne produca altra, in una coevoluzione che ci lega alla macchina (intesa come mezzo e tecnica integrati) in maniera non più unidirezionale. Ma sono anche convinto che l’immagine di una macchina autonoma derivi semplicemente da una nostra necessità interiore: la pulsione che ci porta a voler forzosamente conferire anima e coscienza a un’entità inanimata, nella speranza di instaurare un dialogo con essa.
La macchina fa, esegue a velocità impossibili per noi, sviluppa in maniera perfetta le nostre imperfezioni, è muscolo bionico, tendine sintetico, braccio forte e rapido oltre ogni immaginazione, ma… fa e basta!
Si limita a fare.
Il computer, la Rete, i più sofisticati software sono macchine estremamente complesse: elaborano informazioni in maniera talmente articolata da riuscire ad apparire ingannevolmente capaci di comportamenti autonomi di tipo umano –cioè intelligenti– ma la loro capacità di valutazione e reazione a un impulso resta finita e legata al pensiero di chi le programma.
Il pensiero resta nostro, così come il sogno. E l’evoluzione. Dal punto di vista strettamente biologico continuiamo infatti a evolverci secondo il classico schema darwiniano, mentre sul versante socio-culturale e dello sviluppo tecnologico risulta evidente la coevoluzione uomo-macchina, la cui fonte primaria è e resta l’elemento umano.
A questo proposito, risulta davvero interessante quanto scrive Giuseppe O. Longo nel suo saggio Homo technologicus:
Tanto è importante la tecnologia, che essa contribuisce a formare le categorie cognitive (e attive) dell’uomo, condizionandone lo sviluppo. La distinzione tra uomo e tecnologia non è netta come talora si pretende, perché la tecnologia concorre a formare l’essenza dell’uomo, e inoltre l’evoluzione della tecnologia è diventata l’evoluzione dell’uomo. Se oggi l’evoluzione biologica è ferma, quella culturale è più rapida che mai: ma la separazione tra le due è artificiosa, poiché i due processi si sono ormai intrecciati in un’evoluzione «bioculturale» o «biotecnologica».1
La tecnologia digitale sta rapidamente procedendo verso l’estrema miniaturizzazione dei componenti e la loro diffusione in ogni angolo del nostro mondo, fuori e dentro il nostro corpo, realizzando anche il parallelo procedimento di mimesi con l’ambiente, cioè il pervasive computing, invisibile eppure capace di interconnettere tutti gli elementi della realtà che ci circonda.
Il prossimo futuro è già qui, con l’integrazione completa tra elementi biologici e tecnologici, basti pensare al biorganic computing, una matrice –reale, non da fantascienza, evoluzione del pervasive computing– fatta di computer talmente miniaturizzati e onnipresenti nell’ambiente da costituire un secondo scheletro a nostra disposizione, detto «esoscheletro computazionale».
Se, adesso, facciamo un salto indietro di qualche pagina, andando a rileggere la definizione di «macchina» tratta dal vocabolario Treccani, appare indiscutibile che sia quantomeno obsoleta, inutile, polverosa. Giusto?
Sbagliato.
Ciò che l’interazione simbiotica tra uomo e macchina sta riuscendo a produrre è proprio la realizzazione puntuale della definizione di «macchina»: la trasmissione o l’amplificazione di una forza immensa e naturale, quale quella del pensiero, a un congegno in grado di compiere operazioni predeterminate con risparmio di fatica e di tempo. Cioè?
L’uomo indossa tecnologia dentro e fuori il proprio corpo, diventando un elemento di coesione biologica tra vita intelligente e macchina.
Albert...