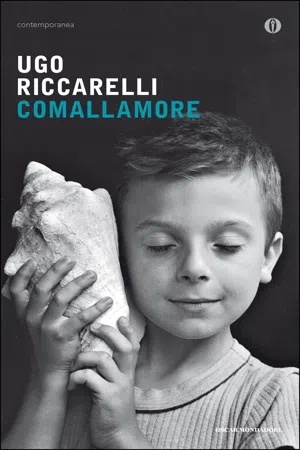«Lei, adesso, mi chiede di raccontare.»
Per un lungo istante il vecchio guardò la donna seduta di fronte a lui. Tra i loro volti ci saranno stati non più di due metri, un piccolo spazio di aria libera e apparentemente vuota. Chi avesse sbirciato dall’esterno in quella stanza avrebbe infatti visto nient’altro che una donna e un vecchio seduti uno di fronte all’altra, su due comode poltrone.
La donna sorrideva per rompere il silenzio che si stava facendo imbarazzante.
Il vecchio aveva lo sguardo fisso su un punto della parete. Le braccia appoggiate sui braccioli della poltrona si muovevano con un leggero tremito.
Il tempo, tra loro, sembrava sospeso al suono delle ultime parole che avevano appena girato per la stanza. Le uniche che erano state pronunciate dopo le presentazioni. Sull’eco di quel silenzio il vecchio si alzò, zoppicando trascinò lentamente le sue gambe e i suoi anni verso la finestra e si appoggiò al davanzale. Davanti alla casa un mercato di paese animava la piazza. Come sulla scena di un teatro, la gente pareva muoversi secondo percorsi già prestabiliti. Si incontrava, si fermava, scambiava qualche parola o toccava la merce, producendo un brusio da insetti.
Dagli alberi che circondavano quello spazio antico aperto tra le case, all’improvviso, quasi rispondendo a un ordine, un gruppo di storni si alzò all’unisono muovendosi velocissimo e cambiando repentinamente direzione, come fosse uno stesso corpo.
Gli occhi del vecchio seguirono quelle evoluzioni acrobatiche, le seguirono allo stesso modo in cui si segue il filo delle parole su una pagina. Quel grumo di punti scuri in movimento apriva per lui un libro su cui aveva scritto, molti anni prima, qualcosa che non poteva dimenticare e che ora una sconosciuta giornalista gli chiedeva di raccontare.
Nella mente del vecchio la nuvola nera degli storni attraversò il tempo, superò quella piazza e continuò a compiere le sue volute sul cortile del manicomio, sopra e dentro la testa di Fosco. Ogni volta che quel corpo nero e frenetico era apparso nel cielo dei matti, Fosco era stato preso dalla stessa frenesia di quegli uccelli, quasi appartenesse anche lui allo stormo scuro. Come gli uccelli, allora, scattava in una corsa rapida attraversando il cortile, le braccia aperte le sue ali, le braccia aperte a battere l’aria, un volare stravolto e felice. Beniamino lo stava a guardare, seguiva quelle evoluzioni come un bimbo che assista a bocca aperta all’esercizio di un acrobata in un circo, ammirato per la rapidità con cui Fosco cambiava direzione, la forza che sprigionava, davvero un uccello libero nella prigione della casa dei matti.
Spettatore di quel volo, Beniamino dimenticava per un po’ di tempo il suo lavoro e si lasciava rapire dall’energia che quel movimento frenetico sprigionava nel mare di disperazione del cortile, stupito di come quel ragazzo attraversato dalla follia potesse annegare per qualche minuto nella felicità più assoluta, trasportato dal volo di uno stormo di uccelli. Poi la macchia nera compiva l’ultima voluta, mutava direzione e spariva come la pioggia di un temporale estivo, lasciando dietro di sé il silenzio e il respiro affannato di Fosco, orfano del suo volo.
Per tutto il tempo che era stato con lui, quel rito si era ripetuto, identico e perfetto, una danza frenetica che si interrompeva bruscamente, lo sguardo del giovane fisso nel cielo a cercare ancora l’aggancio con la felicità che scompariva, immobile nel mezzo della sua prigione.
Solo una volta, l’ultima in cui si erano visti, Fosco non era rimasto bloccato a inseguire nel cielo una traccia del volo, ma si era voltato verso Beniamino e lo aveva guardato, aveva sorriso, prima di andarsene per sempre in direzione del bosco, gridando verso di lui, come in una litania ossessiva, un’unica parola ripetuta all’infinito.
La casa dei matti aveva finestre alte e chiuse da grate. Era una costruzione di mattoni scuri dalla quale la città si difendeva con un muro che celava alla vista dei buoni cittadini lo sconcio di fantasmi in carne e ossa, di camicioni e facce stravolte da pensieri storti.
Solo sul lato di un cortile interno, al confine con una casetta di due piani, il muro si interrompeva come per una dimenticanza, per una svogliatezza dei costruttori, che al posto dei mattoni avevano lasciato, per un breve spazio, la più lieve barriera di una rete metallica.
Da quell’apertura Beniamino guardava i matti sfidando le proibizioni di sua madre e le urla di rimprovero di sua nonna. Si aggrappava alle maglie di ferro a osservare il muoversi in tondo dei malati, a origliare discorsi borbottati, a sussultare per improvvise grida o movimenti inaspettati.
Restava ammirato a guardarli quando, come se fosse chiamato da una voce impercettibile, qualcuno di loro si scuoteva dal torpore, interrompendo un girare continuo o un sonno apparente consumato sopra una panchina e si avvicinava al roseto che copriva un pezzo di quel confine di metallo.
Uno alla volta, come un gregge strampalato, i matti cominciavano a staccare i petali da quella cascata colorata e li mangiavano con delicatezza e piacere, con la stessa sacralità con la quale un credente avrebbe accolto l’ostia benedetta all’altare. Sorridevano, i matti, presi da una serenità incomprensibile masticavano quei fiori colorati e, per un attimo, parevano ombre felici.
Beniamino li fissava rapito. Resistendo alle urla di sua nonna rimaneva immobile a guardare quei fantasmi mangiare le rose.
Avrebbe voluto scavalcare la rete e provare anche lui quella strana condizione che li invadeva.
Avrebbe voluto imitarli.
L’idea del manicomio era stata di sua nonna Aida. Il padre di Beniamino era morto da pochi giorni, portato via in un attimo dal cuore che gli aveva dato uno strattone forte in mezzo al petto, lasciandogli soltanto il tempo di risedersi sulla sedia dalla quale si era appena alzato, dopo pranzo.
«Ricordati di dar da mangiare ai conigli» aveva detto alla moglie, come faceva quando se ne partiva per i mercati dove, seguendo il mestiere che aveva imparato da suo nonno, si ingegnava a vendere lane e tessuti.
Aveva pronunciato quella raccomandazione e poi stretto la bocca come se avesse trangugiato un bicchiere di vino troppo aspro. Quindi l’aveva stirata in un ghigno che all’Elemira, sua moglie, era parso un sorriso incerto e infine aveva lasciato andare il mento sul torace, neanche stesse per scivolare in un sonnellino buono per la digestione.
L’Elemira, infatti, intenta com’era a sparecchiare il tavolo dalle stoviglie, era rimasta in dubbio tra la leggerezza di un riposo domestico, che faceva sembrare un bimbo quell’omone appisolato, e il calare troppo repentino nel silenzio e nell’immobilità. Cosicché, anche se l’agitazione non era ancora montata, aveva ricordato al marito che lei aveva già quelle bestie dei loro figli a cui badare, e sua madre sempre più vecchia, e una casa da mandare avanti, senza che lui le mettesse l’urgenza del lavoro attorno alle gabbie strette strette sotto la tettoia. C’era l’erba da fare e il fondo delle conigliere da pulire dalla schifezza, ché altrimenti il puzzo sarebbe salito fino in camera da letto ben più forte di quello dei matti che ciondolavano oltre il muro del giardino.
E mentre ripeteva le incombenze quasi come una litania stizzita, l’Elemira, i piatti sporchi in mano, andando avanti e indietro verso l’acquaio, aveva continuato a tenere gli occhi sul capo reclinato del marito. L’assenza almeno di un flebile russare che, per l’Ignazio, era il sigillo di garanzia del sonno arrivato, le aveva fatto montare il sospetto, che poi s’era fatto così pressante da costringerla a lasciar perdere il rigovernare. Si era precipitata verso di lui chiamando il suo nome con lo stesso acuto implorare che le era uscito dalla gola la prima volta in cui con lui aveva conosciuto l’amore.
L’Ignazio aveva finito la propria vita così, stecchito sulla sedia della tavola alla quale aveva consumato il suo ultimo pranzo, di poche parole e allo stesso tempo allegro com’era sempre stato negli anni in cui aveva diviso la casa con la moglie, con Beniamino, con la Mara e con quell’impiastro dell’Aida, sua suocera, una volta che era rimasta vedova.
Richiamati dalle grida dell’Elemira, i familiari non poterono far altro che constatare che lui se n’era andato senza neanche un saluto, un biglietto di suggerimenti, un ultimo consiglio su come mandare avanti gli affari o qualsiasi altra raccomandazione che non fosse quella breve e inutile frase sul mangiare dei conigli.
Questa mancanza di premura fu intesa da tutti come una sorta di scortese tradimento, involontario, certamente, ma non di meno fastidioso. Soprattutto Beniamino si sentì defraudato, abbandonato con i suoi giovani anni a reggere il peso di quanto era pronto ad affrontare nella vita, ma non così all’improvviso e senza aiuto, visto che l’Elemira s’era rinchiusa in una disperazione solitaria, squassata dai singhiozzi. Del resto, la Mara era femmina, poco più che ragazzina e piena di fanfole per la testa, tante nuvole e niente praticità, mentre la vecchia Aida, più che prestare aiuto, aveva bisogno lei di sostegno, visto che smarriva i nomi e le cose, persa com’era nella nebbia degli anni.
Così, calato l’Ignazio nella fossa del cimitero, una volta che i parenti, gli amici, i conoscenti ebbero espresso il loro rincrescimento, parole e abbracci e sorrisi e promesse, Beniamino s’era ritirato a pensare tra sé cosa avrebbe potuto fare per mandare avanti la sua vita e una famiglia che gli parevano barchette senza remi, in un mare in bonaccia.
Per almeno un paio di giorni aveva tentato di capire qualcosa dei commerci di suo padre, rimanendo ore a leggere gli appunti e i conti che l’Ignazio teneva in certi quadernetti con la copertina nera, fitti di una scrittura minuta e comprensibile tanto quanto un geroglifico. Se n’era andato nel piccolo magazzino accanto alle conigliere, là dove suo padre teneva il carro, il banco e la merce dei mercati, cercando di ricordare qualcosa di utile in quello che aveva visto le poche volte in cui, durante le vacanze estive, gli era capitato di accompagnarlo nei suoi commerci. Ma più che mai, in quel momento, gli anni di studio, il ginnasio, il liceo e poi l’università che proprio l’Ignazio aveva voluto a tutti i costi fargli frequentare, gli sembrarono una paccottiglia inutilizzabile, come certe passamanerie che suo padre aveva voluto provare a trattare e che da anni rimanevano invendute, in fondo agli scatoloni, in un angolo del magazzino.
Oltretutto, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto tirare le somme degli studi, terminare gli ultimi esami per avviarsi a diventare medico secondo i piani familiari, uno stupido incidente aveva interrotto il suo cammino e l’aveva lasciato con il segno indelebile di una zoppia pronunciata.
Il castello di progetti si era infranto in un attimo sopra un campo di calcio, assieme alla tibia e al perone che il Castellucci, entrando come un disperato per togliergli la palla, gli aveva fracassato di netto, come due grissini. Quel giorno Beniamino se ne stava andando verso la porta dopo aver saltato in dribbling un avversario, e già puntava il Meloni mezzo accucciato tra i pali, quando con la coda dell’occhio aveva appena avuto il tempo di vedere un’ombra con le fattezze del Castellucci. Forse persino gli sembrò di immaginarselo, tanto fu veloce e improvviso l’impatto. Aveva sentito uno strisciare di terriccio smosso e poi uno schiocco secco, come di legna che si spezzi, mentre qualcosa lo rigirava e lo tirava per terra con la forza di un bisonte. Un bruciore fortissimo lo aveva preso sotto il ginocchio, cosicché quando si era alzato portando le mani là, verso il punto in cui le fiamme lo stavano scottando, era rimasto sorpreso nel non vedere fuoco, ma la sua gamba girata come forse aveva visto soltanto nei bambolotti della Mara, quand’era piccina. Preso da quello stupore, prima di svenire per il dolore che dall’arto già gli andava montando veloce come un treno fin in mezzo al cuore, Beniamino aveva fatto in tempo a sentire il Castellucci bestemmiare qualche madonna, mentre altre voci gli raccomandavano di stare fermo e non guardare.
Quando si era svegliato all’ospedale la frittata era già fatta, come da allora ebbe a ripetere l’Ignazio finché la morte non se lo prese. Lo ripeteva battendo la sua grande mano sulla coscia, a sottolineare la rabbia che lo assaliva nel vedere il suo ragazzo così rovinato. Perché immediatamente, senza neppure che il professor Luciani gli avesse spiegato per filo e per segno la situazione, l’Ignazio aveva capito che Beniamino, da sempre dritto e veloce come un fulmine, non sarebbe più stato lo stesso. Ritorto come un tralcio di vite, infatti, quel pezzo di gamba era stato stirato, trapassato da ferri e ferretti, riattaccato, ma alla fine dell’acconciatura era rimasto comunque un poco più corto dell’altro, costringendo il ragazzo a un passo claudicante e un po’ storto.
Oltretutto, a completare la beffa, le settimane di degenza e di malattia erano capitate proprio a ridosso dell’estate. Gli avevano impedito così di sostenere gli ultimi esami e lo avevano costretto a riprogrammare la laurea per un prossimo futuro. E ora che era arrivato, quel futuro era un presente pieno soltanto di preoccupazioni assillanti, di conti da pagare, di incombenze da affrontare.
Così, seduto tra le pile di stoffe che lo attorniavano, i quaderni indecifrabili aperti di fronte a lui, Beniamino si sentiva affogare in un oceano di nullità. Girava e rigirava tra le mani gli appunti di suo padre senza trovare un ordine, un’idea. Si alzava e andava agli scaffali degli scampoli, passando e ripassando i tessuti tra pollice e indice come aveva sempre visto fare all’Ignazio, forse sperando che in quel gesto fosse nascosta la chiave per aprire la porta di una verità a lui ancora chiusa e misteriosa.
Perso in quel girare a vuoto, Beniamino ogni tanto usciva e andava ad appoggiarsi alla rete che separava il giardino dal manicomio e, come faceva fin da quando era bambino, se ne stava a guardare i matti, a seguire il ciondolare ossessivo delle loro camminate, a contemplare quelle vite abbandonate in un cortile e che, ora più che mai, gli parevano alla deriva. Come la sua.
Inaspettatamente, fu la vecchia Aida ad aiutarlo. Proprio mentre era accostato alla rete di metallo, immerso nei percorsi dei matti nel cortile, sentì vicino a sé il corpo minuto della nonna.
Se ne stava, co...