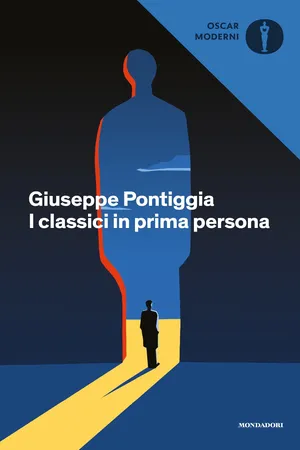Vorrei dire il piacere che provo a parlare all’Università di Bologna su un tema che mi è particolarmente caro. Posso dire che, se non avessi avuto in mente di fare lo scrittore, avrei voluto fare il filologo. Ho una passione ininterrotta per la filologia da quando l’ho scoperta al liceo e nei primi anni dell’Università. Ho raccontato in un romanzo, Il giocatore invisibile,2 un conflitto fra due filologi motivato da ragioni private, ma nutrito anche da quell’accanimento che spesso accompagna il percorso della filologia.
Io coltivo la filologia con l’accanimento di uno specialista e, inevitabilmente, coi debiti di un innamorato della materia che non è uno specialista; però l’accanimento è quello. Ho sempre diffidato delle divulgazioni, delle mediazioni divertite, delle scorciatoie. Io ho l’impressione che molte di queste mediazioni non ci avvicinino veramente all’antico, all’esperienza dell’antico: si impara più da uno storico – anche irto, che a un certo punto apre un’immagine, dà uno scorcio – che non da un libro di divulgazione, fatto da un turista della storia, che non ti fa capire né il passato né il presente, anche se noi abbiamo l’impressione che domini entrambi i campi. Io imparo enormemente dagli specialisti, dagli interstizi e dagli spazi, pur esigui, che aprono all’intelligenza contemporanea.
Dobbiamo sempre tenere presente che l’Italia è l’erede di una tradizione millenaria di retorica.
La retorica è nata in Sicilia. C’è un aneddoto che ha per me un significato sapienziale, perché riguarda la storia della retorica e del nostro rapporto con la retorica. Corace in Sicilia insegna a Tisia a parlare in modo efficace, così da persuadere gli interlocutori di avere ragione: questa era l’essenza della retorica nella sua fase iniziale, che peraltro l’ha accompagnata in tutto il suo percorso. Alla fine delle lezioni, Tisia si rifiuta di pagare il maestro. Corace gliene chiede la ragione e Tisia risponde: «se tu mi hai insegnato bene la retorica, io devo essere in grado di convincerti che non ti devo niente, e non ti pago; se non riesco a convincerti vuol dire che non mi hai insegnato bene la retorica, e non ti pago. In tutti e due i casi, non ti pago».
Questa è la prima parte dell’aneddoto; nella seconda Corace risponde: «se tu riesci a convincermi che non mi devi niente vuol dire che ti ho insegnato bene la retorica, e mi paghi; se non riesci a convincermi, mi paghi. In tutti e due i casi mi paghi».
Ora, questa disputa, nel suo significato ideale, non ha termine: ha un carattere anulare, ciclico, perenne. Dietro, però, che cosa c’è? C’è una persona che non vuole pagare il dovuto. Tutti e due sanno che il maestro va ricompensato; i sofisti sono stati i primi «sapienti» – non erano sophoí, erano sofisti – a insegnare una tecnica e come tali esigevano una ricompensa: una tecnica che aveva un valore sociale enorme, utilissima nel dibattito politico, civile, giudiziario. La retorica fiorisce ad Atene, il popolo più litigioso dell’antichità, la cittadinanza più disputante del mondo antico.
Alla fine, in questa accezione negativa, la retorica serve a eludere una responsabilità. Corace e Tisia non si accordano; non sappiamo come si concluda la disputa, ma in ogni caso essa poggia su una interpretazione immorale, eticamente spregevole, dell’insegnamento retorico: tutti e due sanno benissimo che il maestro va ricompensato.
Purtroppo, in Italia, l’eredità retorica del passato, che ha agito beneficamente su tutta la nostra tradizione letteraria e giuridica, ha anche questa connotazione immorale: questo è l’aspetto linguistico della nostra corruzione. Noi vediamo che in Italia l’abilità dei politici è soprattutto verbale, e il problema politico è un problema essenzialmente verbale: come giustificare le inadempienze. Questo impiego immorale della retorica si manifesta anche nelle cause civili e penali: noi vediamo responsabili di catastrofi che, grazie alla mediazione e all’argomentazione retorica, si giovano di una sostanziale impunità. Ho dedicato un paragrafo proprio alla politica come problema linguistico.3
Personalmente sono contrario alle antologie. Quando ero consulente della Fiera del Libro di Torino, mi hanno coinvolto in un questionario che aveva voluto Ernesto Ferrero. Io avrei detto di no – non amo rispondere a queste domande – però non potevo sottrarmi. Le domande non riguardavano il mondo antico, ma un canone generale degli autori. Io ho risposto: non credo al canone, pur capendo la sua funzione ideale e operativa (per esempio, nelle scuole, il canone è indispensabile).
Personalmente, però, mi sentirei di considerare alcuni autori che, nel mio percorso, hanno significato qualcosa. Io, pur rispettando gerarchie, classificazioni, sistemazioni – perché non possiamo eludere questa necessità critica – ho forte resistenza a indicare canoni: posso dire gli autori che hanno avuto per me una importanza vitale.
Petronio è un autore che continuo a seguire idealmente, anche quando scrivo: il suo stile, secondo Nietzsche, aveva insegnato alle cose a correre; per me è un ideale di mobilità narrativa, di leggerezza, di incisività, di inventività, di aggressività scorrevole. L’epitafio di Trimalcione [Satyricon, 71, 12] è qualcosa di memorabile, come esempio di satira che si identifica perfettamente con il linguaggio del protagonista. In questo senso è una satira di tipo manzoniano: non ha bisogno di aggiunte, di chiose:
Venne su dal nulla, lasciò trenta milioni di sesterzi. Non ascoltò mai un filosofo. Stammi bene. Anche tu.
Qui c’è un universo: c’è l’orgoglio, la tracotanza dell’ignorante; ma anche l’inventiva, la vitalità dell’ignorante e il gusto della contrapposizione.
Poi posso raccontare un aneddoto personale. L’impulso a scrivere poesie – io ho sempre scritto poesie che non ho mai pubblicato: Anceschi l’ho conosciuto proprio mostrandogli le mie poesie – mi era venuto dalla lettura di Virgilio, delle Bucoliche: la prima Bucolica mi aveva proprio emozionato.
Gli autori del mondo latino che io considero non solo vivi, ma anche esemplari, sono Sallustio e Seneca: li leggo sistematicamente, come una fonte viva di energia, un’irradiazione di stile. Sallustio, e naturalmente il suo modello greco, Tucidide, più che Erodoto. Erodoto lo sto leggendo interamente: mi dà molto, ma non è paragonabile, quanto a emozioni, a Tucidide.
Poi, i lirici e i tragici greci per me sono stati una lettura fondamentale nel periodo in cui facevo parte dell’Avanguardia: una parte un po’ critica e isolata. L’Avanguardia, la Neoavanguardia, in Italia nasce da «Il Verri», e io facevo parte della rivista sin dalla fondazione. Nei confronti dei Novissimi – tutti miei amici – avevo un atteggiamento di solidarietà, ma anche di critica e di riserva. Condividevo l’idea che il linguaggio fosse il protagonista malato; condividevo l’idea dei rapporti tra letteratura, ideologia e linguaggio, l’idea che bisognasse innovare radicalmente le forme narrative e poetiche passando anche attraverso una rivisitazione critica dell’Avanguardia: non condividevo l’idea che bisognasse fare tabula rasa, che bisognasse scrivere poesia per dimostrare che non si poteva scrivere poesia. Su questo punto, per esempio, con Balestrini avevo delle dispute.
Proprio in quel periodo – parlo della metà degli anni Sessanta – ho letto sistematicamente tutti i tragici greci in originale, con la traduzione a fianco, ed è stata per me un’esperienza decisiva per recuperare la potenza delle parole, perché in pochi versi io sorprendevo la potenza del linguaggio. È stata anche un’esperienza mentale, intellettuale, conoscitiva, etica: se vogliamo affrontare il problema della colpa e della pena, la lettura di Eschilo riesce enormemente più utile di tutti i dibattiti televisivi. Leggiamo Coefore ed Eumenidi: sono esperienze straordinarie. Una grande studiosa american...