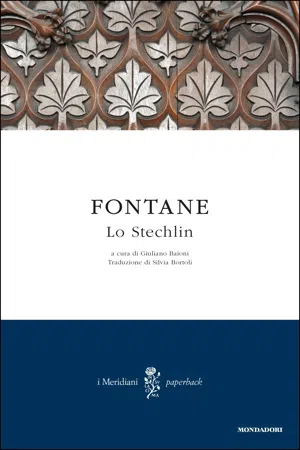PRIMO CAPITOLO
A nord della contea di Ruppin, al confine con il Meclemburgo, una catena di laghi lunga parecchie miglia si stende dalla cittadina di Gransee fino a Rheinsberg (e ancora più lontano) attraverso una regione boscosa, poco popolata, se si eccettua qualche vecchio villaggio sparso qua e là, e disseminata per il resto soltanto di posti di guardia forestali, fornaci per il vetro e per il catrame. Uno dei laghi che formano questa catena si chiama «lo Stechlin».1 Se ne sta adagiato tra sponde basse che salgono ripide e simili a banchine solo in un punto ed è chiuso tutto intorno da vecchi faggi i cui rami, spinti in basso dal loro stesso peso, sfiorano l’acqua. Qua e là spunta una canna o un giunco ma nessuna barca solca le sue acque, nessun uccello canta e soltanto di rado un astore lo sorvola e proietta la sua ombra sullo specchio dell’acqua. Tutto tace qui. Eppure, di tanto in tanto, proprio questo luogo prende vita. Accade quando nel mondo, in Islanda o a Giava, la terra comincia a tremare e a rimbombare, o quando la pioggia di cenere dei vulcani delle Hawaii viene spinta lontano, verso i mari del Sud. Allora qualcosa si muove anche qui e un getto d’acqua zampilla all’improvviso e ricade nelle profondità. Tutti quelli che vivono nei dintorni dello Stechlin lo sanno e quando ne parlano aggiungono anche: «Il fiotto d’acqua è un fatto quasi normale, una cosa da poco, ma quando nel mondo succede qualcosa di grave, come cent’anni fa a Lisbona, allora l’acqua non si limita a ribollire ma spumeggia e crea un vortice, poi, invece del fiotto d’acqua, si alza in volo un gallo rosso e canta a gola spiegata sulle terre che lo circondano».
Questo è lo Stechlin, il lago di Stechlin.
Ma non è soltanto il lago a portare quel nome, anche il bosco tutt’intorno si chiama così. E Stechlin si chiama anche il villaggio che, seguendo le insenature, si stende intorno alla sua punta meridionale. Qui un centinaio di case e casupole disegna una via lunga e stretta che si allarga a formare una piazza solo nel punto in cui incrocia un viale di castagni che scende dal convento di Wutz.2 Proprio in quel punto si concentrano del resto tutte le bellezze del villaggio di Stechlin: la casa del pastore, la scuola, il municipio e l’osteria, un edificio d’angolo che funge anche da bottega di generi vari, con una piccola figura moresca e una ghirlanda di fili di zolfo in vetrina. Sull’angolo opposto, un poco più avanti, subito dietro la casa parrocchiale e a ridosso di questa, sale dolcemente il cimitero in cui si trova, più o meno al centro, la chiesa medievale di pietra greggia, con una torretta campanaria del secolo scorso e un braccio di legno al quale è attaccata una campana, montato accanto al vecchio portale ad arco. Vicino al cimitero e alla chiesa, il viale di castagni che scende fin lì dal convento di Wutz continua poi per un breve tratto, finché si interrompe davanti a un ponte di tavole che attraversa un fossato acquitrinoso ed è fiancheggiato da due giganteschi massi erratici. Il ponte è molto rudimentale. Ma oltre il ponte sorge la casa padronale, un edificio dipinto di giallo con un tetto alto e due parafulmini.
Anche la casa padronale si chiama Stechlin, il castello di Stechlin.
Qui alcuni secoli fa c’era un vero castello, un edificio di mattoni con massicce torri circolari, alla cui epoca risale anche il fossato che tagliando la lingua di terra incuneata nel lago ne faceva una piccola isola. Così fu fino al tempo della Riforma. Durante l’occupazione svedese tuttavia l’antico castello fu raso al suolo e sembrava che lo si volesse abbandonare alla completa rovina e non si volesse costruire nient’altro al suo posto finché, poco dopo l’ascesa al trono di Federico Guglielmo I, il cumulo di macerie fu rimosso e venne dato l’ordine di erigere una nuova costruzione. La nuova costruzione è l’edificio tuttora esistente. Aveva lo stesso carattere sobrio di quasi tutto ciò che fu costruito sotto il re sergente e si trattava di un semplice corps de logis le cui due ali laterali si protendevano fin quasi al fossato e formavano un ferro di cavallo all’interno del quale un cortile spoglio offriva come unico ornamento una grande sfera di vetro lucente. A parte questo si vedeva soltanto una rampa che si stendeva davanti alla casa e dal cui lato anteriore, quello rivolto verso il cortile, l’intonaco cominciava già a staccarsi. Ma al tempo stesso era impossibile non notare uno sforzo per rendere speciale proprio questa rampa, grazie a numerosi vasi di piante esotiche tra cui due aloe, una delle quali era ancora in buona salute mentre l’altra era malata. Ma proprio quella malata era la preferita del castellano perché ogni estate offriva una fioritura che in verità non le spettava. E la spiegazione è questa: molto tempo prima, dal paludoso fossato del castello il vento aveva trasportato nel vaso dell’aloe malata un seme estraneo e perciò, tutti gli anni, dal centro delle foglie ormai ingiallite dell’aloe spuntavano le ombrelle bianche e rosse dell’aglio acquatico o butomus umbellatus. Ogni nuovo arrivato, a meno che per caso non fosse un esperto, prendeva le ombrelle per autentici fiori di aloe e il castellano si guardava bene dal distruggere quella convinzione che era per lui una ragione di divertimento.
E poiché tutto lì intorno si chiamava Stechlin, questo era ovviamente anche il nome del castellano. Anche lui era uno Stechlin.
Dubslav von Stechlin, maggiore in congedo e già ben oltre i sessanta, era il tipico nobile del Brandeburgo, non però di stretta osservanza, uno di quei tipi piacevolmente originali nei quali persino le debolezze si trasformano in pregi. Aveva ancora tutto il simpatico e singolare orgoglio di quelli che «c’erano già prima degli Hohenzollern»,3 ma lo nutriva nel più assoluto riserbo e, se pure l’orgoglio trapelava, si vestiva di umorismo e persino di autoironia poiché, seguendo la propria natura, Dubslav metteva dopo ogni cosa un punto interrogativo. Il suo tratto più bello era una profonda umanità che nasceva direttamente dal cuore e (mentre su tutto il resto aveva la tendenza a lasciar correre) la boria e la superbia erano più o meno le sole cose che lo indignassero. Gli piaceva ascoltare un’opinione franca, e quanto più drastica ed estrema, tanto meglio. Non desiderava affatto che quell’opinione coincidesse con la sua. Al contrario. I paradossi erano la sua passione. «Io non sono abbastanza intelligente da inventarne, ma sono contento che lo facciano gli altri; c’è sempre qualcosa di buono. Non esistono verità incontestabili e, se esistono, sono noiose.» Gli piaceva sentir raccontare e lui stesso chiacchierava volentieri.
La vita del castellano aveva seguito le tradizioni del Brandeburgo. Più volentieri in sella che sui libri fin dalla giovinezza, aveva superato vittoriosamente l’esame di alfiere soltanto dopo essere stato bocciato due volte ed era entrato subito nel reggimento dei Corazzieri del Brandeburgo, nelle cui file naturalmente aveva già militato anche il padre. Il suo reclutamento era coinciso più o meno con l’ascesa al trono di Federico Guglielmo IV4 e quando vi accennava gli piaceva far notare, prendendosi in giro, «che ogni grandezza ha i suoi lati negativi». Gli anni passati tra i corazzieri erano stati sostanzialmente anni di pace; soltanto nel ’64 era stato anche lui nello Schleswig,5 ma anche in quel caso senza entrare «in azione». «Per un uomo della Marca quello che conta è essere presente; il resto è nelle mani di Dio.» E a quelle parole sorrideva sotto i baffi lasciando sempre gli ascoltatori nel dubbio se avesse scherzato o parlato sul serio. Poco più di un anno prima dello scoppio della guerra del ’64 gli era nato un figlio e, appena tornato alla guarnigione del Brandeburgo, si era congedato per ritirarsi nel castello di Stechlin, quasi abbandonato dopo la morte del padre. Qui lo aspettavano giorni felici, anzi, i più felici della sua vita, ma furono di breve durata… già l’anno successivo sua moglie morì. Un nuovo matrimonio gli ripugnava, in parte per senso dell’ordine e in parte per considerazioni estetiche. «Crediamo tutti, chi più chi meno, nella resurrezione» (in realtà personalmente non ci credeva), «e se poi arrivassi lassù con una moglie a destra e una a sinistra, sarebbe imbarazzante.» Quelle parole – poiché le azioni dei genitori incontrano fin troppo spesso il biasimo dei figli – erano rivolte in verità contro il padre che si era sposato tre volte e sul quale trovava da ridire per ogni genere di questioni, grandi e piccole, tra cui ad esempio quella di aver imposto a lui, il figlio, il nome pomerano di «Dubslav».6 «Certo, mia madre era pomerana, e per di più dell’isola di Usedom, e suo fratello si chiamava Dubslav, è vero. E così, grazie allo zio, contro il nome c’è stato poco da obiettare, tanto più che era ricco. (Che alla fine mi abbia lasciato vergognosamente a bocca asciutta è un’altra storia.) Ma comunque sia, resto convinto che questo guazzabuglio di nomi confonda solo le cose. Un brandeburghese si deve chiamare Joachim o Woldemar. Stattene a casa tua e usa un nome del tuo paese. Chi viene da Friesack non può chiamarsi Raoul.»7
E così Dubslav von Stechlin non si risposò. Ormai erano trascorsi quasi trent’anni. All’inizio aveva sofferto, ma ormai tutto era passato e viveva «comme philosophe», seguendo le parole e l’esempio del grande re al quale guardava sempre con ammirazione.8 Era quello l’uomo per lui, più di ogni altro che si fosse fatto un nome dopo di allora. Lo si capiva quando gli dicevano che aveva una testa bismarckiana. «E va bene, ce l’ho; pare addirittura che gli somigli. Ma la gente lo dice sempre come se dovessi ringraziare qualcuno. Se soltanto sapessi chi, forse il buon Dio, o magari Bismarck in persona. Ma neppure gli Stechlin vengono da una cattiva famiglia. E inoltre, per quanto mi riguarda, ho prestato servizio nel sesto Corazzieri e Bismarck soltanto nel settimo e come è noto in Prussia il numero più basso conta sempre di più; dunque sono un gradino sopra di lui. E anche Friedrichsruh, dove adesso vanno tutti in pellegrinaggio, dicono non sia altro che una casa di contadini.9 In questo dunque siamo uguali. E un lago come il mio, come lo “Stechlin”, be’, non ce l’ha proprio. Cose del genere capitano di rado.»
Sì, Dubslav era fiero del suo lago, ma era molto meno fiero del suo castello e quindi gli dava fastidio che lo chiamassero così. Tollerava che lo dicesse la povera gente: «Per loro è un “castello”, ma in realtà non è altro che una vecchia baracca». E quindi preferiva parlare della sua «casa» e, quando scriveva una lettera, l’intestazione portava sempre «Casa Stechlin». Era anche consapevole di non condurre una vita da castellano. In passato, quando c’era ancora il vecchio edificio di mattoni con le sue grosse torri e il belvedere dal quale si poteva guardare lontano, oltre le chiome degli alberi, certo, a quei tempi si conduceva una vera vita da castellani e quegli antichi Stechlin prendevano parte a tutte le feste date dai conti di Ruppin e dai duchi del Meclemburgo ed erano imparentati con i Boitzenburg e i Bassewitz. Ma oggi gli Stechlin era gente di scarsi mezzi, che si limitava a resistere e si sforzava continuamente di rimettersi in qualche modo in piedi grazie a un «buon partito». Anche il padre di Dubslav aveva sposato le sue tre mogli per quella ragione e delle tre, a dire il vero, soltanto la prima aveva giustificato la fiducia riposta in lei. L’attuale castellano, che discendeva dalla seconda, non ne aveva ricavato purtroppo nessun vantaggio diretto e Dubslav von Stechlin non si sarebbe mai liberato delle preoccupazioni e delle difficoltà finanziarie piccole e grandi se nella vicina Gransee non ci fosse stato il suo vecchio amico Baruch Hirschfeld. Il vecchio, proprietario del grande negozio di tessuti sulla piazza del mercato che vendeva anche abiti alla moda e cappelli per signora dei quali si diceva sempre che «Gerson mandava a lui per primo tutte le novità»,10 il vecchio Baruch in effetti, pur senza dimenticare il «lato commerciale» della faccenda, era legato al castellano di Stechlin da una specie di affetto, e la cosa provocava regolarmente, quando si ripresentava il problema di un nuovo credito, discussioni spiacevoli tra Hirschfeld padre e Hirschfeld figlio.
«Dio, Isidor, tu sei a favore del nuovo, lo so. Ma che cos’è il nuovo? Gente che si raduna sempre al mercato e dà l’assalto al negozio e ci prende i cappelli, uno dopo l’altro, e le piume di airone e di struzzo. Io sto dalla parte del vecchio e buon signore von Stechlin. Dopotutto il padre di suo nonno è caduto nella grande battaglia di Praga e ha pagato con la vita.»11
«Sì, lui ha pagato; per lo meno ha pagato con la vita. Ma questo…»
«Paga anche lui, quando può e li ha. E quando non li ha e gli dico “Signor von Stechlin, scriverò sette e mezzo”, non tira sul prezzo e non mi tormenta. E se fallirà, be’, avremo i beni: i terreni fertili e i boschi e la riserva di caccia e una pesca abbondante. Li vedo sempre in lontananza, piccoli piccoli, e vedo anche il campanile.»
«Ma, padre mio, cosa ce ne faremo di un campanile?»
Era spesso questo il tenore dei discorsi tra padre e figlio e ciò che per il momento il vecchio vedeva ancora «in lontananza» sarebbe forse diventato ormai realtà se non ci fosse stata la sorella del vecchio Dubslav, maggiore di lui di dieci anni, con il patrimonio ereditato dalla madre: sorella Adelheid, domina del convento di Wutz.12 Aiutava e dava buoni consigli quando le cose si mettevano male o sembravano addirittura volgere al peggio. Tuttavia lo faceva non per amore del fratello – sul quale, al contrario, aveva parecchio da ridire – ma per puro attaccamento alla famiglia degli Stechlin. La Prussia era importante e lo era anche la Marca di Brandeburgo, ma quello che contava di più erano comunque gli Stechlin e il pensiero di veder passare il vecchio castello in altre mani e adesso persino in mani come quelle, le era insopportabile. E oltre a questo c’era anche il suo figlioccio, il nipote Woldemar, per il quale nutriva tutto l’amore che negava al fratello.
Sì, la domina aiutava ma, nonostante l’aiuto, il sentimento di estraneità tra fratello e sorella cresceva e così il ...