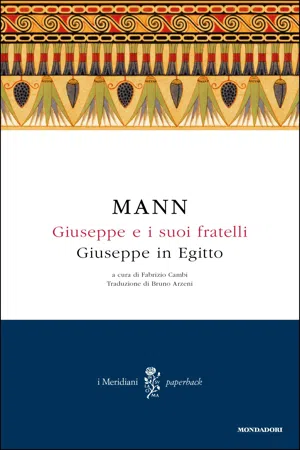LA PAROLA DEL MISCONOSCIMENTO
E dopo questa vicenda avvenne che la moglie del suo signore pose gli occhi su Giuseppe e disse …
Tutti sanno che cosa, secondo quanto si narra, avrebbe detto Mut-em-enet,1 la moglie titolare di Potifar, quando i suoi occhi si “posarono” su Giuseppe, il giovane maggiordomo del marito, e noi non vogliamo né possiamo negare che un giorno, al colmo del turbamento, nell’altissima febbre della disperazione, ella abbia realmente finito col pronunciare quelle parole, e si sia servita davvero di quella espressione terribilmente diretta e cruda che la tradizione le mette sulle labbra e in modo così esplicito come se si fosse trattato di una proposta apertamente licenziosa, del tutto ovvia per quella donna, e non le fosse costata nulla, e non piuttosto di un tardo grido prorompente da una suprema pena dell’anima e della carne. A dirla francamente, ci sgomenta la concisione sommaria di una narrazione, come quella di cui ci serviamo, che rende tanto poco giustizia alla amara minuziosità della vita, e raramente come in questo caso abbiamo sentito più vivamente l’oltraggio che laconicità e stringatezza arrecano alla verità. Non si pensi che noi siamo sordi al rimprovero che sentiamo aleggiare e che, esplicitato o no, e comunque sottaciuto solo per cortesia, contesta questo nostro modo di esporre e di confrontarci con la storia nella convinzione che la concisione e l’efficacia con cui essa è narrata nel suo luogo originario non possa giammai essere superata e che tutta la nostra impresa nel suo ormai lungo e laborioso snodarsi è fatica sprecata. Ma quando mai, ci sia lecito domandare, un commentario si mette a competere con il suo testo? E poi: alla discussione del “come” non spetta altrettanta dignità e importanza della tradizione del “che cosa”? La vita anzi non si adempie proprio quando si declina nel “come”? Giova qui ricordare un’osservazione già fatta in precedenza e cioè che la storia, prima ancora di venire raccontata, ha già raccontato se stessa … e con un’esattezza di cui soltanto la vita è magistralmente capace e che il narratore non ha alcuna speranza o probabilità di attingere. Egli può avvicinarsi a essa solo col servire il “come” della vita più fedelmente che non faccia con riluttanza lo spirito lapidario del “che cosa”. Ma se mai la fedeltà esegetica ebbe una giustificazione, questo è il caso della storia della moglie di Potifar e di ciò che, secondo la tradizione, ella avrebbe detto così apertamente.
L’immagine che, secondo questa tradizione, si è costretti o almeno quasi irresistibilmente tentati di farsi della signora di Giuseppe, e che, temiamo, una vasta schiera di lettori in tutto il mondo si sono realmente fatta, è così fuorviante che, proponendosi di restituirla nella sua esatta luce, si acquista una vera benemerenza nei riguardi del testo originario: sia che con questa parola s’intenda la prima redazione scritta o, più giustamente, la vita che racconta se stessa. Questa immagine fallace di lasciva sfrenatezza e di seduzione spudorata mal si concilia peraltro con quanto noi in compagnia di Giuseppe abbiamo udito nel chiosco del giardino dalla bocca della vecchia e pur sempre veneranda Tuij intorno alla nuora e in cui ci si aprì uno squarcio di vita autentica. “Superba” la chiamò la madre di Peteprê, dichiarando che non poteva assolutamente darle l’epiteto ingiurioso di oca; “altera” la nominò, una casta consacrata alla luna, una eletta e preservata, da cui spirava l’odore aspro del mirto. Può una tale creatura esprimersi come la tradizione la fa esprimere? Eppure ella parlò così, letteralmente e ripetutamente così, quando la sua superbia fu del tutto spezzata dalla passione: noi l’abbiamo già confermato. Ma la tradizione dimentica di aggiungere quanto tempo passò, nel corso del quale ella si sarebbe morsa la lingua piuttosto che parlare così. Dimentica di dire che, non solo in senso figurato ma concretamente, nei fatti ella si morse nella solitudine la lingua, prima che, a fior di labbra, vinta dal dolore, pronunciasse la parola che la bollò per sempre con il marchio della seduttrice. Seduttrice? Una donna nelle sue condizioni diventa naturalmente una seduttrice: la seduzione è il lato esteriore, la manifestazione fisiognomica dell’intima tribolazione; è la natura stessa che fa brillare i suoi occhi più dolcemente che non possano fare le istillazioni artificiali apprese dall’arte della toletta, è la natura che accende il rosso delle sue labbra in modo più attraente che non il belletto e le schiude a un caldo sorriso, colmo di significati e allusioni; è la natura che la spinge a vestirsi e adornarsi con un calcolo innocentemente sapiente, che in vista di un ben preciso fine dona soavissima grazia alle sue movenze e infonde a tutto il suo corpo, per quanto la sua costituzione lo permetta e talora anche un po’ oltre, l’impronta di una promessa di voluttà. Tutto questo in fondo non vuol significare e dire fin da principio altro che quanto la donna dirà alla fine a Giuseppe. Ma colei cui tutto ciò avviene per un intimo impulso della sua natura, può essere ritenuta responsabile? Lo fa ella forse per un diabolico proponimento? Che cosa sa di quel che avviene nel suo intimo se non il martoriante dolore che si manifesta all’esterno come fascino incantevole? In una parola, se in lei è all’opera la seduzione, è per questo una seduttrice?
Innanzitutto, la maniera e la forma della seduzione vengono molto modificate dalla nascita e dall’educazione di colei che fu toccata. Contro la supposizione che Mut-em-enet, detta familiarmente Eni o anche Enti, si sia comportata, una volta toccata dalla passione, come una sgualdrina parla già l’ambiente della sua infanzia la cui aristocraticità non ci raffigureremo mai abbastanza. Quel che fu giusto per l’onesto Mont-kaw deve esserlo ugualmente per la donna che influì in maniera ben diversa sul destino di Giuseppe: è doveroso pertanto dare le notizie più necessarie sulla sua origine.
Nessuno sarà sorpreso di udire che la sposa di Peteprê, del Flabellifero, non era la figlia di un birraio o di un portatore di pietre. Nelle sue vene scorreva nientemeno che antico sangue di nomarchi anche se ormai era già passato tanto tempo da quando i suoi avi avevano dominato come piccoli re patriarcali e proprietari di un largo territorio in una provincia del Medio Egitto. Sovrani stranieri, discendenti da pastori asiatici residenti nel Nord del paese avevano allora portato la doppia corona di Rê e i principi di Wêse nel Sud erano stati per secoli sottomessi agli invasori. Ma tra loro erano sorti uomini forti e coraggiosi, Sekenjenrê e suo figlio Kemose,2 che si sollevarono contro i re pastori e li combatterono tenacemente; l’origine straniera di quei sovrani era stata per la loro ambizione un efficace stimolo per incitare alla guerra. Anzi, l’ardito fratello di Kemose, Achmose, aveva assalito e conquistato Auaris,3 la sede fortificata dei re stranieri, e li aveva scacciati completamente liberando il paese, ma nel senso che ne aveva preso possesso per sé e per la sua casa, sostituendo alla dominazione straniera la propria. Non tutti i principi delle province avevano voluto riconoscere subito nell’eroe Achmose il liberatore del paese e nemmeno identificare la sua sovranità con la libertà, come egli era solito affermare. Parecchi di costoro, e avranno certamente avuto le loro ragioni, avevano tenuto dalla parte degli stranieri in Auaris e avrebbero preferito restare loro vassalli piuttosto che venire liberati da uno dei loro. Anzi, anche dopo la completa cacciata dei signori che avevano esercitato il dominio per tanti anni, alcuni di questi nomarchi, insofferenti di tale libertà, si ammutinarono contro il liberatore e come si legge negli antichi documenti4 “raccolsero ribelli contro di lui”, così che egli dovette vincerli in aperta battaglia, prima di stabilire la libertà. Che questi ribelli avessero perduto le loro proprietà, va da sé. Ma in genere il sistema dei liberatori tebani fu sempre di tenere per sé quello che avevano preso agli stranieri, così che allora ebbe inizio un processo che, molto progredito ma non concluso al tempo della nostra storia, doveva compiersi solo più tardi: l’espropriazione di tutti i possedimenti terrieri della nobiltà provinciale di antico insediamento e l’incameramento dei beni a favore della corona tebana divenuta sempre più l’unica proprietaria di tutto il paese, che essa poi dava in appalto contro pagamento e donava ai templi o ai favoriti, come Faraone aveva donato a Peteprê quell’isola fertile nel fiume. Le antiche stirpi principesche si mutarono in una nobiltà di burocrati e militari che prestava obbedienza a Faraone e rivestiva cariche preminenti nell’amministrazione e nell’esercito.
Tale fu anche la sorte della schiatta e della nobile stirpe di Mut. La signora di Giuseppe discendeva direttamente da quel nomarca di nome Teti-’an che ai suoi tempi “raccolse ribelli” e che dovette essere vinto in battaglia prima di riconoscersi liberato. Ma Faraone non ne serbò rancore ai nipoti e ai pronipoti di Teti-’an. La stirpe era rimasta grande e nobile, aveva dato allo Stato generali, ministri, custodi del tesoro, e alla corte scalchi, primi aurighi e sovrintendenti ai bagni reali, anzi alcuni di questi discendenti messi a capo dell’amministrazione di grandi città come Menfe o Tine avevano potuto conservare l’antico titolo di principi nomarchi. Così il padre di Enti, Mai-Sachme, ricopriva l’alta carica di principe della città di Wêse, era cioè uno dei due principi, perché ce n’era uno per la città dei vivi e uno per la città dei morti a occidente, e Mai-Sachme era appunto principe della città dei morti a occidente. Come tale egli godeva, per dirla con Giuseppe, di una posizione di spicco e sicuramente poteva ungersi con l’olio della gioia: egli e i suoi potevano farlo, anche Eni, la sua figliola dalle belle membra, pur se non più principessa di provincia, proprietaria terriera, ma figlia di un funzionario della nuova era. Dalle decisioni che i suoi genitori, divenuti principi di una città, avevano preso sul suo conto possiamo arguire i mutamenti che dall’epoca degli antenati si vennero compiendo nella mentalità della stirpe. Col dare, per amore di grandi vantaggi a corte, la loro amata figliola, ancora in tenera età, in moglie a Peteprê, il figlio di Huij e di Tuij sottoposto alla procedura che sappiamo per farne un cortigiano, avevano dimostrato chiaramente che l’importanza assegnata alla fecondità, propria dei loro avi legati alla terra, si era in essi notevolmente indebolita sotto l’influsso dei nuovi tempi.
Mut era una bambina quando i suoi genitori disposero di lei non altrimenti che i genitori di Potifar, speculando su di lui, avevano disposto del loro figlioletto che si dimenava e piangeva consacrandolo cortigiano della luce. I diritti del sesso, dei quali non avevano tenuto alcun conto, questi diritti simboleggiati dalla terra nera imbibita d’acqua e dall’uovo-luna, origine di tutta la vita organica, sonnecchiavano muti e in germe in lei a sua insaputa senza levare la minima protesta contro quella disposizione presa, sì, per amore suo, ma contraria alla vita. Ella era spensierata, allegra, limpida, libera. Era come un fiore acquatico, che galleggiando sullo specchio delle acque sorride ai baci del sole, ignaro che il suo lungo stelo ha radici nell’oscuro fango della profondità. Allora non vi era ancora traccia del contrasto tra i suoi occhi e la sua bocca; fra loro regnava anzi un’armonia puerilmente anodina, perché il suo ardito sguardo di fanciulletta non aveva preso ancora quell’espressione di severità che l’abbuiava, e la speciale conformazione della bocca serpentina, dagli angoli profondamente incisi, era appena accennata. La contaminazione del limpido rapporto tra occhi e bocca si produsse a poco a poco nel corso degli anni, quando entrò a far parte dell’Ordine di consacrate alla luna e divenne sposa titolare del camerlengo del Sole, segno evidente che la bocca è un organo e uno strumento più legato e più affine alle potenze infere che non l’occhio.
Per quanto riguarda il suo corpo, tutti conoscevano la sua figura e le sue bellezze, perché “l’aria tessuta”, le lussuose sete, lievissime e impalpabili, che ella indossava la offrivano, secondo il costume del paese, agli occhi di tutti in ogni suo tratto. Potremmo dire che per la sua natura quel corpo era in armonia più con la bocca che con gli occhi; la sua condizione di sposa onoraria non aveva impedito il suo fiorire né frenato il suo rigoglio. Con i seni piccoli e sodi, la fine nuca e il dorso, le delicate spalle, le perfette braccia scultoree, le gambe dalla linea nobilmente affusolata culminanti nel trionfo di muliebrità della fastosa regione delle anche e dei glutei, era, per universale riconoscimento, il più bel corpo di donna che si potesse vedere: Wêse non ne conosceva uno più degno di lode, e negli uomini – così essi erano – al vederlo si affacciavano visioni antichissime e amabili immagini delle origini del mondo e anche anteriori alle origini, immagini che si ricollegavano con l’uovo-luna dei primordi: l’immagine di una splendida vergine che in fondo – proprio nell’umido fondo – era la stessa oca emblema dell’amore in figura di vergine, al cui grembo, dispiegando le ali, si stringeva un magnifico esemplare di cigno, un dio delicatamente violento dal niveo piumaggio, che tra battere d’ali compiva su colei che si sentiva onorata e sorpresa la sua opera amorosa, affinché ella generasse l’uovo …
In verità alla vista della figura di Mut-em-enet, che traspariva dalle sue vesti, immagini primordiali s’illuminavano al fondo della psiche degli uomini di Wêse, dove oscuramente giacevano, sebbene tutti conoscessero il suo rango e lo stato di castità lunare in cui la donna viveva, arguibile dallo sguardo severo dei suoi occhi. Sapevano che della natura e dei costumi di quella donna gli occhi rendevano più sicura testimonianza della bocca, la quale diceva ben altro e avrebbe potuto acconsentire sorridendo alla regale opera del cigno; sapevano che quel corpo non aveva i suoi più alti momenti, le sue soddisfazioni e il suo appagamento nel ricevere tali visite, ma solo quando nei solenni giorni di festa, agitando il sistro, si ergeva dinanzi ad Amun-Rê nella danza cultuale. In breve, essi non avevano da ridire nulla sul suo conto; non correva tra loro alcun pettegolezzo maligno, nessuna strizzatina d’occhi che colpisse quella donna concordando con la bocca ma smentita dagli occhi. Le loro lingue mordaci tagliavano i panni addosso alle altre donne, che erano maritate in un senso più proprio della pronipote di Teti-’an e che tuttavia, riguardo alla moralità, ne combinavano di tutti i colori, non escluse le dame dell’Ordine, non escluse le concubine del dio, la stessa Renenutet, per esempio, la moglie del sovrintendente ai buoi di Amun: di lei si sapeva qualcosa che il marito non sapeva o non voleva sapere, e del resto molto altro si sapeva e si motteggiava dietro la sua lettiga e il suo cocchio, così come dietro ad altre. Ma della prima e, per così dire, vera moglie di Peteprê nulla si sapeva a Tebe, e si era anche convinti che nulla vi fosse da sapere. Nella casa e nella tenuta di Peteprê e anche fuori la reputavano una santa, una “riservata” ed “eletta”, e ciò significava non poco tra tanta inveterata voglia e passione di motteggiare.
Quale che sia l’opinione della cerchia dei nostri lettori, noi non riteniamo nostro compito indagare sui costumi di Mizraim e tanto meno sul mondo delle spose e delle dame di No-Amun, costumi su cui da gran tempo abbiamo udito il vecchio Giacobbe esprimersi con solenne drasticità. La sua conoscenza del mondo non era priva di una certa inclinazione al pathos e alla mitizzazione, dalla quale si fa bene a prescindere, se non si vuol cadere nell’esagerazione. Ma del tutto campate in aria le sue solenni parole certamente non erano. In seno a un popolo che non ha né parola né intendimento per il concetto di peccato, e che se ne va in giro con vesti di “aria tessuta”, nel quale inoltre il culto degli animali e della morte condiziona e favorisce una mentalità particolarmente sensibile alla carnalità, tra un popolo siffatto sono già a priori verosimili, prima ancora di ogni esperienza e verificabilità, quella disinvoltura e leggerezza di costumi che Giacobbe aveva dipinto a tinte così poeticamente vivaci. E la realtà corrispondeva alla verosimiglianza: con soddisfazione logica più che con malignità lo constatiamo. Sarebbe però una indiscreta curiosaggine da ficcanaso volere caso per caso verificare questa concordanza nelle donne di Wêse. Su questo punto non vi è molto da negare, bensì molto da perdonare. Basterebbe che noi facessimo correre il nostro sguardo fra Renenutet, la moglie del sovrintendente ai buoi, e un certo decorativo tenente colonnello della guardia reale, non solo, ma anche tra questa stessa dama d’alto rango e un giovane sacerdote dal lucido cranio rasato del tempio di Chonsu, per mettere l’accento su consuetudini che giustificherebbero ampiamente le icastiche definizioni di Giacobbe. Non è affar nostro erigerci a moralisti e scagliare la pietra contro Wêse, una metropoli con più di centomila abitanti. Rinunciamo a difendere ciò che non si può difendere né salvare. Ma per una donna mettiamo la mano sul fuoco; per l’illibatezza della sua vita fino al momento in cui, certo per violenza di dèi, ella fu invasa da un cieco furore di menade, noi siamo disposti a mettere in gioco tutta la nostra reputazione di narratori: e quest’una è la figlia di Mai-Sachme, il nomarca, Mut-em-enet, la moglie di Potifar. Che ella abbia avuto natura di sgualdrina, che sulle sue labbra abbia sempre aleggiato, per così dire, la proposta che le viene attribuita e che un bel giorno avrebbe gettato fuori con leggerezza e impudenza, è una rappresentazione così falsa che noi, per amore della verità, dobbiamo avere tutto l’interesse di distruggere. Quando poi alla fine, mordendosi le labbra, ella sussurrò quella proposta, non conosceva più se stessa; era fuori di sé, sfatta dal dolore, una vittima della sferzante sete di vendetta delle potenze infere alle quali, grazie alla sua bocca, ella era legata, mentre il suo occhio aveva creduto di poter opporre a esse un freddo disprezzo.
GLI OCCHI SI APRONO
È noto che per concorde volere e con le migliori intenzioni dei suoi genitori, Mut era stata ancora in tenera età promessa e data in moglie al figlio di Huij e Tuij, particolare che merita di venire ricordato ancora una volta per la conseguenza intima che portò con sé; ella infatti si abituò fin d’allora alla formalità esteriore dei suoi rapporti coniugali, mentre il momento che avrebbe potuto far sentire alla sua vita organica che a tale condizione mancava qualche cosa era ancora avvolto nell’oscurità. Non è superfluo notare questo: di nome la sua verginità era già stata cancellata prima del tempo, e tale stato non si modificò in seguito. Appena varcata la soglia della pubertà, ancora adolescente si trovò a essere la signora viziata di un nobile harem ai suoi ordini, circondata da ogni fasto, portata in palma di mano dalla sottomissione selvaggia di nude ragazze more e di eunuchi che s’inchinavano premurosi a ogni suo passo, lei la prima e la vera tra altre quindici bellezze del paese, tutte di origine assai diversa, che là vegetavano mollemente nel lusso, esse stesse tutte insieme puro e vuoto lusso, un superfluo decoro, accessorio di parata della Casa della Benedizione, l’ingodibile corte d’amore di un cortigiano. Regina di tutto questo stuolo di donne starnazzanti, perdute nelle proprie fantasticherie, ossequiose ogniqualvolta ella inarcava un sopracciglio, immerse nella più profonda melanconia se era triste, pronte a esplodere nella gioia più tumultuosa se si mostrava lieta, e che per il resto passavano il loro tempo a litigare scioccamente per piccoli e insignificanti favori di Peteprê, il signore, quando questi, mentre venivano distribuiti dolciumi e liquori d’ambra, seduto in mezzo a loro giocava con Mut-em-enet una partita d’onore sulla scacchiera: astro dell’harem, ella era nello stesso tempo la signora a testa di tutta la casa, moglie di Potifar in un senso più intimo e più alto che non quelle concubine; in una parola, la “signora”, colei che in altre circostanze sarebbe stata la madre dei suoi figli, colei che nell’edificio principale della tenuta aveva a piacer suo un proprio appartamento (posto a oriente della sala ipostila settentrionale, dove Giuseppe soleva nel pomeriggio leggere al signore e che separava l’una dall’altra le camere dei coniugi), colei che quando Potifar, l’Amico di Faraone, dava feste rallegrate da musiche e danze per l’alta società di Tebe, assolveva inoltre il ruolo di padrona di casa e che con Potifar si recava a consimili feste in altre case signorili, soprattutto a corte.
La sua e...