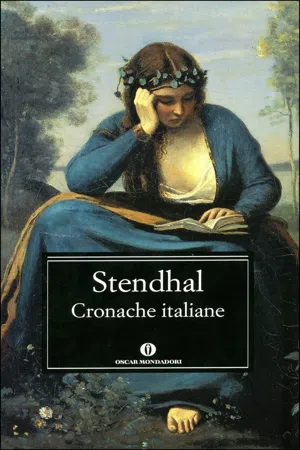
- 352 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Cronache italiane
Informazioni su questo libro
Otto racconti che prendono spunto da cronache del Rinascimento italiano: storie di passioni travolgenti, di ambizioni sfrenate e di perfide vendette.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Cronache italiane di Stendhal, Maria Bellonci, Gabriella Leto, Maria Bellonci,Gabriella Leto in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788804340560eBook ISBN
9788852065385La Badessa di Castro
Capitolo I
Il melodramma ci ha mostrato così spesso i briganti italiani del XVI secolo e tanti ne hanno parlato senza conoscerli che noi abbiamo ora di loro le idee più false. In generale si può dire che quei briganti rappresentarono l’opposizione contro gli atroci governi che in Italia succedettero alle repubbliche del Medioevo. Il nuovo tiranno fu di solito il cittadino più ricco della defunta repubblica, colui che, per conquistare il basso popolo, ornava la città di chiese splendide e di bei quadri. Tali furono i da Polenta a Ravenna, i Manfredi a Faenza, i Riario a Imola, i Cane a Verona, i Bentivoglio a Bologna, i Visconti a Milano, e infine, i meno bellicosi e i più ipocriti di tutti, i Medici a Firenze. Tra gli storici di questi piccoli stati nessuno ha osato raccontare gli avvelenamenti e gli assassinii innumerevoli, imposti dalla paura che tormentava i dispotici principi. Quegli storici austeri erano da loro stipendiati. Pensate che ognuno di questi tiranni conosceva personalmente tutti i repubblicani da cui sapeva di essere esecrato (il granduca di Toscana, Cosimo, conosceva per esempio lo Strozzi), che parecchi di loro morirono assassinati e comprenderete gli odi profondi, gli eterni sospetti che conferirono tanto slancio e coraggio agli italiani del XVI secolo, e così grande genio ai loro artisti. Vedrete tali profonde passioni impedire il prodursi di quel pregiudizio alquanto ridicolo che al tempo di Madame de Sévigné era chiamato onore e che consiste soprattutto nel sacrificio della propria vita per servire il padrone di cui si è sudditi dalla nascita e per piacere alle dame. Nel XVI secolo l’attività di un uomo e il suo reale valore in Francia non potevano affermarsi e conquistare ammirazione se non per la bravura sul campo di battaglia e nei duelli. E poiché le donne amano il coraggio e soprattutto l’audacia, proprio quelle divennero i giudici supremi del valore di un uomo. Allora nacque l’esprit de galanterie, che aprì la strada al successivo annientamento di tutte le passioni, e perfino dell’amore, a vantaggio di un tiranno crudele al quale tutti obbediamo: la vanità. I re protessero la vanità e davvero a ragione: da quella venne l’impero delle onorificenze.
In Italia un uomo poteva distinguersi per meriti di ogni genere, per l’abilità di spadaccino o per la scoperta di antichi manoscritti, come Petrarca, l’idolo del suo tempo. E una donna del XVI secolo amava un uomo dotto in greco altrettanto e più di quanto non avrebbe amato un uomo celebre per il suo valore in guerra. Fu quella un’epoca di passioni e non di consuetudini galanti. Ecco la grande differenza tra l’Italia e la Francia, ecco perché l’Italia ha visto nascere un Raffaello, un Giorgione, un Tiziano, un Correggio, mentre la Francia produceva tutti quei bravi capitani del XVI secolo oggi del tutto sconosciuti benché ognuno di loro avesse ucciso innumerevoli nemici.
Chiedo perdono di queste brutali verità. Comunque sia le vendette atroci e necessarie dei piccoli tiranni italiani del Medioevo donarono ai briganti l’affetto delle plebi. I briganti erano odiati quando rubavano cavalli, grano, denaro e insomma quanto gli era necessario per vivere. Ma in fondo la simpatia popolare era per loro, e le ragazze del villaggio preferivano a ogni altro quel giovane che una volta nella vita aveva dovuto andare alla macchia, ossia fuggire nei boschi e rifugiarsi presso i briganti dopo un’eccesso di imprudenza.
Ancora oggi certamente non c’è nessuno che non abbia timore di incontrare i briganti, ma se quelli vengono puniti, tutti li compatiscono. Poiché quel popolo così fine, così ironico, che irride tutti gli scritti autorizzati dalla censura dei suoi padroni, legge d’abitudine poemetti che narrano con trasporto la vita dei briganti più famosi. Quello che c’è di eroico in queste storie avvince l’istinto popolare naturalmente portato all’arte, e il popolo del resto è talmente stanco delle lodi ufficiali tributate a certuni che proprio quanto c’è di non ufficiale in questo genere di letture lo tocca al cuore. Bisogna sapere che il basso popolo in Italia sopporta cose di cui un viaggiatore che pure vivesse qui per dieci anni mai si accorgerebbe. Per esempio quindici anni fa, prima che l’assennatezza dei governi avesse soppresso il brigantaggio, era possibile non di rado vedere come certe iniziative dei briganti punissero l’iniquità dei governatori di talune piccole città. Questi governatori, magistrati assoluti la cui paga non va oltre i venti scudi al mese, sono agli ordini, come è naturale, della famiglia più cospicua del paese, la quale, con questo molto semplice sistema, non dà respiro ai propri nemici. Se non sempre i briganti riuscivano a punire quei piccoli despoti di governatori, riuscivano almeno a deriderli e a provocarli, il che non è poca cosa agli occhi di un popolo così ricco di umori. Un sonetto satirico lo consola di tutti i mali, né offesa alcuna restò mai inobliata. Ecco un’altra delle fondamentali differenze tra l’Italiano e il Francese.
Nel secolo XVI se il governatore di un borgo aveva condannato a morte un povero montanaro malvisto dalla famiglia prevalente, accedeva che i briganti prendessero d’assalto la prigione e cercassero di liberare l’oppresso. D’altra parte la potente famiglia, che non si fidava troppo degli otto o dieci soldati incaricati dal governo di fare la guardia alla prigione, armava a sue spese un drappello di soldati avventizi. E questi, che erano chiamati bravi, bivaccavano nei pressi della prigione e accettavano di scortare fino al luogo del supplizio il pover’uomo la cui morte era stata comprata. Se poi la potente famiglia contava un giovane tra i suoi membri, questi si metteva alla testa di quei soldati occasionali. Una civiltà in questo stato strazia, sono d’accordo, la morale. Oggi abbiamo il duello, la noia e giudici che non si vendono, e tuttavia usanze come quelle del XVI secolo erano straordinariamente adatte a creare uomini degni di questo nome.
Molti storici, ancora oggi elogiati dal convenzionalismo della letteratura accademica, hanno cercato di dissimulare uno stato di cose come quello che verso il 1550 diede vita a così grandi personalità. Al loro tempo tali prudenti menzogne furono compensate con tutti gli onori di cui potevano disporre i Medici a Firenze, gli Estensi a Ferrara, i viceré a Napoli, ecc. Uno storico, quel povero Giannone, ha voluto sollevare un lembo del velo, ma poiché non ha osato dire che una piccolissima parte della verità, e per di più in forma dubitativa e oscura, ha ottenuto il solo risultato di riuscire noiosissimo senza peraltro evitare di morire in carcere a ottantadue anni nel 1758.
La prima cosa da fare quando si voglia conoscere la storia d’Italia è dunque di non leggere gli autori generalmente approvati. Mai altrove è stato conosciuto meglio il prezzo della menzogna, mai altrove meglio pagato.
Le prime storie che siano state scritte in Italia dopo la grande barbarie del IX secolo fanno già menzione di briganti e ne parlano come se esistessero da tempo immemorabile. Potete vedere la raccolta del Muratori. Quando, per disgrazia del benessere pubblico, della giustizia, del buon governo, ma fortunatamente per le arti, le repubbliche del Medioevo furono oppresse, i repubblicani più energici, quelli che più che non la maggioranza dei cittadini amavano la libertà si rifugiarono nei boschi. È naturale che il popolo, vessato dai Baglioni, dai Malatesta, dai Bentivoglio, dai Medici, provasse simpatia e rispetto per i loro nemici. Le crudeltà dei piccoli tiranni che succedettero ai primi usurpatori, per esempio le crudeltà di Cosimo I granduca di Firenze, che faceva assassinare i repubblicani anche quando si erano rifugiati a Venezia e perfino a Parigi, fornirono reclute a quei briganti. Per non parlare se non dei tempi prossimi a quelli in cui visse la nostra eroina, verso l’anno 1550 Alfonso Piccolomini duca di Monte Mariano e Marco Sciarra guidavano con successo alcune bande armate che, nei dintorni di Albano, sfidavano gli allora molto coraggiosi soldati del papa. La zona operativa di questi famosi condottieri, che il popolo ammira ancora, si stendeva dal Po e le paludi di Ravenna fino ai boschi che allora coprivano il Vesuvio. La foresta della Faggiola, così celebre per le loro imprese, situata a cinque leghe da Roma sulla via di Napoli, era il quartier generale di Sciarra, il quale sotto il pontificato di Gregorio XIII riuscì talvolta a mettere insieme diverse migliaia di soldati. La storia dettagliata di questo brigante illustre riuscirebbe incredibile alla generazione attuale, nel senso che le motivazioni dei suoi atti non potrebbero mai essere comprese. Egli non fu vinto se non nel 1592. Allorché vide che la sua situazione era disperata, trattò con la repubblica di Venezia e passò al servizio di questa con i soldati più devoti o se si vuole più compromessi. Alle proteste del governo romano Venezia, che aveva firmato un trattato con Sciarra, lo fece assassinare e inviò i suoi valorosi soldati a difendere l’isola di Candia contro i Turchi. Ma la saggezza veneziana sapeva bene che una peste micidiale regnava a Candia e in pochi giorni i cinquecento soldati che Sciarra aveva condotto con sé al servizio della repubblica si ridussero a sessantasette.
Questa foresta della Faggiola, i cui alberi giganteschi coprono un antico vulcano, fu l’ultimo teatro delle imprese di Marco Sciarra. Tutti i viaggiatori vi diranno che è il posto più bello della mirabile campagna romana, il cui cupo aspetto sembra fatto per la tragedia. Con la sua nera vegetazione, questa foresta incorona le cime del monte Albano.
Dobbiamo questa stupenda montagna a una eruzione vulcanica anteriore di alquanti secoli alla fondazione di Roma. In un tempo che ha preceduto ogni storia essa sorse in mezzo alla vasta pianura che si stendeva tra gli Appennini e il mare. Il monte Cavo, che si eleva circondato dalle ombre cupe della Faggiola, ne è il punto culminante. Lo si vede dappertutto, da Terracina e da Ostia, da Roma e da Tivoli, e sono i monti albani, oggi coperti di ville, a chiudere a mezzogiorno l’orizzonte romano così noto ai viaggiatori. Un convento di monaci neri ha sostituito sulla cima del Monte Cavo il tempio di Giove Feretrio, dove i popoli latini venivano a sacrificare in comune e a rinsaldare una federazione a suo modo religiosa. Protetto dall’ombra di superbi castagni il viaggiatore arriva in poche ore agli enormi blocchi in cui si distinguono le rovine del tempio di Giove. Ma sotto le ombre cupe, deliziose in un clima come questo, anche oggi il viaggiatore guarda turbato al fondo della foresta, e ha paura dei briganti. Quando ha raggiunto la cima del Monte Cavo, un fuoco per la cottura degli alimenti viene acceso tra le rovine. Da qui, dominandosi tutta la campagna romana, si scorge al tramonto il mare, che sembra a due passi, benché sia a tre o quattro leghe, e si distinguono i più piccoli battelli. Con il più debole dei cannocchiali si possono contare i passeggeri che vanno a Napoli col bastimento a vapore. Da tutte le altre parti la vista si stende su una pianura stupenda, limitata a levante dall’Appennino, sopra Palestrina, e a nord da San Pietro e dagli altri grandi edifici di Roma. E poiché il Monte Cavo non è molto alto l’occhio distingue i minimi particolari di questo luogo sublime che non ha bisogno di illustrazione storica quantunque ogni boschetto, ogni pezzo di muro intravisto nella pianura o sulle pendici della montagna ricordi una delle battaglie, eccelse per patriottismo e valore, narrate da Tito Livio.
Anche oggi per raggiungere gli enormi blocchi che sono i resti del tempio di Giove Feretrio e che fungono da muro al giardino dei monaci neri è possibile seguire la via trionfale, quella che un tempo era percorsa dai primi re di Roma. È lastricata di pietre tagliate molto regolarmente e se ne trovano lunghi tratti in mezzo alla foresta della Faggiola.
Sull’orlo del cratere spento che, ormai colmo di acqua limpida, è divenuto il bel lago di Albano dalla circonferenza di cinque o sei miglia, profondamente calato nella roccia di lava, era situata Alba, la madre di Roma, che la politica romana distrusse dai tempi dei primi re. Nondimeno ne esistono ancora le rovine. Qualche secolo più tardi, a un quarto di lega da Alba, sul versante della montagna che guarda il mare, è sorta Albano, la città moderna. Ma la separa dal lago una cortina di rocce che nascondono il lago alla città e la città al lago. Guardandola dal piano i suoi bianchi edifici risaltano sulla vegetazione cupa e profonda della foresta così cara ai briganti e così spesso nominata che circonda da ogni parte la montagna vulcanica.
Albano, che oggi ha cinque o seimila abitanti non ne aveva neppure tremila nel 1540 allorché la potente famiglia Campireali, di cui stiamo per narrare le sventure, emergeva tra le più nobili.
Traduco questa storia da due voluminosi manoscritti, l’uno romano, l’altro fiorentino. Con mio grande rischio ho osato riprodurne lo stile, che è pressocché quello delle nostre antiche leggende. Lo stile così fine e misurato del nostro tempo non si sarebbe accordato, mi sembra, con i fatti narrati e soprattutto con le riflessioni degli autori. Questi scrivevano intorno all’anno 1598. Chiedo l’indulgenza del lettore per loro e per me.
Capitolo II
“Dopo avere scritto tante storie tragiche, dice l’autore del manoscritto fiorentino, concluderò con quella che di tutte più mi fa pena raccontare. Parlerò della famosa badessa del convento della Visitazione a Castro Elena di Campireali, il cui processo e la cui morte fecero tanto parlare l’alta società romana e italiana. Verso il 1555 i briganti spadroneggiavano ormai nei dintorni di Roma e i magistrati erano venduti alle famiglie potenti. Nel 1572, l’anno del processo, Gregorio XIII Buoncompagni salì al soglio di san Pietro. Questo santo pontefice possedeva tutte le virtù apostoliche, ma al suo governo civile non sono mancate accuse di debolezza. Non seppe scegliere giudici onesti né reprimere i briganti, si affliggeva dei delitti e non sapeva punirli. Gli sembrava che infliggendo la pena di morte si sarebbe assunto una terribile responsabilità. Il risultato di questo modo di pensare fu quello di popolare di un numero pressoché infinito di briganti le strade che conducono alla città eterna. Per viaggiare con una certa sicurezza bisognava essere amici dei briganti. La foresta della Faggiola, a cavallo sulla via di Napoli che passa per Albano era da molto tempo il quartiere generale di un governo avverso a quello di sua Santità e molte volte Roma fu costretta a trattare, come da potenza a potenza, con Marco Sciarra, uno dei re della foresta. La forza di questi briganti consisteva nell’essere amati dai contadini dei luoghi a loro vicini.
“Questa graziosa città di Albano, così prossima al quartiere generale dei briganti, vide nascere nel 1542 Elena di Campireali. Suo padre era considerato il patrizio più ricco del paese e a questo doveva il suo matrimonio con Vittoria Carafa, possidente di vaste terre nel regno di Napoli. Potrei indicare dei vecchi ancora vivi che hanno conosciuto bene Vittoria Carafa e sua figlia. Vittoria fu un modello di prudenza e di acume, ma, malgrado tutto il suo ingegno, non poté evitare la rovina della famiglia. Che strana cosa! Le atroci sventure che saranno il triste argomento del mio racconto non possono essere attribuite, mi sembra, a nessuno in particolare dei personaggi che presenterò al lettore: vedo degli sventurati ma, in verità, non riesco a trovarne di colpevoli. L’estrema bellezza e l’anima tenerissima della giovane Elena erano per lei due grandi pericoli, e costituiscono un’attenuante per il suo amante Giulio Branciforte, così come l’assoluta mancanza di intelligenza di monsignor Cittadini vescovo di Castro può fino a un certo punto scusarlo. Egli doveva il rapido avanzamento nella carriera ecclesiastica a un’onesta condotta e soprattutto all’aspetto più nobile e al volto più regolarmente bello che sia possibile incontrare. Trovo scritto di lui che non si poteva vederlo senza amarlo.
“Dal momento che non voglio adulare nessuno non nasconderò affatto che un santo monaco del convento di Monte Cavo, il quale era stato spesso sorpreso nella sua cella sospeso a parecchi piedi dal suolo come san Paolo senza che niente altro se non la grazia divina potesse sostenerlo in quella posizione abnorme, aveva predetto al signore di Campireali che la sua famiglia si sarebbe estinta con lui e che avrebbe avuto due figli i quali sarebbero morti entrambi di morte violenta. Fu proprio per questa predizione che quello non trovò moglie nel paese e andò a cercare fortuna a Napoli dove ebbe la felice sorte di trovare grandi beni e una donna capace, per il suo talento, di stornare da lui quel triste destino, se solo fosse stato possibile. Questo signore di Campireali era considerato un uomo molto onesto e di certo era assai caritatevole ma privo di qualsiasi ingegno, il che fece sì che a poco a poco rinunciasse a vivere a Roma e finisse per passare quasi tutto l’anno nel palazzo di Albano, dedicandosi alla coltivazione delle sue terre, che si estendevano nella ricca pianura tra la città e il mare. Seguendo i consigli della moglie fece educare splendidamente il figlio Fabio, giovane molto orgoglioso del suo casato, e la figlia Elena, che fu un miracolo di bellezza come ancora può vedersi dal ritratto della collezione Farnese. Dopo avere iniziato a raccontarne la storia sono andato a palazzo Farnese per osservare l’involucro mortale che il cielo aveva dato a questa donna, il cui fat...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Introduzione
- Cronologia
- Bibliografia
- Nota
- Cronache italiane
- La Duchessa di Paliano
- Vittoria Accoramboni. Duchessa di Bracciano
- I Cenci. 1599
- San Francesco a Ripa. Ariste e Dorante avendo trattato questo argomento, hanno dato a Erarte l’idea di trattarlo.
- Vanina Vanini. Particolari sull’ultima “vendita” di Carbonari scoperta negli Stati Pontifici
- La Badessa di Castro
- Troppo favore uccide
- Suora Scolastica – seconda versione
- Copyright