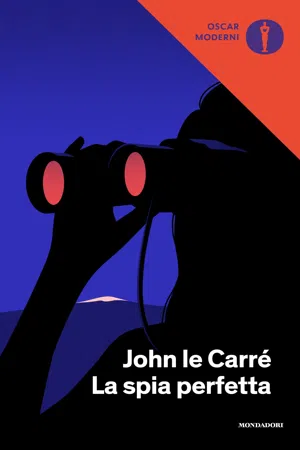Una burrascosa mattina d’ottobre, prima dell’alba, in una città di mare del Devon meridionale da cui sembrava che tutti fossero fuggiti, Magnus Pym scese da un vecchio tassì di provincia e, avendo pagato l’autista e atteso finché non fu ripartito, attraversò la piazza della chiesa. Era diretto verso una via in cui abbondavano albergucci d’età vittoriana malamente illuminati con nomi quali Bel-a-Vista, The Commodore, Eureka. Di robusta costituzione ma di nobile portamento, Pym simboleggiava qualcosa. Procedeva con passo agile, il corpo inclinato in avanti secondo la miglior tradizione della classe dirigente anglosassone. Con quello stesso atteggiamento, fermi o in movimento, altri inglesi hanno piantato la bandiera su colonie remote, hanno scoperto le sorgenti di grandi fiumi, sono rimasti sull’attenti sul ponte di navi che colavano a picco. Tra una cosa e l’altra, era in viaggio da sedici ore, ma non aveva né soprabito né cappello. Reggeva una pingue cartella nera dall’aspetto molto ufficiale e, con l’altra mano, una borsa verde di Harrods. L’impetuoso vento di mare frustava l’abito cittadino, la pioggia salmastra gli bruciava gli occhi, fiocchi di spuma svolazzavano sul suo cammino. Pym non se ne preoccupava. Arrivato davanti al portico di una casa che mostrava un cartello con la scritta “Completo”, suonò il campanello e attese prima che si accendesse la luce esterna, e poi che tirassero i catenacci dall’interno. Mentre aspettava, un campanile cominciò a battere le cinque. Quasi in risposta a quel richiamo Pym si girò e guardò la piazza. Guardò il campanile sgraziato della chiesa battista che si stagliava contro le nuvole in corsa; le araucarie convulse, orgoglio dei giardini; il palco vuoto della banda; la fermata dell’autobus; i pozzi bui delle strade laterali; i portoni, uno per uno.
«Ah, ma è il signor Canterbury!» lo rimproverò con una certa asprezza una voce di vecchia mentre la porta alle sue spalle si apriva. «Cattivo. Ha preso anche questa volta il treno della notte, immagino. Perché non ha telefonato?»
«Salve, signorina Dubber» disse Pym. «Come sta?»
«Lasciamo perdere come sto, signor Canterbury, e venga subito dentro. Si prenderà un accidente.»
Ma Pym era come affascinato dalla brutta piazza spazzata dal vento. «Credevo che il Sea View fosse in vendita, signorina D.» disse mentre lei cercava di tirarlo in casa. «Non mi ha detto che il signor Cook ha traslocato quando gli è morta la moglie? Che non avrebbe mai più messo piede in quella casa?»
«Certo. Non la sopportava più. Venga dentro immediatamente, signor Canterbury, e si asciughi i piedi mentre le faccio il tè.»
«E perché allora c’è la luce accesa in camera da letto?» chiese Pym mentre si faceva trascinare su per i gradini.
Come molti tiranni, anche la signorina Dubber era bassa di statura. Inoltre era vecchia, fragile e sbilenca; la schiena ricurva le deformava la vestaglia facendo sembrare sbilenco anche tutto ciò che aveva intorno.
«Il signor Cook ha affittato il piano di sopra a Celia Venn, che lo usa per dipingerci. Lei è proprio un bel tipo, sa?» Chiuse un catenaccio. «Sparisce per tre mesi, ricompare a notte fonda e si preoccupa perché vede la luce accesa nella casa di un altro.» Chiuse un altro catenaccio. «Lei non cambierà mai, signor Canterbury. Non so perché io stia a darmi tanta pena per lei.»
«Chi diamine è Celia Venn?»
«È la figlia del dottor Venn, sciocco. Vuole vedere il mare e dipingerlo.» Il tono di voce di lei cambiò bruscamente. «Come si permette, signor Canterbury? Se la tolga immediatamente.»
Chiuso l’ultimo catenaccio, la signorina Dubber si era raddrizzata per quanto poteva preparandosi a un abbraccio riluttante. Ma invece che nel solito cipiglio, che nessuno prendeva mai sul serio, il suo volto sciupato si era contratto in una smorfia di spavento.
«Quella cravatta nera è orribile, signor Canterbury. Non c’è la morte in casa mia e non voglio che ce la porti lei. Per chi è?»
Pym era un bell’uomo dall’aspetto un po’ troppo giovanile ma distinto. Poco più che cinquantenne, era nel pieno vigore della sua maturità, colmo di ardore e di energia in un luogo in cui queste qualità erano sconosciute. Ma agli occhi della signorina Dubber il suo pregio maggiore era il delizioso sorriso che comunicava calore e verità e che le scaldava il cuore.
«Solo un collega di Whitehall, signorina D. Nulla di drammatico. Non era una persona cui fossi particolarmente vicino.»
«Tutti ci sono vicini, alla mia età, signor Canterbury. Come si chiamava?»
«Lo conoscevo appena» tenne a chiarire Pym togliendosi la cravatta e mettendosela in tasca. «E non ho nessuna intenzione di far nomi per poi vederla spulciare i necrologi, ecco tutto.» Così dicendo, l’occhio gli cadde sul registro degli ospiti, aperto sul tavolo dell’ingresso sotto la lampada velata arancione che lui aveva montato sul soffitto durante il suo precedente soggiorno. «Qualche ospite di passaggio, signorina D.?» chiese scorrendo i nomi. «Qualche coppia di fuggitivi, qualche principessa misteriosa? Che ne è stato di quei due giovani amanti che sono arrivati a Pasqua?»
«Non erano giovani amanti» lo corresse con severità la signorina Dubber avviandosi zoppicando verso la cucina. «Avevano due stanze separate e la sera stavano alzati a guardare il football alla televisione. Che cos’ha detto, signor Canterbury?»
Ma Pym non aveva detto nulla. Certe volte i suoi slanci di comunicazione assomigliavano a telefonate interrotte a metà da una qualche censura interna. Tornò indietro di una, due pagine.
«Non credo che prenderò più ospiti di passaggio» disse la signorina Dubber dalla cucina mentre accendeva il gas. «Certe volte quando suona il campanello io me ne sto seduta qui con Toby e dico: “Va’ tu ad aprire, Toby”. Lui non ci va, com’è naturale. Un gatto tigrato non sa aprire le porte. Così restiamo seduti tutt’e due. Restiamo seduti ad aspettare finché sentiamo i passi che si allontanano.» Gli gettò un’occhiata provocatoria attraverso la porta aperta della cucina. «Non ti sembra, Toby, che il nostro signor Canterbury sia innamorato?» chiese maliziosamente al gatto. «Come siamo belli, stamane. Come siamo lustri. Dieci anni di meno, a giudicare da quel che si vede, il signor Canterbury.» Non ricevendo risposta dal gatto, si rivolse al canarino. «Non che ce lo verrebbe a dire, eh, Dickie? Noi saremmo gli ultimi a saperlo. Pio pio? Pio pio?»
«John e Sylvia Illeggibile di Wimbledon» disse Pym ancora intento a sfogliare il registro.
«John fabbrica computer e Sylvia li programma. Se ne vanno domani» disse lei imbronciata. Perché la signorina Dubber non voleva ammettere che nel suo mondo esistesse qualcun altro oltre l’amato signor Canterbury. «E cos’altro ha preso, stavolta?» esclamò rabbiosamente la signorina Dubber. «Non lo voglio. Se lo riprenda.»
Ma la signorina Dubber non era affatto arrabbiata, avrebbe accettato il dono e Pym non se lo sarebbe ripreso: uno scialle di cachemire a maglie fitte bianco e oro ancora nella sua confezione di Harrods e avvolto nella carta velina pure di Harrods: cose che lei sembrò apprezzare quasi più dello scialle stesso. Infatti, tolto lo scialle dalla scatola, la signorina Dubber prima lisciò ben bene la carta velina e la ripiegò e la rimise nella scatola; quindi prese la scatola e la chiuse nella credenza, là dove teneva i suoi tesori più cari. Solo a questo punto gli permise di metterle lo scialle sulle spalle, rimproverandolo nel frattempo per la spesa esagerata.
Pym bevve il tè della signorina Dubber, Pym la ammansì, Pym mangiò uno dei suoi biscotti elogiandone la bontà benché lei sostenesse che le erano riusciti bruciati. Pym promise di sistemare il tappo del lavandino, di sturare lo scarico e già che c’era di dare anche un’occhiata al serbatoio al piano di sopra. Pym si mostrò lesto e premuroso, sempre conservando quell’aria di vitalità che la signorina Dubber aveva accortamente notato in lui. Si prese Toby in grembo e l’accarezzò, cosa che non aveva mai fatto in precedenza e che non procurò a Toby alcun visibile piacere. Ascoltò le ultime notizie sul conto della vecchia zia della signorina Dubber, la zia Al, quando normalmente bastava un accenno alla zia Al per farlo andare immediatamente a letto. Le chiese, come sempre, se c’erano novità, e ascoltò annuendo l’elenco delle lagnanze della signorina Dubber. E spesso, annuendo ai discorsi di lei, o sorrideva tra sé per motivi non chiari o sbadigliava al riparo della mano. Finché mise giù bruscamente la tazzina e si alzò, quasi che avesse un altro treno da prendere.
«Se per lei va bene mi fermerei un po’ a lungo, signorina D. Ho da scrivere parecchio.»
«Dice sempre così. L’ultima volta sembrava che volesse stabilirsi qui per sempre. Poi si sveglia la mattina e torna a Whitehall saltando la colazione.»
«Potrei fermarmi anche due settimane. Ho preso un congedo così da poter lavorare in pace.»
La signorina Dubber si finse sgomenta. «Ma cosa succederà alla nazione? Come potremo io e Toby sentirci al sicuro senza il signor Canterbury al timone dello Stato?»
«Dunque che programmi ha, signorina?» chiese lui con un sorriso affascinante prendendo la grossa cartella che, dallo sforzo necessario per sollevarla, si sarebbe detto fosse piena di piombo.
«Programmi?» ripeté la signorina Dubber ancora sorridendo per la sua battuta. «Non si fanno programmi alla mia età, signor Canterbury. Si lasciano a Dio. Lui in questo è molto più bravo di me, non è vero, Toby? Più affidabile.»
«E quella crociera di cui mi parla sempre? È ora che si conceda un regalo, signorina D.»
«Non faccia lo sciocco. Questo succedeva anni fa. Ne ho perso la voglia.»
«Sono sempre disposto a offrirgliela io, la crociera.»
«Lo so, che Dio la benedica.»
«Telefono io. All’agenzia di viaggio possiamo andarci insieme. Anzi, ne ho già trovato una che andrebbe benissimo: L’Orient Explorer salpa da Southampton tra una settimana. Si è liberato un posto. Mi sono già informato.»
«Sta cercando di mandarmi via a tutti i costi, signor Canterbury?»
Pym rise brevemente. «Nemmeno insieme a Dio potrei smuoverla da qui, signorina D.» disse.
Ferma nell’ingresso, la signorina Dubber lo guardò avviarsi su per la scala stretta ammirando il passo giovanile ed elastico nonostante la cartella pesante. Sta andando a una conferenza ad alto livello. E molto importante, anche. Ascoltò i passi leggeri che percorrevano il corridoio verso la stanza numero 8, quella che dava sulla piazza e che lui aveva in affitto da anni, come mai le era capitato nella sua lunga vita. Quella morte non l’aveva turbato, stabilì sollevata sentendolo girare la chiave e poi chiudere piano la porta. Soltanto qualche collega del ministero, e non una persona cara. Avrebbe voluto che nulla lo turbasse. Lui doveva rimanere lo stesso perfetto gentiluomo che aveva suonato il campanello anni prima cercando – parole sue – un rifugio senza telefono, per quanto ci fosse un apparecchio perfettamente funzionante in cucina. E da allora le pagava in anticipo l’affitto ogni sei mesi, in contanti e senza ricevuta. E le aveva costruito il muretto di pietre in giardino lungo il sentiero, tutto quanto in un solo pomeriggio per farle una sorpresa il giorno del suo compleanno, facendo lavorare come dannati il muratore e il manovale. E dopo la tempesta di marzo aveva rimesso a posto con le sue mani le lastre del tetto. E le aveva mandato fiori, frutta, cioccolatini, souvenir dall’estero, da posti stranissimi senza mai spiegare davvero le ragioni per cui c’era andato. E l’aveva aiutata a preparare il breakfast quando c’erano troppi ospiti di passaggio, e l’aveva ascoltata quando parlava di suo nipote, che conosceva ogni sorta di metodi per far soldi che non portavano mai a niente: l’ultima era di metter su una sala per il gioco della tombola a Exeter, sennonché prima aveva bisogno dei soldi per saldare lo scoperto di conto. E non riceveva né posta né visite, non suonava strumenti musicali limitandosi ad ascoltare certe stazioni estere alla radio, e telefonava soltanto ai bottegai del vicinato. E nulla le aveva detto di sé, tranne che abitava a Londra e lavorava a Whitehall ma viaggiava molto, e che si chiamava Canterbury come la città. Figli, mogli, genitori, fidanzate: non aveva un’anima viva tranne la sua signorina D.
«Potrebbe essere baronetto, per quel che ne sappiamo» disse a Toby accostando lo scialle al naso e aspirandone l’odore di lana. «Potrebbe anche essere il primo ministro, e noi lo verremmo a sapere soltanto dalla televisione.»
Appena percettibile sopra lo strepito del vento la signorina Dubber sentì una voce che cantava. Una voce maschile stonata ma gradevole. Dapprima pensò che cantassero Greensleeves in giardino, e poi Jerusalem nella piazza, e già stava avviandosi verso la finestra per gridare di smetterla. Fu allora che capì che era il signor Canterbury al piano di sopra, e ciò la stupì a tal punto che aprì la porta per sgridarlo e invece si fermò ad ascoltare. Il signor Canterbury smise di cantare da sé. La signorina Dubber sorrise. Ora è lui che ascolta me, pensò. È proprio il mio signor Canterbury.
Tre ore prima, a Vienna, la signora Mary Pym, moglie di Magnus, dalla finestra della camera da letto guardava un mondo che, contrariamente a quello scelto dal marito, era meravigliosamente sereno. Non aveva tirato le tende né acceso la luce. Era vestita per ricevere, come avrebbe detto sua madre, e stava alla finestra già da un’ora con il suo completino blu di maglia, aspettando la macchina, aspettando il campanello, aspettando il lieve girare della chiave del marito nella serratura. E ora nella sua mente si svolgeva una gara sleale tra Magnus e Jack Brotherhood, per vedere chi dei due avrebbe ricevuto per primo. La neve precocemente caduta all’inizio d’autunno ricopriva la cima della collina, e la luna piena alta nel cielo riempiva la stanza di barre bianche e nere. Nelle ville eleganti lungo il viale gli ultimi fuochi dei ricevimenti diplomatici andavano spegnendosi a uno a uno. La moglie del ministro Meyerhof aveva dato un ballo in occasione dei colloqui per la riduzione degli armamenti al quale avrebbe suonato un quartetto. Mary ci sarebbe dovuta andare. I Van Leyman davano invece un buffet freddo in onore della vecchia guardia praghese: entrambi i sessi e niente cartellini sulla tavola. Ci sarebbe dovuta andare – ci sarebbero anzi dovuti andare entrambi – e raccogliere poi i tiratardi per un whisky e soda, vodka per Magnus. E mettere su dischi e ballare fino a quell’ora o anche più tardi – i famosi ballerini Pym – proprio come quella volta famosa a Washington quando Magnus era vicecapo di stazione e tutto era assolutamente meraviglioso. Poi Mary avrebbe potuto fare uova e pancetta mentre Magnus scherzava e faceva domande trabocchetto e si faceva nuovi amici, cose in cui era bravissimo e di cui non si stancava mai. A questo serviva la stagione a Vienna, quando la gente che per tutto l’anno teneva la bocca chiusa parlava tutta eccitata di Natale e dell’Opera, e buttava via indiscrezioni come vestiti vecchi.
Ma tutto questo avveniva mille anni prima. Così era stato fino a mercoledì scorso. Adesso una cosa sola importava, e cioè che Magnus comparisse lungo il viale con la Metro che aveva lasciato all’aeroporto e arrivasse alla porta prima di Jack Brotherhood.
Suonava il telefono. Accanto al letto. Dalla parte di lui. Non correre, cretina, se no caschi. E non andare troppo piano, se no riattacca. Magnus caro, oh mio Dio speriamo che sia tu, hai avuto un momento così ma ora stai meglio, non ti domanderò mai cos’è successo, mai più dubiterò di te. Alzò il ricevitore e per qualche incomprensibile ragione si buttò a sedere scompostamente sul piumino del letto, afferrando con la mano libera carta e penna nel caso ci fossero da annotare numeri di telefono, indirizzi, orari, istruzioni. Non esclamò “Magnus!” perché così avrebbe mostrato di essere preoccupata per lui. Non disse “Pronto”, perché la voce avrebbe tradito l’agitazione. Disse invece il suo numero in tedesco così che Magnus potesse riconoscerla e capire che era perfettamente normale e stava bene e non era arrabbiata con lui, e che tutto era a posto e che poteva tornare. Niente scene, niente problemi: io sono qui e ti aspetto come sempre.
«Sono io» disse una voce maschile.
Ma non era lui. Era Jack Brotherhood.
«Saputo niente di quel pacco, immagino?» chiese Brotherhood nell’inglese rotondo e sicuro tipico dei militari.
«Non una parola da nessuno. Dove sei?»
«Arrivo tra mezz’ora, forse meno. Aspettami, ti prego.»
Il fuoco, le venne di colpo in mente. Mio Dio, il fuoco. Corse giù per le scale, non più in grado di distinguere tra disastri grandi e piccoli. Aveva dato la sera libera alla donna di servizio e si era dimenticata di mettere legna nel caminetto del salotto. Ora era spento di certo. Invece no. Il fuoco bruciava allegramente e ci voleva solo un altro ciocco per rendere meno funerea l’ora mattutina. Mise la legna sulle fiamme e prese ad aggirarsi per la stanza sistemando gli oggetti – i fiori, i portacenere, il vassoio del whisky per Jack – cercando di rendere perfetto tutto ciò che era fuori di lei proprio perché dentro di lei tutto er...