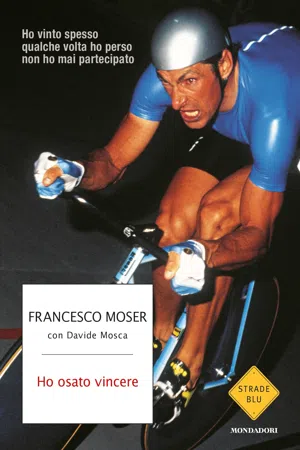La definiscono la corsa più dura al mondo. Io la definisco la mia corsa. Raccontano che è come scendere all’inferno. Io vi ho trovato il paradiso. Dicono che equivale ad andare in guerra. Per me è come tornare a casa.
La Parigi-Roubaix non è una gara di ciclismo, ma il ciclismo. È l’unica corsa al mondo in cui non conta la squadra. Sei solo. Tutti contro di te, e tu contro tutti. Come nell’arena dei gladiatori. Le pietre su cui si corre sono altrettanto antiche, impregnate del sudore e del sangue degli eroi del passato. Perché su questi cubi di porfido non basta sudare per trionfare. C’è un tributo di sangue da versare.
Dopo aver messo un piede in cielo a San Cristóbal, devo dimostrare di meritarmelo, il mio paradiso. Al mio ritorno dal Venezuela ho trovato un’accoglienza incredibile e incontrollabile. La gente è fuori di sé dalla gioia. Non credevo di aver fatto nulla di così eclatante. E non lo crede nemmeno mia mamma, che alla vista degli archi tirati su in mio onore in paese scuote la testa. «Gli archi si innalzano solo per i preti. Non sta bene farli per Francesco» si lamenta con i compaesani, troppo eccitati per prestarle ascolto.
Tutto il Trentino pare essersi riversato per le strade. Trento scoppia di gente festante. L’ultimo chilometro della strada che sale a Palù è stato dipinto con i colori dell’iride. Mi scortano a casa come un generale romano in trionfo. Le cantine restano aperte giorno e notte. Per l’occasione si mette in funzione l’enorme paiolo da due ettolitri che in piazza sforna polenta a getto continuo. Arriva gente da ogni paese d’Italia e non solo. Tutti vogliono stringermi la mano, mentre con l’altra stringono un bicchiere. È festa grande.
E non finisce. I Moser club sono scatenati. Presso l’hotel Trento viene organizzata una grande festa, a cui partecipano gli ex campioni del mondo italiani: Alfredo Binda, Marino Basso, Ercole Baldini, Vittorio Adorni, Felice Gimondi. Mi chiamano «l’Eroe dei due Mondi», perché ho conquistato la maglia iridata in Europa e in Sudamerica, unico ciclista insieme a Coppi ad aver primeggiato tanto sulla strada quanto sulla pista. Coppi, il grande assente e nel contempo presenza importante. Non ho deluso quei pronostici che hanno accompagnato il mio passaggio dai «puri» ai professionisti. Soprattutto non ho tradito la fiducia dei miei cari.
La gloria è davvero pericolosa. Ti seduce, come l’alcol. Prima sei tu a prendere lei, e un attimo dopo è lei a prendere te. È difficile resisterle, è come un vortice. La mia fortuna è quella di avere i piedi ben piantati per terra, quando non li tengo sui pedali. E se non bastasse la mia formazione e la mia filosofia di vita, c’è mamma Cecilia a indicare la giusta rotta. Quando le chiedono cosa cambierà adesso per lei, con un figlio campione del mondo, risponde seria: «Avrò una maglia in più da lavare».
L’antidoto all’ubriacatura di gloria è uno solo: tornare a correre. Perdere o vincere non ha importanza. Conta rimettersi sulla bicicletta. Faticare, sudare: i verbi dei veri uomini. Perché sono solo un uomo e non devo mai dimenticarlo. Soltanto i veri uomini non si fanno schiacciare dal successo.
Ho finito la stagione del Mondiale con altre vittorie, come quella al Giro del Lazio, con l’arrivo in volata presso l’arco di Costantino, e inizio la nuova con una rinnovata voglia. Ho ancora fame. Vengo da una famiglia di contadini: abbiamo conosciuto la fame vera, una medaglia d’oro sotto i denti non può certo saziarmi.
È una domenica d’aprile del 1978. La Pasqua è stata celebrata da tre settimane, ma oggi è giorno di morte o resurrezione. È giorno di Parigi-Roubaix. Dopo due secondi posti e un altro paio di partecipazioni sfortunate, voglio correre come se fosse l’ultima gara non della stagione, ma dell’intera carriera. Oggi o arrivo primo o piuttosto ultimo. O con lo scudo o sullo scudo, come dicevano le donne spartane ai loro uomini in partenza per la guerra. Mi ripeto lo stesso monito. Spenderò fino all’ultima goccia di sudore. Se non arrivo per primo al velodromo di Roubaix, sarà soltanto perché sarò crollato sul percorso.
Sento la gamba giusta e ho anche la necessaria dose di rabbia in corpo. Sono infatti arrivato secondo all’Amstel Gold Race di fine marzo perché Jan Raas, che correva in casa, si è fatto trainare spudoratamente da un’auto. Ho fatto il diavolo a quattro all’arrivo con gli organizzatori piuttosto imbarazzati, ma mi hanno risposto che da quelle parti funziona così. Allora ho detto loro che da quelle parti non mi vedranno mai più. Ho anche ottenuto il terzo posto alla Gand-Wevelgem, in una giornata di freddo siberiano, con la neve a imbiancare le spettacolari dune di sabbia che in certi tratti costellano il percorso. Soltanto la coalizione dei nordici mi ha impedito di strappare la vittoria. La Parigi-Roubaix, però, non conosce coalizioni, giochi di squadra, strategie o più o meno occulti favoritismi ai corridori di casa. È la corsa degli highlanders. Ne resterà soltanto uno.
Dopo aver visto i miei numeri tanto alla Amstel Gold Race quanto alla Gand-Wevelgem, Freddy Maertens, già campione del mondo, afferma: «Francesco vola. È il più forte. Stravincerà». Dall’Italia replica Saronni, fresco vincitore della Tirreno-Adriatico: «Il mio favorito è De Vlaeminck. Oppure un altro belga. Moser sarà con i primi, ma è difficile che vinca. Anche perché il suo compagno di squadra De Vlaeminck correrà per sé».
Saronni ancora non sa che alla Roubaix ognuno corre per sé. Lo scoprirà sulla propria pelle, e maledirà questa corsa. Qui non ci sono squadre. Solo uomini. E per vincere devi essere più uomo degli altri. Alla partenza ti fai il segno della croce. Nella migliore delle ipotesi, sarà una giornata terribile. Non sai nemmeno tu cosa augurarti: se c’è il sole, ti intossica la polvere; se piove, affondi nella melma. E tanto la polvere quanto il fango mascherano le buche. Sai che cadrai. Solo un paio di volte, se sarai fortunato. Se te la caverai con qualche escoriazione e un paio di lividi, potrai ringraziare il cielo. Le bici vanno equipaggiate come in guerra: tubolari trattati, imbottiture di gommapiuma dove possibile, forcelle rinforzate. Le salite sono brevi e fulminanti. In un chilometro rischi di beccare due minuti di distacco. Non c’è tratto in cui non possa scoppiare la battaglia: salti, schivi, rimbalzi, raddrizzi e salti, salti ancora. E mangi polvere e sputi fango…
Dalle mie parti si dice sempre che noi trentini abbiamo esportato soltanto due cose: preti e porfido. In mezzo al pavé ci sono nato. Ora è il momento di trionfarci.
Nevischia alla partenza. Poi si scatenano anche gli altri elementi: pioggia, sole e vento. Sembra che la natura voglia metterci alla prova, facendoci passare attraverso tutte le possibili condizioni atmosferiche, come se non bastasse già il terribile percorso, in una landa selvaggia segnata dalle antiche strade di pietra. Forature, cadute, abbandoni, crolli: la corsa si trasforma in una gara a eliminazione. All’apparire del pavé presso Neuvilly si scatena una lotta furibonda per imboccare quel tratto fra i primi. La foga costa cara. Due corridori si agganciano e in un istante metà gruppo si trova a terra in un groviglio di ruote, catene, gambe e braccia.
Insieme a Thurau, Kuiper e Pollentier aumentiamo il ritmo. È arrivato il pavé più selettivo, è ora di aprire le danze. Si scatena la bagarre in un susseguirsi di scatti, rincorse e contrattacchi. Alla fine restiamo in quattro: io, De Vlaeminck, Maertens e Raas. Siamo i più forti, abbiamo fatto la storia di questo sport negli ultimi anni, vincendo classiche e campionati del mondo. Ma adesso non conta nulla. Al collo non sfoggiamo medaglie, ma collane di fango. E abbiamo sangue negli occhi.
A ventidue chilometri dal traguardo scatto. Maertens e Raas tentano di venirmi a riprendere con De Vlaeminck a ruota, ma resisto. La mia progressione è di quelle che ti portano dritto in cielo. Senti di poter tutto in quei momenti di ebbrezza. Spingi sui pedali e la velocità è come quella del sangue. Vita, pulsi di vita. Sento di pedalare a un centimetro dal suolo. Il pavé è una lastra. Non temo di cadere o di forare. Dietro danno tutto per ricucire il distacco, ma questo cresce invece di diminuire. È come una magia. È il mistero del ciclismo: la matematica dice che dietro, alternandosi a tirare, dovrebbero guadagnare terreno, e invece lo perdono. Io viaggio spedito, un’ombra solitaria sospesa tra cielo e terra.
«Un uomo solo è al comando, la sua maglia è iridata, il nome è Francesco Moser» riferisce il telecronista interrompendo i programmi italiani. Una curva secca, una pozzanghera, ecco che rivivo l’incubo, ma è solo per un attimo. Mi specchio nell’acqua torbida. Indosso una maschera di fango. Faccio paura. Dai polpacci fino ai capelli sono incrostato di terra rappresa e polvere di carbone. La maglia iridata è chiazzata, ma i colori trovano ancora la forza di brillare. Volo sull’acqua e passo oltre.
Appena entro nel velodromo di Roubaix il pubblico schizza in piedi. I francesi mi hanno adottato. Mi applaudono, scandiscono il mio nome. Qualche tricolore spunta d’improvviso sulle tribune. Un nutrito drappello di italiani mi aspetta al di là della linea d’arrivo. Ci sono quelli della mia squadra, ma anche giornalisti e tifosi. Sono emozionati e pronti ad abbracciarmi. Sanson e Vannucci piangono lacrime di gioia e non sono i soli. Sto arrivando, amici. Sto arrivando. Alzo le braccia al cielo.
Ed è arcobaleno su Roubaix.
Arc-en-ciel sur Roubaix titola il giorno dopo «L’Équipe», con in prima pagina una foto gigantesca che mi ritrae mentre affronto il pavé con il volto rigato di fango. Roba da brividi. Il patron del Tour Jacques Goddet dichiara che ho fatto grande il ciclismo, mentre «Le Figaro» scrive: «È stato nettamente il migliore, come lo era stato alla Gand-Wevelgem, ma questa volta è riuscito a imporre la legge del più forte. Mai ordine di arrivo di una classica è stato meno contestabile». Ferruccio Berbenni sulla «Notte» chiosa: «Si è dimostrato un grande campione il trentino, perché ha vinto quando ha voluto e non quando si può. Come faceva Coppi. Come faceva Merckx. Come ha fatto Moser».
Mentre sfoglio i giornali penso che siamo a cavallo di un’epoca per il ciclismo. Ho sfidato e battuto alcuni degli imbattibili. Ho sfilato la corona dalla testa dei sovrani. Qualcuno ha anche scritto che Moser ne ha mandati in pensione molti, di mostri sacri. È una ruota che gira, e adesso io sono dalla parte di quelli da battere. Si cercano gli anti-Moser. Quando davanti al tuo cognome appare un «anti» significa che hai compiuto qualcosa di importante, qualcosa che ha lasciato il segno, che ha fatto venire voglia agli altri di prendere il tuo posto.
Individuato il protagonista del nuovo ciclismo italiano, bisogna subito scovare l’antagonista. Ci hanno provato prima con Battaglin, mio leale avversario già dai tempi dei dilettanti, ma Giovanni non si è ancora confermato nei professionisti. Poi hanno soffiato sulla rivalità con Baronchelli, ma Tista non è più riuscito a esprimersi sugli stessi livelli di quando arrivò secondo al Giro. Adesso è il turno di Beppe Saronni. Lui è ben felice di interpretare il ruolo. Capisce che il ciclismo è anche teatro, oltre che corsa. Dopo le punzecchiature dei primi tempi, firma una dichiarazione di guerra: «Non invidio Moser. So che posso batterlo, e poi è troppo diverso da me, troppo impulsivo».
Dice il vero, Saronni. Siamo molto diversi io e lui. Io credo che le sfide si affrontino unicamente sui pedali. Sono all’antica, non capisco le strategie da guerra fredda. Lui va forte con la bicicletta, ma è altrettanto rapido con la lingua. Cerca lo scontro, graffia, crede nel potere destabilizzante della pretattica. Conosce la mia indole e mi provoca con grande astuzia. Io rispondo a tono, spesso a caldo. Ho il brutto vizio di dire quello che penso. Mi accusano bonariamente di pensare ad alta voce, di dire verità non richieste. Del resto non conosco la diplomazia. E sono irruento. Se Beppe usa lo spillo, io spesso passo direttamente al forcone, da buon contadino.
Ai giornalisti non sembra vero: non credono alla propria fortuna sfacciata. Si divertono come bambini al parco giochi. L’opinione pubblica si divide, le vendite dei giornali raddoppiano. I risultati che sorridono ora a lui ora a me sorreggono il gioco. Era dai tempi di Coppi e Bartali che non si assisteva a un dualismo simile. Quando mi accorgo di essere caduto nella trappola, è ormai troppo tardi. Sono uscito quasi indenne dalla bocca del Cannibale, sopravvivrò anche a quella velenosa del buon Beppe.
Nel frattempo cominciano i problemi con Teofilo Sanson. Siamo amici, ma litighiamo come una coppia di innamorati. Siamo due vulcani sulla stessa isola, il minimo che possa capitare è una costante attività tellurica. Dopo l’abbandono delle corse da parte della gloriosa Brooklyn nel 1977, Teofilo ha deciso di ingaggiare De Vlaeminck e la colonia dei belgi che correvano per quel prestigioso team. Ha visto un’opportunità e ci si è tuffato spinto dall’istinto, con il consueto impeto. Pretende una squadra competitiva per vincere il Giro d’Italia e la Coppa del mondo a squadre.
«Il ciclismo va forte e tu vai fortissimo» mi ha rassicurato con la sua voce roca e i suoi modi esuberanti da trascinatore. «Ma c’è di più. Anche la mia azienda va alla grande, vendo più gelati di quelli che riesco a produrre. Tutto è perfetto. Mi manca solo un sogno: il Giro d’Italia. Abbiamo bisogno di un altro alfiere per proteggerti. Ogni anno gli altri big si alleano per farti perdere. Dobbiamo rintuzzare gli attacchi, circondarti di validi gregari. Abbiamo bisogno di una squadra.»
Io ero perplesso, anche se l’idea mi stuzzicava. Bartolozzi era favorevole. «Sei un campione, ma se vuoi diventare un campionissimo devi vincere almeno una grande corsa a tappe. È la regola non scritta del ciclismo. La squadra può aiutarti. I belgi sono forti di gamba, ma anche di testa. Possono garantirci quel quid di furbizia che spesso al Giro ci è mancata.»
Vannucci, invece, era fortemente contrario. Si era dato da fare in segreto per mettere sotto contratto De Muynck e Knudsen, che secondo lui sarebbero state due spalle ideali per me, ma alla fine aveva dovuto rinunciare. Sanson non conosce il significato della parola no. Vannucci non riesce a darsi pace. «Invece di rinforzarla, ha indebolito la squadra. De Vlaeminck non è un uomo da grandi giri, semmai di grande appetito: è uno che fa incetta di tappe e quando la strada inizia a salire saluta la compagnia. E soprattutto non è uno che possa calzare i panni del gregario, anche se solo occasionalmente. È nato cavaliere, e non sarà mai scudiero. Ha l’istinto del predatore, proprio come te. Non puoi fargli odorare una preda e poi dirgli che non è per lui.»
Roger De Vlaeminck, detto «il Gitano di Eeklo», è uno dei più grandi di tutti i tempi. Fenomenale su ogni terreno, è quasi insuperabile nelle gare di un giorno. Ci siamo sempre dati battaglia in corsa, pur rispettandoci, e ora vederlo al mio fianco mi fa una strana sensazione. È un uomo ombroso, indecifrabile, con i lunghi basettoni neri a incorniciare il volto affilato di bronzo: a volte si lascia andare a qualche manifestazione di stima e quasi di affetto, per poi chiudersi a riccio per lunghi periodi, interrotti solo da inaspettate dichiarazioni al vetriolo.
La scelta sembra vincente, specie al principio: in questi primi mesi del 1978 io ho portato a casa la Roubaix e De Vlaeminck la Milano-Sanremo. Il gioco di squadra sembra funzionare, per il bene di tutti e la soddisfazione di Sanson. Vannucci, però, non la vede allo stesso modo: «A volte sei ingenuo, Francesco. De Vlaeminck voleva portarti via a ogni costo la Parigi-Roubaix. Certo, non ha tirato quando era nel gruppetto degli inseguitori. Ma come avrebbe potuto? Avrebbe fatto una colossale figuraccia in diretta televisiva, eppure ha offerto soldi a Maertens perché tirasse lui. Uno sproposito di soldi. Non hai visto come si è dannato l’anima Maertens per venirti a prendere? Lo so per certo».
Le parole di Vannucci trovano conferma durante una corsa a tappe in Danimarca, dove vinco diverse frazioni mettendo una seria ipoteca sul successo finale. All’ultima tappa, però, De Vlaeminck va inaspettatamente in fuga. Poiché mi accorgo che non c’è nessuna reazione da parte del gruppo, faccio un po’ di domande e alla fine vengo a sapere che la sera prima Roger si è messo d’accordo di nascosto con gli avversari perché gli lasciassero via libera. Loro hanno acconsentito, ma io no. Così vado a riprenderlo da solo. Lo raggiungo, lo affianco e lo batto in volata conquistando tappa e giro. Siamo ottimi compagni io e Roger, soprattutto quando non disputiamo la stessa corsa.
Accantonata la questione della composizione della squadra, con Teofilo Sanson torniamo a discutere per la scelta delle biciclette. Un paio d’anni fa, insieme a mio fratello, dopo l’iniziale esperienza del negozio abbiamo deciso di aprire un’officina di biciclette a Gardolo, che nel frattempo si è ingrandita. Una vera e propria casa di produzione con il marchio Moser. È arrivato il momento di correre con le mie biciclette. Sanson prova in tutti i modi a farmi cambiare idea, ma questa volta non cedo.
Nel frattempo, sull’onda degli ultimi successi internazionali, scendo in pista a Follonica per sfidare Atollo. Non è un corridore, ma un cavallo. Una sfida singolare che vanta illustri precede...