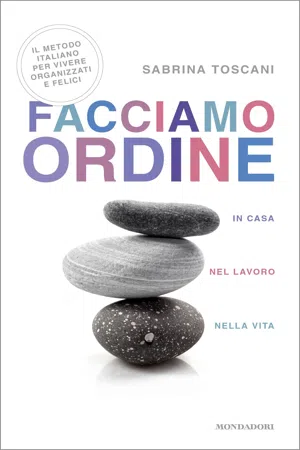IL PICCIONE VIAGGIATORE
Sono state prodotte più informazioni negli ultimi trent’anni che nei precedenti cinquemila.
Ricerca Jungwirth 2002
Nel Diciassettesimo secolo una persona doveva gestire, nel corso della propria vita, la quantità di informazioni che noi troviamo in una rivista settimanale. Il che la dice lunga sulla natura e la portata dei cambiamenti economici e sociali che caratterizzano la nostra epoca.
Ogni grande cambiamento a cui l’essere umano ha contribuito e assistito, dall’invenzione della scrittura alle attuali 1.217.230.684 pagine web (ma si tratta di una cifra in continuo aumento, il contatore online che monitora la crescita dei siti Web nel mondo – http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/ sembra impazzito), ha sempre suscitato lamentele e proteste, forti opposizioni e scenari catastrofici.
L’abbondanza di libri rappresenta una distrazione.
Seneca
Quest’orribile massa di libri che continua a crescere [...] porterà a un ritorno alla barbarie.
Gottfried Wilhelm von Leibniz
Noi tutti siamo consapevoli di quante opportunità questa realtà digitale ci offra; facciamo invece più fatica a renderci conto delle problematiche che ci pone. Se da un lato infatti l’abbondanza di informazioni e il desiderio innato nell’essere umano di averne sempre più vengono percepiti come fonte di maggior produttività, dall’altro, paradossalmente, sortiscono l’effetto opposto.
Ottenere un’informazione da Internet è come bere un bicchier d’acqua da un idrante.
Mitchell Kapor
Immaginando di essere in un altro momento storico, be’... è un po’ come se, in attesa di un messaggio recato da un piccione viaggiatore, fossimo investiti da un intero stormo di pennuti.
QUANTE VOLTE SUONA IL POSTINO?
Con un ulteriore sforzo di immaginazione facciamo ora un salto in un passato più recente: corre l’anno 1985, il tradizionale metodo per scambiarsi comunicazioni scritte è la lettera. Il postino ci consegna la posta una volta al giorno, noi svuotiamo la nostra cassetta, apriamo le buste, ne leggiamo il contenuto e decidiamo cosa farne. Se il postino suona una seconda volta, riceviamo e ringraziamo. A un eventuale terzo squillo la nostra disponibilità nei confronti del buon uomo comincia a scemare, sicuramente non reggiamo a un quarto trillo e provvediamo a chiudere, più o meno garbatamente, la relazione.
Anno 2015, ore 8.30 di una giornata lavorativa. Accendo il PC, lancio Outlook, scarico la posta e do una rapida occhiata a tutto. Cerco di elaborare qualche messaggio per portarmi avanti, poi però mi devo buttare su una pratica urgente. Dopo qualche secondo sento la notifica dell’arrivo di una email. Controllo, niente di importante. Passano cinque minuti e compare di nuovo la bustina di Outlook: altro messaggio, corro a vedere. E così trascorre tutta la mattina, fra notifiche e interruzioni, senza che mi venga in mente nemmeno per un momento di mandare a quel paese Outlook. E allora perché il postino ci fa così innervosire e invece il client di posta ne esce indenne, pur essendo molto più insistente?
Studiosi di ogni parte del mondo stanno analizzando il fenomeno della posta elettronica che ha rivoluzionato, nel bene e nel male, il nostro modo di comunicare.
Il primo dato rilevante è che mediamente trascorriamo il 28 per cento della giornata lavorativa nel nostro inbox, per un totale di 13 ore a settimana. Secondo un calcolo spannometrico, in un anno sono circa 470 le ore dedicate a lettura ed elaborazione di messaggi elettronici: non poco, vero?
All’arrivo di una notifica, la media degli utenti risponde dando un’occhiata entro sei secondi, e con tempi di reazione più ristretti di quando risponde al telefono.
Una volta controllata la posta, tuttavia, non sempre intraprendiamo immediatamente delle azioni relative a ciò che abbiamo ricevuto; anzi, a quanto sembra, nella maggior parte dei casi torniamo subito a ciò che stavamo facendo prima dell’interruzione. Il che non sarebbe nemmeno così grave se non fosse stato provato che di media ci servono 64 secondi per concentrarci di nuovo e appieno sulla nostra attività. Una persona che riceve circa quaranta email al giorno e le consulta più o meno ogni cinque minuti rischia quindi di sprecare otto ore e mezzo a settimana solo per “tornare sul pezzo” e riprendere il filo di ciò che stava facendo.
SIAMO TUTTI LAVORATORI DELLA CONOSCENZA?
Peter Drucker, economista e saggista austriaco ma naturalizzato statunitense, utilizzò per primo, nel 1959, il termine knowledge worker per definire un lavoratore il cui capitale principale è la conoscenza. In questa categoria includeva ingegneri, dottori, architetti, scienziati, avvocati, insegnanti e tutti coloro che “pensano per vivere”. Da allora, la quantità di “lavoratori della conoscenza” è andata continuamente aumentando e oggi sono sempre meno i lavori “tradizionali”, nei quali non è necessario impiegare e accrescere le proprie conoscenze, per così dire, cognitive. Anche un contadino non può più limitarsi a piantare e raccogliere le sue patate, curandone la produzione e la qualità, poiché è probabile che, per poter stare sul mercato, sopravvivere e prosperare, debba costantemente imparare anche altro (per esempio la coltivazione biologica o la vendita online).
È ancora aperto il dibattito per definire chi sia un lavoratore della conoscenza e chi no, lasciamo quindi la soluzione agli esperti. Ciò che ci interessa sapere è che il knowledge work ha delle caratteristiche molto diverse dal lavoro tradizionale.
I confini delle mansioni, per esempio, non sono prestabiliti, ma flessibili e soggetti a una continua revisione; i cambiamenti, repentini e all’ordine del giorno, rendono sempre più difficile definire degli obiettivi precisi e valutare la qualità dei risultati; l’utilizzo delle informazioni, che non solo sono risorse necessarie per lavorare ma spesso costituiscono anche il risultato del lavoro stesso, è di vitale importanza.
Questi fattori incidono sulla qualità della vita del lavoratore che è sempre più soggetto a burnout, cioè a uno stato di esaurimento delle energie, mancanza di motivazione ed entusiasmo, frustrazione e altre emozioni spiacevoli a causa di uno stress eccessivo e prolungato. Anche senza arrivare al burnout, però, molti di noi rischiano quotidianamente di oltrepassare la soglia dello stress, diciamo così, fisiologico.
PERSONA IMPEGNATA, PERSONA IMPORTANTE
La mentalità prevalente oggi è che essere molto occupati costituisca già di per sé un ottimo biglietto da visita. E così tutti cerchiamo di adeguarci. È molto diffusa, infatti, la convinzione secondo cui una persona molto impegnata è anche molto importante. Vedendo qualcuno sempre affaccendato siamo portati a pensare che abbia successo e ad attribuirgli dei meriti. Spesso del tutto infondati.
Ma la persona che porta a termine un incarico in un’ora non risulta per forza “perdente” rispetto a una che ne impiega cinque, poiché si deve valutare il risultato non il numero di ore impiegate. Inoltre, la persona molto richiesta non necessariamente è molto brava, anzi, forse è vero il contrario. La fila fuori dal suo ufficio (fisico o virtuale) è spesso composta da gente che sta attendendo da troppo tempo una risposta, ha ricevuto un riscontro parziale o non sufficientemente chiaro, oppure non riesce mai a parlare con lei. Elementi non molto positivi. Infine, sapere come impiegare bene il tempo è una delle competenze più importanti che si possono acquisire nella vita. Non averla non è un merito.
Quindi liberiamoci dal falso mito che essere sommersi dalle cose da fare abbia automaticamente un valore positivo e diamo spazio solo agli impegni che davvero meritano il nostro tempo.
Quello che fai oggi è importante perché stai investendo un giorno della tua vita per farlo.
Anonimo
TUTTI A SCUOLA?
Secondo studi americani solo una percentuale compresa tra il 10 e il 12 per cento della popolazione mondiale possiede la capacità innata di essere organizzato. L’altro 88-90 per cento, pur avendo molti altri talenti, non ha una particolare propensione per l’organizzazione. Il rischio è che le altre abilità vengano travolte da confusione e disorganizzazione o che non emergano come potrebbero non ricevendo lo spazio, il tempo e l’energia che meritano. Un vero peccato.
Perché quindi non insegnare l’organizzazione personale? È una materia utile in qualunque contesto, propedeutica a ogni attività, la base per qualsiasi progetto, piccolo o grande, privato o professionale.
Forse proprio perché si tratta di un fatto così basilare, viene dato per scontato che tutti sappiano gestirsi come vogliono, in qualunque contesto, in qualsiasi momento. Ma con i rapidi cambiamenti cui abbiamo accennato, il volume di informazioni che ci bombarda, la massa di oggetti che ci circonda, il numero di impegni che riempie il nostro tempo, diventa ancora più importante crearsi una solida base di strategie organizzative e metodi pratici, che ci supportino nel corso delle nostre giornate.
L’organizzazione personale è un po’ come una lingua straniera; si imparano i fondamenti, poi a poco a poco si costruiscono delle frasi fino ad arrivare a interi periodi. Necessita di un metodo di apprendimento che consenta di porre in campo talenti e abilità: si prendono i concetti base e piano piano si mettono in pratica, fino a costruire un proprio linguaggio. Esattamente come una lingua, se l’organizzazione personale venisse insegnata con metodo fin da piccoli sarebbe tutto più facile, se ne farebbe uso nella vita di tutti i giorni senza nessuno sforzo.
Proprio questo metodo è suggerito nel presente libro.
GLI ANTENATI E LE EMOZIONI
Se è vero che le emozioni ci hanno guidato con saggezza nel lungo cammino dell’evoluzione, è altrettanto vero che le nuove realtà legate alla civilizzazione sono sorte così velocemente che l’evoluzione – un processo molto più lento – non può più tener loro dietro. [...] Troppo spesso ci capita di dover affrontare dilemmi postmoderni con un repertorio emozionale adatto alle esigenze del Pleistocene.
Daniel Goleman
La parola “emozione” deriva dal latino moveo, che significa “muovere”, con l’aggiunta del prefisso “e” (movimento da) a indicare che in ogni emozione è implicita la tendenza ad agire. E, infatti, tutte le emozioni sono impulsi ad agire: reazioni istintive di cui ci ha dotato l’evoluzione per gestire le emergenze della vita.
Le emozioni, però, non sono così importanti solo perché si sono rivelate vitali per la nostra sopravvivenza; lo sono anche perché i centri emozionali hanno l’immenso potere di influenzare il funzionamento di tutte le altre aree del cervello.
Le neuroscienze, oggi, annettono molta importanza alle emozioni, sottolineando quale ruolo rivestano nel nostro vivere quotidiano, quale incidenza abbiano sulla nostra qualità di vita e quanto importante sia saperle riconoscere e imparare a gestirle. Come sintetizza John Medina (Il cervello. Istruzioni per l’uso), “il successo dipende interamente dallo stato emotivo”.
Abbiamo creato ambienti di lavoro d’ufficio molto stressanti, anche se un cervello stressato è notevolmente ...