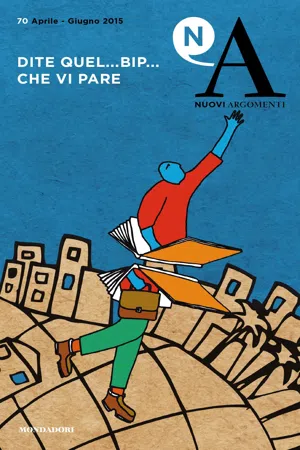Questionario
- La libertà d’espressione deve tener conto di altre libertà (per esempio legate a: religione, credo politico, ruoli istituzionali, memoria storica, ecc.) o non deve essere limitata? Quali dovrebbero essere gli eventuali limiti e chi dovrebbe deciderli?
- Rappresentazione artistica e opinione personale dovrebbero godere dello stesso grado di libertà di espressione?
- Dovrebbe essere diversa la libertà d’espressione di cui si può usufruire in ambito pubblico e in ambito privato? Perché?
- È giusto limitare la libertà di un cittadino di esporre o indossare simboli religiosi, politici, ecc.? Se sì, in che misura?
- Chi difende o appoggia pubblicamente atti violenti o illegali dovrebbe esserne considerato corresponsabile sotto un profilo etico e giuridico, o dovrebbe avere diritto a esprimere liberamente la propria convinzione?
- Si può ricorrere alla violenza fisica per l’affermazione di un ideale? Quali sono, se ci sono, i valori per la cui difesa varrebbe la pena ricorrere alla violenza o sacrificare la propria vita?
- I valori della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 sono assoluti e universali o tutto è soggetto alla storia e non esistono valori indiscutibili?
- Si può dire che è in atto uno scontro fra due o più civiltà diverse e inconciliabili? E se sì, quali sono le cause di questo scontro (culturali, religiose, politiche, economiche, ecc.)?
- È possibile mettere a confronto e stabilire quale sia il migliore tra sistemi di valori di differenti civiltà?
- Qual è lo stato della libertà di espressione in Italia? Ci sono argomenti tabù su cui risulta difficile o impossibile esprimersi liberamente?
Autori
Fulvio Abbate
Eraldo Affinati
Alessandro Agostinelli
Massimo Arcangeli
Federico Audisio di Somma
Alberto Bertoni
Filippo Bologna
Carlo Bordini
Maria Borio
Franco Buffoni
Laura Buffoni
Errico Buonanno
Maria Grazia Calandrone
Mario Capello
Aldo Cazzullo
Mauro Covacich
Marco Cubeddu
Giancarlo De Cataldo
Roberto Deidier
Erri De Luca
Fabio Deotto
Paolo Di Paolo
Simona Dolce
Giuliano Ferrara
Biancamaria Frabotta
Gabriele Frasca
Stefano Gallerani
Attilio Giordano
Arnaldo Greco
Andrea Inglese
Stefano Jossa
Andrea Kerbaker
Raffaele La Capria
Nicola Lagioia
Marina Lalovic
Camillo Langone
Antonella Lattanzi
Loredana Lipperini
Giancarlo Liviano D’Arcangelo
Gaja Lombardi Cenciarelli
Francesco Longo
Federica Manzon
Paola Mastrocola
Marco Missiroli
Antonio Monda
Raul Montanari
Italo Moscati
Giulio Mozzi
Edoardo Nesi
Piergiorgio Odifreddi
Vincenzo Ostuni
Massimiliano Parente
Sandra Petrignani
Gabriele Pedullà
Stefano Petrocchi
Aurelio Picca
Veronica Raimo
Elisabetta Rasy
Gianni Riotta
Mario Santagostini
Simonetta Sciandivasci
Gian Paolo Serino
Giulio Silvano
Walter Siti
Italo Testa
Filippo Tuena
Patrizia Valduga
Giorgio van Straten
Paolo Valesio
Mariapia Veladiano
Gian Mario Villalta
Alessandro Zaccuri
Giorgio Zanchini
Fulvio Abbate
1. Sogno l’abolizione delle religioni. La memoria è semmai fantasia, non dogma. Gli orfani d’ogni credo ripieghino sul modellismo. Sia aeronavale sia automobilistico. Costruire il Bounty, per esempio, è meglio di leggere la Bibbia.
2. Affermava Lev Trotskij, ossia il fondatore dell’Armata rossa: «Anche quando serve la rivoluzione, la creazione artistica obbedisce a leggi proprie». Se lo diceva lui.
3. La libertà di espressione è una scelta di libertà, non di opportunità. Punto.
4. Comincio a pensare che andrebbe proibito il chador, oppure esteso anche agli uomini. Vuoi farti un altare? Bene, fattelo in casa, privatamente: dopo l’angolo-cottura e l’angolo-bagno, ecco anche l’angolo-altare.
5. Esiste l’apologia di reato. Si può discutere sulla sua legittimità o meno.
6. La violenza è inaccettabile. Il pensiero razionale ha l’obbligo del pacifismo.
7. Sì, ma basterebbe non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te.
8. Sì, se ti ritengo un idiota rinuncio a misurarmi con te. Pensiamo ai nostri dirimpettai, alla miseria condominiale.
9. Il relativismo culturale non può giustificare tutto l’orrore poiché anche gli sfruttati sovente, come ha spiegato Albert Camus, sono culturalmente ottusi. Mi fa orrore ciò che pensano in certi centri sociali occupati.
10. Potrebbe cominciare il nostro governo, per decreto, ad abolire la religione. Vi sembra un paradosso? Non lo è, in ogni caso lo scrittore ha diritto al paradosso e all’assurdo, altrimenti si è mediocri politici come i sostenitori della “Vocazione maggioritaria”. In caso contrario è inutile perfino citare Charlie Hebdo e Wolinski che hanno creduto in una satira che colpisse dio patria famiglia e perfino gli handicappati.
Eraldo Affinati
1. Credo che il vero senso della libertà non sia il superamento del limite, bensì la sua accettazione, pena il delirio, lo smarrimento, l’ebbrezza. Solo nel momento in cui dobbiamo misurare i passi del nostro cammino, possiamo apprezzare l’energia che sprigiona da essi e comprendere la vastità del territorio, interiore e esteriore, che attraversiamo. Essere consapevoli dell’impossibilità di un controllo assoluto sulla stessa direzione da prendere, ci spinge a cercare mappe, genealogie, tradizioni. I muri sono fatti per essere picconati, scavalcati, distrutti, ma dopo bisogna ricostruire il paesaggio, imparare le lingue necessarie a comunicare, scrivere le leggi del patto sociale senza le quali l’incontro fra gli uomini sarebbe simile a quello di due animali nella radura di un bosco.
2. Entrambe, in quanto frutto del pensiero umano, sono legate alla responsabilità. La libertà artistica non può essere determinata dai codici, tuttavia chiunque crei un’opera o esprima un concetto, è chiamato a renderne testimonianza e, nel caso in cui commettesse un danno, dovrebbe pagare il prezzo del risarcimento. La cultura del ventesimo secolo ha spesso mitizzato la libertà trasformandola in un feticcio.
3. È una differenza di scala. Non ontologica. La libertà privata assomiglia al pezzo unico. Quella pubblica possiede una dimensione industriale.
4. Non credo sia giusto. Storicamente è stato spesso inevitabile. La misura è un’invenzione umana, quindi varia nel tempo e nello spazio. Si tratta di un accordo provvisorio destinato a essere sempre rinegoziato.
5. Per quanto riguarda il punto di vista giuridico, rimando alle risposte precedenti. Bibliografia classica: Hobbes, Machiavelli. Eticamente il discorso cambia e riguarda le poetiche individuali, gli alibi interiori, insomma le maschere. Ciò che conta sono le nostre motivazioni: cioè il desiderio che ci guida. Su quello dovremmo appuntare la riflessione.
6. Tutti rispondiamo alla violenza rivolta contro noi stessi: si chiama legittima difesa. Più difficile è intervenire quando vediamo oltraggiato un principio nel quale crediamo. Sarebbe impossibile assumere su di sé l’ingiustizia del mondo, ma se non sentissimo il peso della nostra insufficienza come una spina nel fianco, passeremmo indifferenti di fronte alle peggiori nefandezze. Per capire quali siano i valori da difendere a qualsiasi costo dovremmo interrogarci sul bene e sul male. Dai dieci comandamenti in poi l’uomo ha cercato di definire queste categorie che a volte ci sembrano astratte, oppure obsolete. Io però lavoro con adolescenti provenienti da tutto il mondo e vedo che essi, pur parlando lingue diverse, s’intendono ancora su queste vecchie basi.
7. Quei principi, sacrosanti, sono l’ultimo anello di una lunga catena. Valori da rispettare, sui quali l’uomo si è messo d’accordo. Non una volta per tutte. Piuttosto: qui e ora.
8. Credo sia in atto uno scontro fra mondo antico e mondo moderno. Dietro questa tensione possiamo scoprire, a stento celato, il vecchio fossato fra chi ha e chi non ha. Sono quindi propenso a privilegiare il fattore economico su quello religioso che quasi sempre viene strumentalizzato.
9. Mettere a confronto sì. Stabilire quale sia il migliore no. Non dovremmo delegittimare la scelta dell’uno o dell’altro, bensì cercare territori comuni per intendersi. Piattaforme universali. C’è un lavoro umano da compiere.
10. Scriviamo Italia ma intendiamo Europa, mondo occidentale, torretta del pianeta, di cui noi siamo soltanto una piccola provincia. Stiamo vivendo la rivoluzione informatica. Rispetto a tale evidenza il concetto di libertà d’espressione assomiglia a una pista in disuso. Pura archeologia novecentesca. Sono saltate le vecchie categorie ermeneutiche. La percezione della realtà è cambiata. La certificazione dei valori estetici sembra scaduta. La quantità ha vinto sulla qualità. Le gerarchie culturali paiono superate. Esistono grandi talenti che, con tutta la libertà possibile, non hanno più luoghi espressivi. Opere che pochi vedono. Linguaggi non condivisi. La vegetazione è stravolta. Si tratta della condizione ideale per un artista.
Alessandro Agostinelli
1. Se disegno una vignetta contro Allah in un paese islamico probabilmente contravvengo a un profondo comune sentire, se non addirittura a una legge coranica (laddove vige la sharia). Mentre se questa vignetta la disegno in un paese europeo le norme e il comune sentire modificano la prospettiva della mia azione espressiva. Così come una svastica disegnata sopra un manifesto in India è molto diversa da una svastica tracciata con lo spray sopra la sinagoga di Cracovia.
Il problema è quando si vuole imporre, in un paese diverso dal nostro, i propri parametri culturali, religiosi, sociali.
Le leggi vigenti in un paese, di solito, indicano i limiti e sono termini di paragone delle libertà personali di ciascun cittadino di quel paese. E anche gli ospiti è conveniente che si adeguino a quelle norme.
Tuttavia esistono anche quelli che definirei “simboli sensibili”. Sono simboli che per i loro adepti o sostenitori obbligano chiunque al rispetto. E qui entriamo nella sfera della fede, della convinzione apodittica delle proprie ragioni. In questo livello cognitivo di rappresentazione del mondo il dubbio non ha luogo. E quindi c’è la patologia sociale dei tifosi di una curva dello stadio che obbligano i propri giocatori a togliersi la maglia della squadra perché non vincono e quindi non la onorano a dovere, ma c’è anche la follia di chi decide di lapidare e bruciare una ragazza accusata di aver offeso il Corano. Queste due azioni riguardano entrambe un “simbolo sensibile” che determina, nella mente di chi agisce (spesso collettivamente), un solco invalicabile. Si tratta di un solco che però mette a repentaglio due cose a mio parere più importanti del simbolo stesso: la dignità della persona e la tutela della vita umana.
2. Che legami ci sono tra La nona ora, la scultura di Maurizio Cattelan che ritrae papa Wojtyla colpito da un meteorite, e la recentissima dichiarazione della moglie del leghista Roberto Calderoli contro le vittime italiane dell’attacco jihadista a Tunisi, colpevoli – a suo dire – di sottovalutare il rischio Islam? L’unico legame è che entrambe possono aver offeso qualcuno. Ma solo questo. L’arte sublima anche l’offesa, la critica o lo sberleffo, mentre la chiacchiera (oggi ritenuta anche “opinione”) da bar, da talk show televisivo o da piazza digitale di Facebook non sublima un bel niente, resta soltanto un’offesa.
Si può biasimare quanto si vuole Ezra Pound per il suo antisionismo, ma ciò non mette in discussione la sua primaria grandezza di scrittore e poeta e l’autorevolezza delle sue opere letterarie. Si possono usare le feci umane per imbrattare la facciata di una chiesa, oppure inscatolarle come Merda d’artista, producendo così un corto circuito di senso di grande rilievo artistico, come fece Piero Manzoni.
3. Il diritto a una separazione tra sfera pubblica e privata dovrebbe essere esercitato con massima cura da parte di ciascun individuo. Cioè, ognuno di noi dovrebbe essere geloso del proprio privato. Ma oggi il privato deborda nella piazza digitale dei social network e spesso un pensiero lanciato in rete da un momento di riflessione privata diventa immediatamente pubblico, con grande detrimento della privacy. Non posso essere in pubblico ciò che sono in privato: sarebbe sconveniente e poco dignitoso per entrambi i ruoli. E quindi intendo sia il pubblico come il luogo del discorso pubblico che dovrebbe essere preservato da irricevibili pensieri privati, sia il privato come lo spazio vitale che va curato dall’ingerenza della sfera pubblica.
Alla fine del Seicento, in Europa, la religione aveva un potere enorme sulle persone, quanto non si può capire oggi se non guardando alle azioni contro i sudditi (musulmani sciiti e kafiri, cioè infedeli) del Califfato islamico di al-Baghdadi nelle città che egli governa in Medio Oriente.
Nonostante la forte ingressione del potere religioso e politico nella sfera personale dei sudditi, nel 1670 il filosofo Spinoza scriveva nel Tractatus theologicus-politicus: «Nessuno può essere costretto a trasferire ad altri il proprio naturale diritto, e cioè la propria facoltà di ragionare liberamente e di esprimere il proprio giudizio intorno a qualunque cosa. Ne viene di conseguenza che si giudica violento quel potere che si esercita sulle coscienze».
4. Direi che in questo caso è utile il concetto espresso da Kant: «la mia libertà esterna deve essere definita piuttosto in questo modo: essa è la facoltà di obbedire a nessun’altra legge esterna se non a quelle leggi a cui ho potuto dare il mio consenso».
5. In un mondo ideale, dove ogni individuo è responsabile delle sue azioni e conduce la sua vita secondo un ordine morale condiviso, ognuno dovrebbe poter esprimere il proprio pensiero. Tuttavia viviamo nel flusso contingente dell’energia vitale ed è difficile non circoscrivere i termini dell’agire nel campo del discorso pubblico.
È ancora Spinoza, sempre nel Tractatus, a scrivere che «ciò che non può essere vietato deve essere necessariamente permesso, per quanto danno ne derivi». Tuttavia ci sono delle fattispecie – come si dice – che devono metterci in guardia da un permessivismo acritico come da rigide restrizioni. E credo che le leggi vigenti in Europa siano sufficienti a normare la maggior parte dei casi. È chiaro che, se esprimo la mia solidarietà a chi fuma uno spinello e finisce in galera per questo, mi comporto molto diversamente da chi appoggia o favorisce lo spaccio di sostanze stupefacenti; così come è diversa la posizione tra chi sostiene e appoggia pubblicamente il diritto all’eutanasia di un malato terminale da chi difende e giustifica un marito che ha ucciso la moglie dopo anni di maltrattamenti.
6. Sì è sempre ricorsi alla violenza fisica per l’affermazione di ideali o di interessi. La storia dell’umanità è una lunga sfilata di conflitti, scontri, violenze. Non saprei dire quali siano i valori per cui vale la pena sacrificare la propria vita, e forse potrei ricorrere alla violenza per difendermi da un’aggressione. Ma credo che nel nostro tempo servirebbe soprattutto che in alcune zone del mondo si potesse passare dal significato letterale al linguaggio figurato. Tzvetan Todorov nel libro La conquista dell’America racconta che gli amerindi intendevano “mettersi nella pelle dell’altro” letteralmente, cioè scuoiavano l’altro e si coprivano il corpo con la sua pelle.
Ecco ho paura che ancora oggi, nell’anno 1435 circa del calendario islamico, qualcuno prenda troppo alla lettera discorsi di guerra e di lotta agli infedeli. Servirebbe un passaggio convinto all’uso del linguaggio metaforico. E in questo cultura, educazione, letteratura hanno molto da dire.
7. Certo la Dichiarazione universale dei diritti umani è un punto alto della storia della consapevolezza umana, che però è arrivata soltanto alla fine di una delle guerre più devastanti per il mondo intero. E servirebbe certo un passo avanti anche sui diritti universali del pianeta Terra, flora e fauna compresa. Ma i diritti umani non possono essere imposti ex-abrupto con la violenza, laddove non c’è stato un percorso verso quella dimensione del diritto che ritiene l’essere umano un valore.
Certamente anche le tre religioni del Libro hanno elementi di mis...