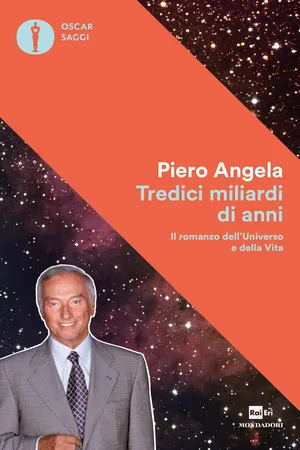IL BIG BANG
Da dove cominciamo?
Dal punto zero, naturalmente; che, secondo gli ultimi calcoli, dovrebbe risalire a circa 13 miliardi e 700 milioni di anni fa.
Quando è avvenuto il famoso Big Bang...
Questa è la teoria più diffusa: si pensa che in quel punto esistesse una concentrazione di energia inimmaginabile, e che si sia verificata una grande “esplosione”.
Oggi, però, è più che una teoria...
Sì, ma nella scienza c’è sempre la tendenza a essere prudenti, con il linguaggio.
Ci sono però varie prove che ciò sia avvenuto.
Come lei sa, la prima osservazione rivelatrice, da cui tutto è partito, fu quella fatta dall’astronomo Edwin Hubble, alla fine degli anni Venti, quando osservando il cielo si accorse che nelle galassie si verificava quello che si potrebbe definire oggi “l’effetto ambulanza” (l’effetto Doppler).
Cioè quella distorsione del suono che percepiamo quando un’ambulanza ci passa velocemente davanti?
Sì, anche con la luce avviene qualcosa di analogo. Per il suono, come è noto, ciò è dovuto al fatto che le onde sonore ci arrivano “compresse”, oppure “dilatate”, a causa della velocità di avvicinamento (o allontanamento) dell’ambulanza, e quindi le percepiamo come frequenze diverse. Per le galassie questo stesso effetto è provocato dalla “compressione” o “dilatazione” delle onde luminose. Se una luce si avvicina tende a diventare blu, se si allontana rossa.
E Hubble cosa scoprì?
Scoprì che la luce delle galassie di Andromeda e del Gruppo Locale (ma anche di tutte le galassie) tendeva al rosso. Quindi si stavano velocemente allontanando le une dalle altre, in tutte le direzioni. Proprio come avviene dopo un’esplosione.
Quindi l’Universo si stava espandendo, come un palloncino che si gonfia.
Sì, e da qui nacque l’idea che poteva esserci stato un Big Bang iniziale. Perché, invertendo il movimento come in un’immaginaria moviola, si vedrebbero le galassie tornare indietro e convergere tutte verso uno stesso punto, un punto iniziale a densità e a temperatura infinite, da cui tutto sembra essere partito.
Il punto zero.
La “singolarità”, la definiscono gli scienziati. Cioè qualcosa di unico, fuori dalle nostre regole abituali.
In quel punto, cosa c’era?
Non lo sappiamo. È come se, risalendo un cunicolo, non riuscissimo ad aprire l’ultima porticina. Andando indietro nel tempo, infatti, le nostre conoscenze si fermano a una frazione di secondo dal Big Bang, una frazione straordinariamente piccola: un decimilionesimo di miliardesimi, di miliardesimi, di miliardesimi, di miliardesimi di secondo! Al di là non riusciamo a spingerci. Ed è proprio al di là di questo “muro” sottilissimo, ma per noi insuperabile (almeno per ora), che si sono formate, secondo gli esperti, le caratteristiche fondamentali del nostro Universo: lo spazio, il tempo e la forza di gravità.
Tutto questo in un istante! E subito dopo, cosa avremmo visto?
Se vuole, glielo posso raccontare, ma questa prima parte della storia è davvero un po’ complicata (e basata su ipotesi).
I PRIMI MINUTI
Non si preoccupi...
Be’, avremmo visto un nucleo iniziale di Universo con una densità e una temperatura altissime: miliardi di miliardi di miliardi di gradi. Un nucleo che, in quella fase, si espandeva a una velocità pazzesca: addirittura superiore a quella della luce. Secondo certi calcoli, infatti, in poche frazioni di secondo l’Universo sarebbe passato dalle dimensioni di un atomo a quelle dell’intera galassia. È una transizione che i fisici chiamano “inflazione”.
Albert Einstein, però, ci ha insegnato che niente può viaggiare più veloce della luce: l’Universo, allora, nella fase iniziale se n’è infischiato della teoria della relatività?
È vero: se si pensa che oggi per attraversare la nostra galassia, da un punto all’altro alla velocità della luce, occorrono circa 100mila anni, la domanda è: com’è possibile che l’Universo si sia espanso dalle dimensioni di un atomo a quelle della galassia in una frazione di secondo?
E la risposta?
La risposta è che, in effetti, dentro lo spazio niente può viaggiare più velocemente della luce: ma in questo caso era lo spazio stesso che si espandeva, e quindi i “limiti di velocità” stabiliti da Einstein non erano validi.
In proposito bisogna rendersi conto che le attuali leggi della fisica non sono applicabili a una situazione così diversa. È anche questa una delle difficoltà per gli scienziati che cercano di decifrare ciò che è avvenuto alle origini.
E quello che è avvenuto prima del Big Bang?
Questo rimane un grande mistero. Torneremo più tardi sull’argomento.
Ma c’è anche un’altra cosa che per noi è difficile da concepire: il fatto che in quel momento iniziale siano nati lo spazio e il tempo. Come si può immaginare che lo spazio prima non esistesse? E, ancor più, che il tempo non esistesse? Il tempo a noi sembra essere un’entità immateriale, che esiste indipendentemente dal fatto che ci sia un Universo oppure no...
È vero. Abbiamo difficoltà a comprendere questi concetti. Il nulla, per esempio, ce lo possiamo al massimo immaginare come qualcosa di buio e vuoto; ma questo rappresenterebbe già uno spazio, mentre è proprio lo spazio (qualunque tipo di spazio) che non esisteva prima del Big Bang. Anche per il tempo vale lo stesso discorso: l’idea che ne abbiamo nasce dalla nostra mente, ma la nostra mente fa parte del sistema, non riesce a uscirne. È un po’ come per i pesci, che vivono confinati sott’acqua e non possono conoscere quello che c’è fuori, e tantomeno esplorarlo.
Va anche detto che lo spazio e il tempo, che noi percepiamo come separati, sono in realtà intimamente collegati tra loro in quello che viene definito lo spazio-tempo.
Come le due facce di una stessa moneta?
Sì, o come la pressione e la temperatura di un gas; sono cose diverse (e si possono misurare separatamente), ma in realtà sono intimamente collegate. Se varia una, varia anche l’altra.
Ed è questo collegamento tra spazio e tempo all’origine di quel famoso fenomeno per cui, secondo la teoria della relatività, se si viaggia a velocità vicine a quelle della luce il tempo si dilata e lo spazio si contrae?
Questo, in realtà, avviene a qualunque velocità, anche se si va in bicicletta, ma, in effetti, se si viaggiasse a quelle velocità estreme lo si percepirebbe molto chiaramente.
Infatti, se un veicolo, per ipotesi, cercasse di avvicinarsi alla velocità della luce, il tempo per chi è a bordo scorrerebbe sempre più lentamente rispetto a chi sta a terra, fino a fermarsi.
È il paradosso degli astronauti gemelli: dopo un viaggio a velocità prossime a quella della luce, un astronauta tornando sulla Terra troverebbe il suo gemello invecchiato, perché il tempo è passato in modo diverso per ognuno dei due. Ma c’è qualche prova che questo sia vero?
Sono stati fatti esperimenti, sistemando a bordo di satelliti degli orologi di estrema precisione: una volta rientrati, sono stati confrontati con analoghi orologi rimasti a terra. Effettivamente si è osservato che gli orologi a bordo del satellite avevano funzionato un po’ più lentamente. La differenza era poca, perché un satellite viaggia a una velocità molto ridotta rispetto a quella della luce (circa 40mila chilometri l’ora contro 300mila chilometri al secondo). Però l’effetto si era verificato, e corrispondeva alle previsioni della teoria della relatività.
L’ANTIMATERIA
La nascita dello spazio-tempo avviene dunque immediatamente, con il Big Bang. E intanto l’Universo conosce un’espansione rapidissima. In questi primi secondi cos’altro succede?
Ecco quello che si pensa sia successo. Dopo un centesimo di secondo, la temperatura è ancora sopra i 100 miliardi di gradi. Ma l’Universo è ora un brodo di quark (cioè dei mattoni fondamentali che compongono il nucleo degli atomi) e di leptoni (cioè di particelle leggere, come elettroni e neutrini).
È un po’ come un gioco di montaggio, dove i primi ad apparire sono i mattoncini più piccoli.
Sì, ma con una complicazione.
Quale?
Prima di continuare nel discorso, occorre fare una precisazione. Perché è effettivamente in questi primi istanti che comincia a formarsi la materia che oggi pervade l’Universo. Ma è anche in quel momento che si forma l’antimateria.
Vogliamo spiegare cos’è esattamente l’antimateria?
La stessa cosa della materia, ma con cariche elettriche invertite (e ci sono anche altre caratteristiche “quantistiche” che si invertono).
Cioè?
Se si prende per esempio un atomo semplice, quello dell’idrogeno, sappiamo che esso è composto da un protone e da un elettrone che gli gira intorno. Nel nostro mondo, il protone possiede una carica elettrica positiva e l’elettrone negativa.
Invece per l’antimateria è il contrario?
Esattamente: l’antiatomo di idrogeno possiede un protone negativo e un elettrone positivo (o positrone, come viene chiamato). Quindi è un atomo in apparenza uguale, ma intimamente diverso.
Ce n’era tanta di questa antimateria alle origini?
Tantissima, sembra.
E dove è andata a finire?
Questo è un mistero. Bisogna partire dal fatto che materia e antimateria, venendo a contatto, si annullarono, trasformandosi in pura energia. Ancora oggi sarebbe così.
Cioè, se io fossi fatto di materia e lei di antimateria, e ci dessimo la mano, cosa succederebbe?
Spariremmo di colpo in un lampo, trasformandoci in energia....