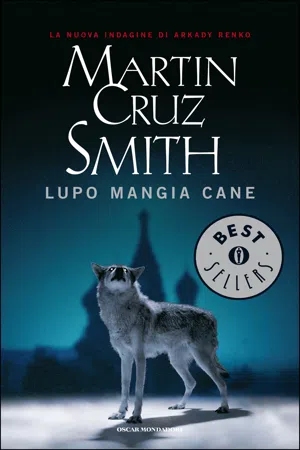Mosca vibrava di colori. L’illuminazione soffusa della Piazza Rossa si mescolava con i neon dei casinò di piazza della Rivoluzione. La luce filtrava dal centro commerciale sotterraneo del Manezh e i riflettori incoronavano le nuove torri di vetro e pietra levigata sovrastate da guglie. Le cupole dorate spiccavano ancora attorno all’Anello dei giardini, ma nel corso della notte le escavatrici artigliavano la città, creando pozze di luce sempre più ampie là dove sarebbe sorta una nuova Mosca, moderna e verticale, simile a Houston o a Dubai. Era la Mosca che Pasha Ivanov aveva contribuito a creare, un paesaggio mutevole fatto di placche tettoniche, colate di lava ed errori fatali.
L’investigatore Arkady Renko si sporse dalla finestra per riuscire a vedere meglio Ivanov, che giaceva sul marciapiede dieci piani più sotto. Non aveva perso molto sangue, ma era indubbiamente morto, con gli arti piegati in modo innaturale. Parcheggiate lì accanto c’erano due Mercedes nere, quella di Ivanov e la SUV della guardia del corpo.
Ivanov era arrivato alle 9.28 di sera, era salito direttamente a quello che veniva considerato l’appartamento più sicuro di tutta Mosca e alle 9.48 si era schiantato a terra. Arkady aveva misurato la distanza del corpo dall’edificio. Di solito, se si trattava di omicidio, la caduta avveniva in verticale, visto che la vittima aveva speso quasi tutte le sue energie per evitare di essere catapultata all’esterno. I suicidi, invece, erano più motivati e atterravano più lontano. Ivanov era finito quasi sulla carreggiata.
Alle spalle di Arkady, il pubblico ministero Zurin aveva portato qualcosa da bere a un vicepresidente della NoviRus, un certo Timofeyev, e alla giovane bionda che stava con lui in soggiorno. Zurin aveva la sollecitudine di un capocameriere, qualità che gli aveva consentito di sopravvivere a sei passaggi di potere all’interno del Cremlino, individuando chi poteva essergli utile e spianandogli la strada. Timofeyev tremava e la ragazza era ubriaca. Arkady aveva la sensazione di essere a un party in cui il padrone di casa, all’improvviso, si fosse inesplicabilmente buttato dalla finestra. Superato lo shock, la serata procedeva come se niente fosse stato.
L’unica presenza fuori luogo era Bobby Hoffman, l’assistente americano di Ivanov. Nonostante il suo capitale fosse valutato in svariati milioni di dollari, indossava dei mocassini malandati, una giacca di pelle completamente lisa e aveva le dita macchiate d’inchiostro. Arkady si domandò quanto tempo ancora sarebbe rimasto alla NoviRus. Essere l’assistente di un morto non era molto promettente.
Hoffman raggiunse Arkady alla finestra. «Perché avete messo dei sacchetti di plastica sulle mani di Pasha?»
«Voglio verificare se ci sono segni di traumi, magari dei tagli sulle dita.»
«Segni di traumi? Vuol dire che c’è stata una colluttazione?»
Il pubblico ministero Zurin, che si era seduto sul divano, si protese in avanti. «Non ci sarà un’indagine. Non si investiga su un suicidio. Nell’appartamento non ci sono segni di colluttazione. Ivanov è salito da solo e se n’è andato da solo. È indubbio che si è tolto la vita.»
La ragazza alzò gli occhi con aria stupefatta. Leggendo il dossier su Pasha Ivanov, Arkady aveva appreso che Rina Shevchenko, una ventenne che indossava un tailleur pantalone di pelle rossa e stivali con il tacco alto, era la sua arredatrice personale.
Timofeyev aveva la fama di essere stato uno sportivo, ma ora sembrava un vecchio, tanto si era afflosciato. «Il suicidio è una tragedia personale. La morte di un amico è abbastanza dolorosa di per sé, senza aggiungere altre complicazioni. Il colonnello Ozhogin, il capo della sicurezza della NoviRus, è già in volo.» Poi, rivolto ad Arkady, aggiunse: «Ha chiesto di non toccare niente fino al suo arrivo».
«Non possiamo lasciare un cadavere sul marciapiede come se fosse un tappeto, nemmeno per fare un piacere al colonnello» replicò Arkady.
«Non fate caso all’investigatore Renko» disse Zurin. «Va matto per le procedure. È come i cani della squadra Narcotici: non c’è borsa che non si precipitino ad annusare.»
“Non resterà molto da annusare qui attorno” pensò Arkady. Per pura curiosità, gli venne da chiedersi come avrebbe potuto salvaguardare le impronte di sangue sul davanzale.
Timofeyev si premette un fazzoletto sul naso. Arkady notò delle piccole macchie rosse.
«Ha perso sangue dal naso?» domandò Zurin.
«No, è semplicemente un’allergia estiva.»
Sul lato opposto della strada, di fronte all’appartamento di Ivanov, c’era un palazzo di uffici completamente buio. Un uomo uscì dal portone, salutò Arkady con un cenno della mano e gli rivolse il gesto del pollice verso.
«È uno dei suoi?» chiese Hoffman.
«È un detective. Magari qualcuno si è fermato a lavorare fino a tardi e ha visto qualcosa.»
«Ma non ci sarà un’indagine, no?»
«Io faccio quello che dice il pubblico ministero.»
«Dunque ritenete che si tratti di un suicidio.»
«A noi piacciono i suicidi. Non richiedono molto lavoro e non incidono sul tasso di criminalità.» Senza contare – ma questo Arkady si limitò a pensarlo – che i casi di suicidio non rivelavano l’incompetenza degli investigatori, molto più abili a distinguere un ubriaco vivo da uno morto che a risolvere un caso di omicidio commesso con un minimo di premeditazione.
«Vi prego di scusare Renko» disse Zurin. «È convinto che Mosca non sia altro che un vivaio di criminali. Il problema è che la stampa si butterà a capofitto sulla morte di un personaggio del calibro di Pasha Ivanov.»
“Nel qual caso, meglio un bel suicidio di un omicidio” pensò Arkady. Timofeyev poteva essere dispiaciuto che l’amico si fosse tolto la vita, ma un’indagine per omicidio sarebbe stata per la NoviRus come una bufera, soprattutto dal punto di vista dei soci e degli investitori stranieri, già convinti che fare affari in Russia fosse come tuffarsi in acque tempestose. Poiché era stato Zurin a istruire un’indagine sulle finanze di Ivanov, il brusco mutamento di direzione doveva avvenire senza indugi. Più che un capocameriere, pensò Arkady, Zurin era un abile marinaio che sapeva sempre quando era il momento di cambiare rotta.
«Chi aveva accesso a questo appartamento?» domandò.
«Pasha era l’unico autorizzato ad arrivare a questo piano. E il servizio di sicurezza è il migliore del mondo» commentò Zurin.
«Proprio così» confermò Timofeyev.
«L’intero edificio è munito di telecamere a circuito chiuso, interne ed esterne, e i monitor sono controllati non solo dal portiere, ma anche dai tecnici del servizio di sicurezza, nella sede centrale della NoviRus. Gli altri appartamenti sono forniti di chiavi. Ivanov, invece, aveva una pulsantiera di cui lui solo conosceva il codice. Disponeva anche di un congegno per bloccare la porta dell’ascensore, se voleva tenere fuori il mondo quando era in casa. La sicurezza di cui godeva era totale.»
Nell’atrio, Arkady aveva notato i monitor incassati nel bancone circolare di legno di rosa. Ciascuno schermo era diviso in quattro sezioni. Il portiere disponeva anche di un telefono bianco con due linee esterne e di uno rosso che comunicava direttamente con la NoviRus.
«Il personale dell’edificio non conosceva il codice d’accesso all’appartamento di Ivanov?» chiese Arkady.
«No. Era noto solo all’ufficio centrale della NoviRus» rispose Zurin.
«E lì, chi ne era in possesso?»
«Nessuno. È rimasto sigillato fino a questa sera.»
Secondo il pubblico ministero, Ivanov aveva ordinato che nessuno entrasse nell’appartamento tranne lui. Niente personale di sicurezza, né donne di servizio, nemmeno l’idraulico. Chiunque avesse provato a introdursi sarebbe comparso sui monitor e sulle registrazioni, e il portiere non aveva visto niente. Ivanov puliva l’appartamento personalmente. Dava invece all’addetto all’ascensore la lista delle cose da fare: il bucato, la tintoria, l’acquisto di generi alimentari e altre incombenze, e ritirava il tutto in portineria quando tornava a casa. Nel racconto di Zurin, sembravano altrettanti colpi di genio.
«Originale» osservò Arkady.
«Poteva permetterselo. Churchill girava nudo per il suo castello.»
«Pasha non era pazzo» protestò Rina.
«Com’era?» chiese Arkady. Poi riformulò la domanda. «Come lo descriverebbe?»
«Era dimagrito. Diceva di avere un’infezione. Forse era allergico a qualche farmaco.»
«Vorrei che Ozhogin fosse qui» disse Timofeyev.
Una volta Arkady aveva visto una rivista patinata su cui era pubblicata una foto di Lev Timofeyev che, sorridente e sicuro, fendeva le onde del mar Nero a bordo di uno yacht. Dov’era finito quell’uomo?
Un’ambulanza parcheggiò discretamente accanto al marciapiede. Il detective attraversò la strada con una macchina fotografica e cominciò a prendere alcuni scatti di Ivanov mentre veniva chiuso nel sacco di plastica, occupandosi poi delle macchie di sangue sul selciato. Qualcosa era rimasto nascosto sotto il cadavere. Da quella distanza sembrava un bicchiere, osservò Arkady. Il detective immortalò anche quello.
Lo sguardo di Hoffman si spostò su Arkady. «È vero che considera Mosca come una grande scena del crimine?»
«È la forza dell’abitudine.»
Il soggiorno sarebbe stato il sogno di ogni tecnico della Scientifica: divani e poltrone rivestiti di pelle bianca, pavimento di marmo e pareti tappezzate di lino, portacenere e tavolini di vetro, superfici perfette per rilevare capelli, impronte, tracce di rossetto, tutti i piccoli segni del disordine della vita. Sarebbe stato un lavoro facile se Zurin non avesse avuto l’idea geniale d’invitare in casa quella banda di allegroni, inquinando le prove. Perché, quando uno salta dalla finestra, le possibilità sono due: o l’ha fatto da solo o qualcuno l’ha spinto.
Timofeyev attaccò a parlare, senza rivolgersi a nessuno in particolare. «Pasha e io ci conoscevamo da un pezzo. Avevamo studiato insieme ed eravamo diventati ricercatori all’istituto nel periodo in cui il paese era in piena crisi economica. Pensate un po’, lavoravamo nel più grande laboratorio di fisica di Mosca senza uno straccio di compenso. D’inverno il direttore, il professor Gerasimov, non accendeva il riscaldamento per risparmiare e naturalmente i tubi gelavano. Dovevamo scaricare un migliaio di litri d’acqua radioattiva e quindi decidemmo di farla defluire direttamente nel fiume, in pieno centro cittadino.» S’interruppe per finire il suo drink. «Gerasimov era un uomo brillante, ma il più delle volte era ubriaco perso. In quelle occasioni avevamo mano libera. Così versammo la nostra acqua radioattiva nel bel mezzo di Mosca, senza che nessuno ne sapesse niente.»
Arkady era sconcertato. Non aveva mai sentito parlare dell’episodio.
Rina prese il bicchiere di Timofeyev e si diresse al mobile bar, dov’era esposta una serie di fotografie che ritraeva Pasha Ivanov da vivo. Non si poteva dire che fosse stato particolarmente affascinante, ma era un uomo imponente, che amava la grandiosità. Nelle foto lo si vedeva scalare montagne, fare trekking negli Urali, solcare rapide su un kayak. Abbracciare Eltsin, Clinton e Bush senior. Rivolgere un sorriso radioso a Putin, il quale, come al solito, sembrava in preda a un attacco di mal di denti. In una foto teneva in braccio un minuscolo bassotto come se fosse un bambino. Ivanov era amico di cantanti d’opera e star del rock e, anche quando si inchinava davanti al patriarca della Chiesa ortodossa, aveva un’aria di totale sicurezza, di sfrontatezza, quasi. Altri uomini appartenenti alla Nuova Russia avevano fatto una brutta fine: erano stati uccisi, mandati in esilio o avevano concluso la loro carriera con la bancarotta. Pasha non solo aveva prosperato, ma si era anche guadagnato la fama di persona attenta ai bisogni della collettività. Quando i fondi per la costruzione della chiesa del Redentore si erano esauriti, lui aveva provveduto ad acquistare la lamina d’oro che doveva servire a rivestire la cupola. Nel momento in cui Arkady aveva aperto il fascicolo su Ivanov, gli era stato detto che, nel caso in cui fosse stato accusato di qualcosa, gli sarebbe bastata una telefonata al senato per far riscrivere la legge. Cercare di incriminarlo era come pretendere di tenere stretto un serpente in muta, a cui per giunta stessero spuntando le zampe. In altre parole, Ivanov era un uomo del suo tempo e, contemporaneamente, un fenomeno in evoluzione.
Arkady notò qualcosa che baluginava impercettibilmente sul davanzale, dei piccoli cristalli dall’aria così familiare che non resistette alla tentazione di raccoglierli con la punta di un dito e di assaggiarli. Era sale. «Do un’occhiata attorno» disse.
«Perché? Non è tutto chiaro?» osservò Hoffman.
«Certo che sì.»
«Permette una parola» intervenne Zurin, guidando Arkady verso l’ing...