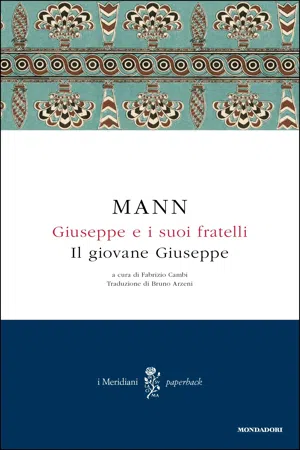LA PRETESA
L’abbiamo udito: Giacobbe aveva chinato il capo quando i figli nella loro esasperazione si erano allontanati dalla casa paterna, e da allora solo di rado lo risollevò. Si avvicinava la stagione in cui il sole infuria con torrida vampa e con il più spietato ardore su tutta la terra. E sebbene fosse proprio la stagione in cui l’astro solare principia a scomparire e in cui una volta, nel mese di Tammuz, Rachele, la Giusta, gli aveva donato Giuseppe, l’animo di Giacobbe soffriva come sempre nell’ardente desolazione di questo quarto del ciclo planetario. La stagione, dunque, poteva contribuire al suo abbattimento, e aiutare Giacobbe a spiegare a se stesso tale stato d’animo. Ma il motivo vero del suo avvilimento era un altro: l’unanime annuncio dei figli, la loro partenza, questo evento di cui sarebbe dire troppo qualora si affermasse che aveva causato grande dolore a Giacobbe: no, così non era. Nel suo cuore egli dava veramente “dieci per uno”; ma farlo nella realtà, trovarsi ad affrontare il fatto che la rottura della comunità familiare da parte dei fratelli si rivelasse definitiva, rimanere, lui, Giacobbe, come un albero sfrondato, con due invece che con dodici, era una cosa un po’ diversa. Prima di tutto menomava il suo decoro e la sua maestà, e poi il solo pensiero di quella divisione lo metteva in uno stato di ansiosa incertezza di fronte a Dio; si domandava infatti quanto grande sarebbe stata la responsabilità che si assumeva davanti al Dio della promessa e ai suoi progetti. Non aveva il Signore dell’avvenire saggiamente impedito che tutto andasse solamente secondo il desiderio di Giacobbe e che egli fosse fecondo solo in Rachele? Non l’aveva reso numeroso anche contro il desiderio del suo cuore per mezzo dell’inganno di Labano e non erano tutti, anche i figli delle non amate, frutto della benedizione e portatori di un avvenire imprevedibile? Giacobbe vedeva bene che la predilezione per Giuseppe era una privatissima faccenda del suo cuore, di un’arbitrarietà sconfinata ma suscettibile, per le sue conseguenze, di diventare, qualora si fosse trovata in dannoso contrasto con i progetti indeterminatamente vasti di Dio, colpevole protervia. E questo appunto sembrava che stesse per diventare: se l’avventatezza di Giuseppe era stata la causa immediata della rottura – e Giacobbe, se pur con dolore, era in collera con lui per questo – tuttavia non si faceva illusioni: di fronte a Dio e agli uomini, responsabile di quello sconsiderato contegno di Giuseppe era soltanto lui. Mentre contendeva con Giuseppe, egli contendeva in realtà con se stesso. Se sventura aveva avuto luogo, il ragazzo non ne era stato che lo strumento: il vero responsabile era il cuore di Giacobbe, che troppo amava. A che nasconderselo? Dio lo sapeva, e dinanzi a Dio non ci si nasconde. Rendere onore alla verità era il retaggio di Abram, e in fondo non si trattava che di dirsi senza infingimenti quanto Dio già sapeva.
Tale l’esame di coscienza e le riflessioni cui si abbandonò Giacobbe dopo la mietitura e a cui si dovettero le sue decisioni. Sorgente di tutto il male era stato il suo cuore; ora il suo cuore doveva dominarsi, e dell’oggetto viziato della sua tenerezza, del suo figliolo che era stato lo strumento del danno doveva fare lo strumento della riparazione, pretendere da lui qualche sacrificio, trattarlo un po’ duramente, perché espiasse per sé e per il suo cuore. E così appena vide di lontano Giuseppe lo chiamò con tono piuttosto perentorio:
«Giuseppe!»
«Eccomi!» rispose il ragazzo e subito accorse. Si rallegrava che lo chiamasse, perché da quando i fratelli se ne erano andati aveva parlato poco con lui e anche in lui, l’autore del gesto sconsiderato, era rimasto dell’ultimo incontro un senso di disagio, pieno di presentimenti.
«Ascolta un po’», disse Giacobbe con un’aria volutamente distratta, socchiudendo pensosamente gli occhi e lisciandosi la barba con la mano, «che ne è dei tuoi fratelli maggiori? Non pascolano tutti insieme nella valle di Shekem?»
«Certo», rispose Giuseppe, «credo bene di ricordarmene e, se la memoria non mi inganna, volevano trasferirsi tutti insieme a Shekem e custodirvi le tue mandrie che pascolano laggiù, perché vi sono là pingui prati e perché questa valle non può nutrire tutto il tuo bestiame.»
«Così è», confermò Giacobbe, «ed è per questo che ti ho chiamato. Non so infatti nulla dei figli di Lia e mi manca notizia dei figli delle ancelle. Non so come vadano le cose su quei pascoli, se la benedizione di Jizchak si sia fatta sentire sull’agnellatura estiva o se i parassiti del fegato e il meteorismo distruggano le mie greggi. Della salute dei miei figli, tuoi fratelli, non so nulla, non mi giunge voce se esercitino in pace il diritto di pascolo della roccaforte, dove, se ben ricordo, avvennero una volta gravi fatti. Ciò mi mette in pensiero ed è appunto in questo pensiero che ho deciso di mandarti a loro perché tu li saluti in mio nome.»
«Eccomi!» esclamò ancora una volta Giuseppe. Scoccò un sorriso al padre con i suoi denti candidi e, per mostrargli com’era pronto, si mise a saltellare sui talloni.
«Se non calcolo male, tu entri ormai nel tuo diciottesimo anno di vita», continuò Giacobbe, «ed è giunto il momento che io ti tratti con una certa ruvidezza, e metta alla prova la tua virilità. Pertanto ho deciso di affidarti questa missione e che tu per qualche tempo te ne parta da me e vada dai tuoi fratelli e ti informi su quello che non so, così che dopo dieci o nove giorni tu torni a me con l’aiuto di Dio, e me lo dica.»
«Eccomi, sono pronto!» rispose Giuseppe in visibilio. «Le idee del mio caro papà, del mio signore sono oro e argento! Percorrerò il paese, visiterò i fratelli, vedrò se tutto va bene nella valle di Shekem, sarà per me un grande piacere! Se mi fosse stato permesso augurarmi qualche cosa secondo il desiderio del mio cuore, sarebbe stato questo e null’altro!»
«Tu non dovrai» disse Giacobbe «guardare se tutto va bene presso i tuoi fratelli. Sono capacissimi di provvedervi da sé e non hanno bisogno del bambino. Né del resto è con questa intenzione che ti mando. Ma ti inchinerai davanti a loro con grazia e con belle maniere e dirai: “Sono venuto qui dopo un viaggio di parecchi giorni per salutarvi e informarmi della vostra salute, di mia iniziativa come pure per suggerimento di nostro padre, giacché entrambi convenimmo in questo desiderio”.»
«Dammi Parosh da cavalcare! È tenace, ha lunghe zampe, ossa robuste e assomiglia a mio fratello Issakhar.»
«Depone a favore della tua virilità d’animo» rispose Giacobbe dopo una pausa «che tu accolga con gioia questa missione e che non giudichi strana la pretesa di doverti separare da me per parecchi giorni e che io non ti veda finché la falce in cielo non si muti in mezzaluna. Dirai dunque ai tuoi fratelli: “Nostro padre volle così”.»
«Mi dai allora Parosh?»
«Sono disposto, è vero, a trattarti con una certa rudezza e non più come un bambino, ma l’asino Parosh non te lo do perché è ostinato e la sua prudenza non è pari all’irruenza. Molto più adatta è per te la bianca Hulda, un animale docile e cauto, e anche bello a vedersi quando cavalchi tra la gente: quella devi prendere. Ma affinché tu riconosca che io pretendo da te che porti a compimento qualcosa, e lo riconoscano anche i fratelli, ti ordino di compiere il viaggio da solo, da qui ai campi di Shekem. Non ti farò accompagnare da garzoni e non lascerò che Eliezer cavalchi al tuo fianco. Viaggerai da solo, per conto tuo, e dirai ai fratelli: “Sono venuto da solo su un’asina bianca per salutarvi, così volle nostro padre”. Ma non è detto che poi tu debba ritornare da solo, senza nessuno, i fratelli potranno accompagnarti, tutti o alcuni. Questo anzi è il segreto pensiero con cui ti affido questa missione.»
«Saprò ben combinare le cose» rispose Giuseppe. «Impegnami pure a riportarteli, anzi voglio farmene garante, e oso dirti: non ritorno se non te li riporto!»
Gettata là questa sciocca promessa, Giuseppe si mise a ballare intorno al padre e a inneggiare a Jah, perché gli era concesso di fare un viaggio da solo e di vedere il mondo. Poi corse da Beniamino e dal vecchio Eliezer per raccontare loro la cosa. Ma Giacobbe lo seguì con lo sguardo scuotendo la testa, perché vedeva bene che se in questo caso si poteva dire che si “pretendesse” qualche cosa, era solo da lui, ed egli non trattava duramente altri che se stesso. Ma non doveva forse essere così e non voleva appunto questo la responsabilità che egli sentiva nei riguardi di Giuseppe a causa del proprio cuore? Per molti giorni non avrebbe veduto il figlio, e ciò gli sembrava una espiazione sufficiente per la propria colpa; non poteva nemmeno immaginarsi né avere la più lontana idea di quello che in alto luogo si intendeva con “trattare rudemente”. Egli metteva in conto che la missione di Giuseppe potesse fallire, allorché considerava la possibilità di un suo ritorno senza i fratelli. Ma la terribile possibilità che si avverasse il caso opposto non si affacciò neppure alla sua mente; il destino, per assicurarsi di poter esercitare il proprio dominio, gli impediva di immaginare un tale caso. Poiché tutto avviene altrimenti da quello che si pensa, i pensieri degli uomini, quando precorrono ansiosamente il futuro, assomigliano un po’ agli esorcismi e sono un ostacolo all’attuarsi del destino. Ma questo, per difendersi, paralizza la nostra immaginazione, così che essa tutto configura fuorché la fatalità che incombe, e quest’ultima, non scongiurata dai nostri pensieri, conserva in tal modo tutta la sua originaria natura e la sua annichilente potenza.
Durante i piccoli preparativi richiesti dal breve viaggio di Giuseppe risorgeva nell’animo di Giacobbe, con una malinconia alta e pensosa, il ricordo di giorni lontani, gravi di destino: la partenza dalla casa paterna voluta da Rebecca, dopo l’inganno della benedizione, e la sua anima era piena del sentimento solenne del ripetersi degli eventi. Bisogna però dire che trovare una corrispondenza fra i due eventi era molto ardito: la sua parte ora non poteva confrontarsi con quella di Rebecca, la madre eroica e coraggiosa, che aveva consapevolmente sacrificato il suo cuore, ordito l’inganno che, a suo vedere, rimetteva le cose nel giusto ordine e, pur sapendo che forse non avrebbe riveduto mai più il suo diletto, lo aveva mandato in terre lontane. Il tema si prestava a molte varianti. Se infatti Giuseppe doveva a sua volta lasciare la casa per la collera dei fratelli defraudati dei loro diritti, egli non fuggiva per la manifestazione diretta di tale collera, ma era Giacobbe che lo inviava, per così dire, nelle braccia di Esaù; era la scena presso lo Jabbok,1 che egli aveva in mente e desiderava che si ripetesse al più presto lo spettacolo di umiliazione affatto esteriore, quella conciliazione puramente di facciata e piena di riserve, rimarginarsi di una ferita che non si poteva rimarginare, la conciliazione apparente di ciò che restava inconciliabile. L’atteggiamento di Giacobbe con il suo indulgere al sentimentalismo e al decoro era ben diverso dall’azione risoluta di Rebecca, che prendeva su di sé tutte le conseguenze del suo operato. Inviando Giuseppe dai fratelli egli si proponeva soltanto di ristabilire lo stato di prima che, però, con fin troppa chiarezza si era dimostrato insostenibile; nessuno può dubitare infatti che con il ritorno dei dieci sarebbe irrimediabilmente continuato il vecchio gioco, in cui si mescolavano la debolezza di Giacobbe, la cieca arroganza di Giuseppe, il mortale cruccio e rancore dei fratelli, e si sarebbe giunti allo stesso risultato.
Ma, comunque, restava la circostanza che il prediletto veniva mandato in viaggio a causa del dissidio con i fratelli, in questo punto si poteva parlare veramente di una ripetizione dell’evento, e Giacobbe provvide poi a che la somiglianza si manifestasse anche nei particolari: fissò la partenza per le primissime ore del giorno, ancora prima del levar del sole, come era stato l’altra volta. Anche nell’accomiatarsi da lui, più che la sua parte di padre egli recitò la parte di Rebecca, la madre. A lungo tenne fra le sue braccia il partente, gli mormorò sulla guancia parole di benedizione, si tolse un amuleto e glielo appese al collo, lo abbracciò ancora, e si comportò con lui come se Giuseppe dovesse partire per chissà quanto tempo, forse per sempre, un viaggio di diciassette giorni, o più ancora, verso Naharajim, in terre ignote, mentre in verità il giovane, fornito a dovizia di cibarie, si preparava, con suo grandissimo piacere, a fare un salto, per vie sicure, alla non lontana Shekem. Dal che si vede come il contegno degli uomini spesso non sia proporzionato agli eventi quando, per giudicarlo, prendiamo come misura la consapevolezza che essi hanno di questi eventi, mentre se guardiamo dal punto di vista del destino di cui non sono ancora consapevoli, il loro contegno è più che giustificato. Più tardi, quando la coscienza si rischiara, ed essi comprendono qual era il segreto disegno del destino, ciò può divenire motivo di consolazione. Pertanto gli uomini non dovrebbero mai accomiatarsi gli uni dagli altri alla leggera, affinché poi, quando sia il caso, possano almeno dire: l’ho stretto al cuore ancora una volta!
È superfluo dire che questo commiato al mattino della partenza, a fianco di Hulda tutta carica di bagagli, ornata dei fiori gialli di vulneraria e di perle di vetro multicolori non era che un ultimo atto, preceduto da consigli, raccomandazioni, ammonimenti: Giacobbe aveva insegnato al ragazzo come meglio sapeva la via e le varie stazioni, raccomandandogli, proprio come fanno le madri, di badare bene a non riscaldarsi troppo e a non prendere freddo, gli aveva fatto il nome di uomini e di correligionari nei diversi luoghi dove forse avrebbe pernottato e gli aveva fatto divieto severamente, una volta che fosse giunto a Urusalim e avesse scorto presso il tempio di Baal le consacrate, le tessitrici di Ashera che lì avevano la propria dimora, di attaccare discorso con alcuna di loro. Infine, più di ogni altra cosa, lo aveva esortato caldamente e reiteratamente a comportarsi con ricercata gentilezza con i fratelli. Non sarebbe stato male, così aveva suggerito, se si fosse prostrato sette volte davanti a loro chiamandoli più volte suoi “signori”; allora forse avrebbero deciso di sedere con lui a una mensa e di non volersi più appartare da lui per il resto dei loro giorni.
Molte di queste raccomandazioni Giacobbe-Rebecca gli ripeté all’alba, nell’ultimo commiato, prima di permettergli di montare sull’asina, di partire, schioccando la lingua per la contentezza, verso il Nord, verso mezzanotte. Anzi lo accompagnò ancora per un pezzo di strada, seguitando a parlargli a fianco di Hulda, scalpitante nell’aria mattutina, ma non poté a lungo starle a passo e dovette rinunciarvi, con il cuore più affaticato di quel che avesse potuto credere. Gli riuscì di intravedere un’ultima volta lo scintillare dei denti nel volto del figlio, che si era voltato per sorridergli, e levò la mano verso di lui. Poi una curva della strada gli sottrasse la vista della giovane figura ed egli non vide più il suo Giuseppe, ormai già lontano.
GIUSEPPE CAVALCA VERSO SHEKEM
Ora il ragazzo, non più visibile all’occhio del padre, ma contento e del posto dov’era e di sé, seduto molto indietro sulla groppa della sua bestia, con le snelle gambe brune protese in avanti, il busto buttato baldanzosamente indietro, trottava nella mite luce del sole mattutino, sulla strada che conduceva a Beth-Lachem, attraverso il paese montagnoso. Il suo umore era in perfetta sintonia con le circostanze, quali esse almeno si mostravano, e se il padre aveva voluto dare una sproporzionata importanza al commiato, egli prendeva tutte quelle cerimonie con sorridente indulgenza, da vero fanciullo viziato, senza provare il minimo rammarico, per aver giocato, in quel primo distacco, un tiro all’apprensione paterna.
Giacobbe, infatti, gli aveva dato le più minuziose istruzioni sul modo di comportarsi durante il viaggio, non dimenticando nessun consiglio, nessun avvertimento; tuttavia, per colpa di una strana e non del tutto innocente amnesia, un riguardo, una precauzione sola, ma la più importante, aveva dimenticato, e ad essa pensò solo più tardi, quando l’oggetto a cui si sarebbe dovuta riferire ricomparve in circostanze terribili davanti ai suoi occhi: non gli aveva ordinato di lasciare a casa la ketônet, il velo, e Giuseppe di quel silenzio aveva astutamente approfittato. Egli la portò con sé. Ardeva talmente dal desiderio di mostrarsi anche a genti lontane in quella veste, e aveva letteralmente tremato al pensiero che il padre all’ultimo momento potesse vietargli di prenderla che riteniamo possibile, qualora così fosse avvenuto, che egli mentisse al vecchio affermando che il sacro ricamo si trovava nel baule, mentre in verità l’aveva nascosto sotto il bagaglio. Dal dorso della sua cavalcatura, la bianca Hulda color del latte, una graziosa asina di tre anni, docile e intelligente anche se incline a qualche innocente scherzo, piena di quel commovente guizzo di allegria che a volte la chiusa natura degli animali ci lascia intravedere, con espressive orecchie vellutate, la criniera lanosa che le scendeva in modo buffo dalla fronte fin sopra i grandi occhi arguti e mansueti, molestati di continuo agli angoli da nugoli di mosche. Dal dorso di Hulda, dai due lati, pendeva tutto l’occorrente per il viaggio e le provviste: l’otre di capra con il leggero latte acido per combattere la sete, panieri coperti e vasi di creta con paste di semola e di frutta, spighe arrostite, olive salate, cetrioli, cipolle abbrustolite e formaggi freschi. Tutto questo e altro ancora era destinato a ristorare il viaggiatore e a far da omaggio ai fratelli; il padre aveva esaminato con gran cura direttamente ogni cosa e soltanto in un recipiente, fin dai tempi più antichi oggetto usuale a ogni viaggiatore, non aveva spinto lo sguardo: un disco di pelle, che serviva da tovaglia, o più propriamente da tavola, in cui, tutt’intorno, erano cuciti degli anelli metallici. Perfino il Bedu del deserto, anzi soprattutto il Bedu, lo usava, e fu lui a inventarlo. Si faceva passare una corda attraverso gli anelli e si appendeva poi quella specie di tavola da pranzo portatile, a guisa di sacco, alla cavalcatura. Così aveva fatto anche Giuseppe, e con la gioia segreta di chi commette una birichinata vi aveva nascosto la ketônet.
A che pro gli apparteneva ed era sua eredità, se in viaggio non doveva farsi vedere con essa? Nelle vicinanze del suo paese tutti lo conoscevano, per l...