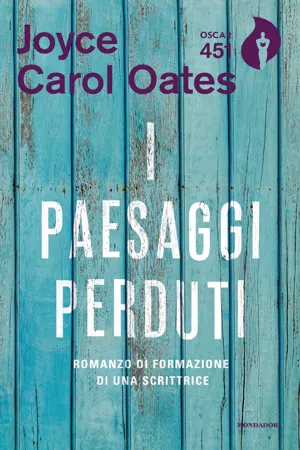Carolina Oates e Joyce nel giardino della casa di Millersport, maggio 1941. (Fred Oates)
14 maggio 1941. Un periodo di tensioni. Di gravi preoccupazioni per quello che stava per succedere, avrebbe detto mio padre di quel momento nella storia della nostra famiglia, ma chi lo immaginerebbe, guardando la vecchia e preziosa istantanea di me e mia madre che giochiamo con dei gattini nel cortile sul retro di casa?
Pareva che dovessi andare in guerra. Nessuno sapeva che cosa sarebbe successo. Alla Harrison facevamo i doppi turni. Sui giornali comparivano vignette su Hitler niente affatto divertenti. All’incubo di Pearl Harbor mancano ancora sette mesi, ma gli Stati Uniti sono in continuo allarme da quando, nel 1939, Hitler ha scatenato il suo Blitzkrieg contro una Polonia impreparata. Nel maggio 1941, mentre l’Inghilterra è sotto attacco, gli Stati Uniti sono impegnati in una guerra non dichiarata contro la Germania nell’oceano Atlantico… Ma io ho due anni e undici mesi e ignoro le preoccupazioni degli adulti che non riguardano direttamente me.
Mio padre, Frederic Oates, che tutti chiamano “Fred” o “Freddy”, ha ventisette anni e sta fotografando la mamma e me dietro la nostra fattoria di Millersport, nella parte occidentale dello stato di New York: oggi papà non è alla catena di montaggio della Harrison Radiator, una divisione della General Motors, che si trova a Lockport, New York, a sette miglia di distanza, dove si “lavora per la difesa”, o così si ritiene. È un’epoca imprevedibile, di inquietudini e rapide trasformazioni, un’epoca pre-televisione, in cui le notizie arrivano in concise comunicazioni radiofoniche e dalle sobrie pagine del “Buffalo Evening, News” che viene consegnato nel tardo pomeriggio sei giorni su sette. Ma tutta la turbolenza del mondo è molto distante dalla nostra fattoria, dove ogni cosa è verde e umida in quel maggio quasi estivo e l’erba nel cortile cresce vigorosa e disordinata. Qui mia madre Carolina, ventiquattro anni, che tutti chiamano “Lena”, mi coccola sull’erba mentre giochiamo con i gattini neri e sorride a papà che ci scatta la foto.
Immagini scattate con la fotocamera a cassetta blu. Delle decine o centinaia di fotografie di quegli anni sembra ne siano sopravvissute pochissime, e di certo saremmo rimasti sbalorditi se nel maggio del 1941 avessimo pensato: Queste foto ci sopravvivranno!
Come eravamo felici, e come doveva sembrare bella e facile la vita a quella Joyce Carol bambina lontana – che non sapeva sarebbe stata la “primogenita” di tre figli – e i cui peggiori guai nella vita consistevano nel sopportare che le districassero i ricci aggrovigliati e li legassero con dei nastri, e nell’essere “vestita bene” per qualche occasione speciale degli adulti.
Nell’immagine, dietro me e la mamma si vede un ciliegio con la corteccia scura, e dietro l’albero la fattoria, un edificio in legno a due piani, un po’ cupo, di proprietà dei genitori adottivi di mia madre, John e Lena Bush. Costruita nel 1888 in Transit Road – all’epoca una strada di campagna a due carreggiate che collegava la cittadina di Lockport con Buffalo, città in espansione a una ventina di miglia di distanza, e sorprendentemente grande per gli standard di Millersport, dove le case dei nostri vicini erano a un piano solo e senza cantina, poco più che capanne o baracche –, questa fattoria dal tetto spiovente è stata demolita alcuni decenni orsono, eppure abita ancora con indomita prepotenza i miei ricordi, ed è il luogo dove si svolgono i miei sogni ricorrenti. (In uno di questi sogni non riconosco una scena, ma una sensazione: una tonalità, una lama di luce. Spesso i dettagli si confondono. Se ci sono delle figure umane i loro volti sono confusi. Mi pare di sapere dove mi trovo e chi c’è con me, benché non sia in grado di dar loro un nome. Soltanto quella sensazione, confortante e al tempo stesso contaminata da una specie di paura viscerale: di nuovo a casa.) Si noti la porta a botola della cantina, normale in quest’America rurale ormai scomparsa, come la botte per la raccolta dell’acqua piovana a un angolo dell’edificio, che veniva usata per tutti gli scopi fuorché bere.
Alle spalle di papà che ci sta fotografando (e non visibile all’occhio di chi guarda), c’è l’aia: il fienile scolorito dalle intemperie, con il parafulmine di metallo sul punto più elevato del tetto; i pollai circondati da filo spinato per tenere lontani i procioni, le volpi e i cani dei vicini che sconfinano nella nostra proprietà, i capanni per le provviste, i campi, i frutteti. A destra della porta scorrevole del fienile c’è una porticina più piccola: è l’angolo della fucina di nonno Bush, con l’incudine e il martello, gli attrezzi da fabbro, una piccola forgia a carbone e mantici a manovella. Polli e galline che non hanno idea di essere “allevati all’aperto” gironzolano becchettando per terra, indifferenti a qualunque altra cosa. Tutto questo… perduto.
Le fotografie sono state la nostra salvezza. Senza fotografie i nostri ricordi si sarebbero dissolti, sarebbero evaporati. L’invenzione della fotografia nel Diciannovesimo secolo – e dell’“istantanea” nel Ventesimo – ha rivoluzionato la consapevolezza di sé degli esseri umani; perché quando sosteniamo di ricordare il passato quasi sicuramente stiamo ricordando le nostre foto preferite, sulle quali a un passato da lungo tempo sbiadito è stata data immortalità visiva.
Nel 1941 fare fotografie era privilegio degli adulti. Io scarabocchiavo con entusiasmo con i miei pastelli Crayola su album e blocchi di carta. L’erba erano i tratti orizzontali del pastello verde. Gattino nero, pastello nero. I polli e le galline erano forme verticali dall’aria vagamente umanoide. A ritrarre i miei genitori non ci provavo nemmeno. Nei miei disegni infantili non compare nessuna figura di adulto, soltanto erba verde scuro e alberi, gattini e gatti con il pelo di vari colori, e i polli Rhode Island Red.
Nessuna storia d’amore è profonda e duratura come quella della prima infanzia. Per tutta la vita abbiamo nostalgia dei nostri genitori, giovani, attraenti e misteriosi, che ci erano così fisicamente vicini e al tempo stesso così distanti e inaccessibili, imperscrutabili. È questa l’origine dell’“amore”, che colora e determina tutto ciò che verrà dopo? Sento l’esigenza di guardare tutte le vecchie foto di famiglia amorevolmente conservate negli album e nelle buste. Sono attratta anche dalle foto di famiglia di sconosciuti, e nei negozi dei rigattieri rovisto nelle scatole di vecchie cartoline e istantanee; anche se queste persone non sono la “mia” famiglia, spesso non sono poi così diverse da noi. Bambini in istantanee di tanto tempo fa, a cui l’affetto di un adulto conferisce un’illusoria forma di immortalità, e tutti ormai probabilmente defunti. Mi assale un desiderio che quasi mi travolge: Voglio scrivere le loro storie! È il solo modo, per me, di conoscere questi estranei, scrivere le loro storie…
Ero il suo pollo da compagnia. Ero Happy.
Soltanto uno era il pollo da compagnia della bambina con i riccioli rossi nella piccola fattoria di Transit, all’estremità settentrionale della Erie County, nella parte occidentale dello stato di New York, in quell’epoca lontana che erano i primi anni Quaranta.
Alla bambina venne fatto credere di essere stata lei la prima a chiamarmi Happy. In effetti credo sia stato uno degli adulti, probabilmente la madre.
E probabilmente era stata sempre la madre, non la bambina, ad accorgersi per prima che ero l’unico fra tutti i polli e le galline a correre incontro alla bambina chiocciando come per dirle ciao.
Oh, guarda! – è Happy che viene a dire ciao.
La bambina e la sua mamma ridevano deliziate vedendo che io, senza essere chiamato, andavo a becchettare intorno ai piedi della bambina e sembravo chinare la testa quando mi si accarezzava delicatamente il dorso, come fanno i cani e i gatti quando vengono coccolati.
Alla bambina piaceva moltissimo, perché avevo un piumaggio morbido. Non ruvido e puzzolente come quello degli altri polli più vecchi.
Alla bambina piaceva sentirmi chiocciare gentilmente, in tono interrogativo.
Al mattino presto correva fuori.
Polletto! Happy! chiamava, con le manine a coppa intorno alla bocca.
E io arrivavo correndo! Dal fienile ombroso, o dai cespugli, o da qualche punto dell’aia dove mi trovavo in mezzo ad altri polli normali dal piumaggio rosso scuro. Uno sbatter d’ali e co-co-co-co-co in un limpido staccato: Eccomi! Sono Happy!
Il nonno scuoteva la testa incredulo. Mai visto niente del genere: quel dannato pollastro crede di essere un cane.
Era un segno di quanto mi considerassero speciale, il fatto che la famiglia parlasse di me al maschile. Non come di una gallina qualsiasi, una stupida gallina ovaiola come tante altre, ma di un vivace giovane pollo.
Perché le altre erano soltanto galline, difficili da distinguere l’una dall’altra se non le si osservava con attenzione, cosa che nessuno faceva (eccetto la nonna, che esaminava quelle sospettate di essere “malaticce”).
Ero davvero Happy! Davvero non ce n’erano altri come me.
Le mie piume dalle belle tonalità rosse si gonfiavano e brillavano più lucide di quelle delle altre galline, perché io non stavo sempre a rotolarmi nella polvere come loro nel tentativo (perlopiù futile) di liberarsi dei parassiti. Non si trattava soltanto del fatto che Happy era giovane (c’erano altri polli giovani come me, usciti dall’uovo quell’anno): ero molto più intelligente e più bello; catturavo l’attenzione fra tutti gli abitanti del pollaio, perché si capiva dal luccichio dei miei occhi e da come arrivavo di corsa, prima ancora che la bambina mi chiamasse, che ero un polletto veramente speciale.
In cortile, tra il fienile e la fattoria, c’erano delle piccole buche dove le galline si rotolavano e starnazzavano come grossi uccelli dementi che avevano perso la capacità di volare. A volte addirittura una dozzina di polli si rotolava contemporaneamente nella terra come in una bizzarra e aggraziata danza moderna; solo che loro non erano aggraziati e si ignoravano, salvo, di tanto in tanto, per beccarsi, chiocciando petulanti e irritati. Quando non si rotolavano nella polvere (e nelle loro feci nere e liquide) passavano il tempo a conficcare il becco nel terreno alla ricerca di larve e insetti, semi rimasti dall’ora del pasto, pezzettini di frutta marcia. La loro felicità non era quella di Happy, ma un tipo di felicità molto ottusa, perché il cervello di una gallina non è più grande di un pisello, e quindi che cosa si può pretendere? Ecco perché Happy, cioè io, era una tale sorpresa per la famiglia, e una tale gioia.
Avevo la cresta rosea, turgida di sangue, godevo di ottima salute. I miei occhi erano insolitamente attenti e limpidi. Ma con un occhio da una parte e uno dall’altra della testa, come ci si può aspettare una visione coerente? Vediamo doppio, e una parte del nostro cervello quasi si spegne affinché l’altra parte possa mettere a fuoco ciò che vediamo. È così che capiamo in quale direzione correre, per sfuggire ai nostri predatori.
Comunque, in genere le galline non lo fanno. Non sfuggono ai predatori.
Certe volte sono così tonte che corrono incontro al predatore. Succede quando quello è abbastanza astuto da rimanere immobile. Le galline non riescono a decifrare l’immobilità, e non riescono a individuare qualcosa che le fissa.
Proprio non ero uno di loro. Essere considerato speciale e chiamato con un nome, Happy, significava che, benché anch’io fossi un pollo, ero diverso. E soprattutto non ero una stupida gallina.
Qualche volta, in occasioni speciali, sotto la supervisione degli adulti e sempre stretto fra le braccia della bambina, Happy era autorizzato a entrare in casa.
A nessuna gallina, nemmeno al signor Gallo, era mai permesso di entrare in casa.
Non nelle camere di sopra, ma al pianoterra, nella “lavanderia” sul retro – una stanza con il pavimento di linoleum dove c’erano una lavatrice e un’asciugatrice manuale, e venivano tenuti cappotti e stivali –, è qui che mi portava la bambina, Joyce. Beninteso, sempre tenuto con-gentilezza-ma-con-fermezza tra le braccia, oppure fermo sul pavimento della lavanderia o – in alcune occasioni molto speciali – nella cucina adiacente, dove la nonna passava quasi tutto il suo tempo. Qui la bambina riceveva pezzetti di pane da darmi, sul pavimento.
E qui, a volte, mi veniva permesso di stare sulle ginocchia della bambina, per essere vezzeggiato e coccolato.
Le altre galline sarebbero state gelose di me, ma erano troppo stupide. Non se ne rendevano conto. Nemmeno il signor Gallo capiva quanto era privilegiato Happy. Certe volte si piazzava sulla porta sul retro della fattoria a chiocciare e a pulirsi le penne, a protestare, ad agitarsi, sbattendo le ali, richiedendo l’attenzione di chiunque entrasse in casa o ne uscisse, sfacciatamente in cerca di un boccone speciale, e se non riceveva niente starnazzava indignato e allungava il becco aguzzo minacciosamente.
La bambina aveva paura del signor Gallo, e gli passava davanti di corsa. La mamma e la nonna lo scacciavano, perché anche loro ne avevano paura. Il nonno e il papà ridevano del signor Gallo e gli tiravano un calcio. Trovavano molto divertente che uno stupidissimo uccello provasse a intimidirli.
A volte Happy era autorizzato a passare la notte nella lavanderia, in una scatola foderata di paglia, come un nido. E la piccola Joyce mi accarezzava, e mi faceva festa, e mi dava cose buone da mangiare.
Happy! Sei così carino.
… sei tanto bello. Ti voglio bene.
Happy. Ti voglio bene.
La bambina mormorava piano, in modo che nessun altro potesse sentire. Aveva molte cose da raccontarmi, segreti di ogni genere da confidare, sussurrati contro la mia testa, nel punto dove (secondo lei) avevo “le orecchie”, e quand...