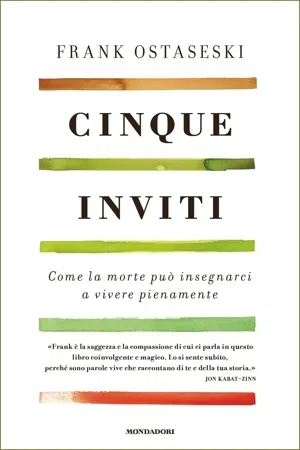Immaginate una vostra foto stampata su un cartoncino spesso e rigido. Ora immaginate che quella foto non ritragga solo il volto e il corpo, ma un’immagine multidimensionale del vostro intero essere, compresi tutti gli aspetti della vostra personalità. Supponiamo che tagliate quel cartoncino in tanti pezzi per farne un puzzle. Visualizzate le migliaia di pezzi sparsi su un tavolo e incominciate a ricostruire il puzzle.
Potreste iniziare dagli angoli o dalle parti più riconoscibili, come una mano o un orecchio, o forse dagli occhi, dato che sono considerati lo specchio dell’anima. Ma a un certo punto potreste trovare un pezzo che non vi piace, per esempio, la vostra paura. Magari pensate: «La lascerò fuori». Oppure potreste trovare la vostra lussuria e dire: «No, il mio maestro spirituale mi ha detto che la lussuria non è una cosa buona. Non posso includere questo pezzo».
Potreste continuare così, distinguendo i pezzi accettabili da quelli totalmente inaccettabili. Dopo un po’, però, non riuscireste più a riconoscervi nel puzzle, perché vedreste un’immagine frammentata; non potreste riconoscere l’immagine intera.
A tutti piace vedere se stessi belli e buoni. Vorremmo essere capaci, forti, intelligenti, sensibili, spirituali o, almeno, adeguati. Pochi vogliono mostrare la disperazione, la paura, l’ira o l’ignoranza, né vogliono che gli altri sappiano che talvolta sono un disastro.
Eppure, varie volte, ho scoperto che un mio aspetto «indesiderabile», uno di cui in precedenza mi vergognavo e che nascondevo, era una qualità che mi permetteva di affrontare le sofferenze altrui con compassione, invece che con paura o semplice pietà. Le mie stesse esperienze di abusi mi consentivano di provare empatia sia verso gli abusati sia verso gli abusatori, in modo da aiutarli a trovare perdono per la loro rabbia e ad accettare la loro paura. Non si tratta di competenza, ma di saggezza ottenuta attraverso le nostre stesse sofferenze, la nostra vulnerabilità e la nostra guarigione: il che ci permette di assistere gli altri. È l’esplorazione della nostra vita interiore che ci aiuta a gettare un ponte di empatia tra le nostre esperienze e le loro.
Per essere interi, dobbiamo includere, accettare e connettere tutte le parti di noi stessi. Dobbiamo accettare le nostre qualità conflittuali e le apparenti incongruenze tra mondo interiore e mondo esteriore.
Interezza non significa perfezione. Significa che nessuna parte viene esclusa.
Quando sto seduto accanto al letto di una persona in punto di morte, anch’io provo paura, perché sono in contatto con il mio dolore. Per compiti come questo, attingo sia alla mia disperazione che alla mia forza, sia alle mie ferite che alla mia passione. Questo è il modo in cui scopriamo un vero punto di incontro con gli altri: attraverso un’esplorazione vulnerabile e coraggiosa della nostra stessa esperienza.
Anni fa, nel 1989, assistevo il mio caro amico John, che stava morendo di AIDS. Gli volevo molto bene e volevo offrirgli la migliore assistenza possibile. Nel suo gruppo di supporto c’erano parecchi di noi. Facevamo a turno per assisterlo ventiquatt’ore su ventiquattro.
Il lunedì era il mio turno. Quel giorno indimenticabile, John fu colpito da una strana complicazione neurologica, che gli provocò confusione e amnesie, improvvisi cambiamenti della facoltà di pensare e di parlare e una perdita di sensibilità nelle mani e nelle gambe. In un colpo solo, John perse la capacità di tenere in mano un cucchiaio, di stare in piedi e di comunicare in modo intelligibile. Quando entrai nel suo appartamento, era seduto con una vestaglia a quadri al tavolo di cucina, curvo su una ciotola di Kellog’s Cocoa Krispies, con i capelli arruffati e l’espressione completamente assente.
Non lo riconoscevo. Dov’era andato? Poche notti prima ridevamo insieme guardando il Johnny Carson Show. Ora era cambiato. Sinceramente ero terrorizzato.
Con il passare delle ore, venne il pomeriggio e poi la sera, e scese un’oscurità quasi palpabile. Confesso che talvolta, nel tentativo di gestire il comportamento inusuale di John, cercai di forzarlo e di manipolarlo. Oppure, lo trattai come un bambino. Non sapevo che cosa fare. Mi sentivo confuso, perduto.
Prendermi cura di John in quelle condizioni era un lavoro duro. Aveva fistole anali e una continua diarrea. Durante la notte dovetti portarlo dozzine di volte in bagno.
Quando infine venne l’alba a scacciare l’oscurità, ero esausto. Volevo solo andare a letto. Desideravo che John si addormentasse e che si risvegliasse l’uomo che era sempre stato. Volevo che quell’incubo finisse.
Poi, in uno di quegli spostamenti dal letto al bagno, mi lavai le mani nel lavandino. Guardandomi allo specchio, vidi John seduto sul water dietro di me, con i calzoni del pigiama scivolati sulle caviglie. Stava balbettando qualcosa.
Mi voltai.
Dalla sua mente confusa uscì un sussurro: «Stai faticando troppo».
Mi fermai, mi sedetti accanto al lui e incominciai a piangere.
Quel momento fu il più intimo dell’intera nostra amicizia. Lì, di fianco alla tazza, circondati dagli escrementi. In quel momento non c’era separazione tra noi due. Eravamo entrambi distrutti. Piangevamo e, dopo un po’, ridevamo per la completa assurdità delle circostanze.
Fino a quel momento, avevo avuto paura di entrare nel territorio dell’impotenza in cui viveva John, temendo di perdermi. Mi tenevo occupato cercando di essere utile. Volevo mantenere il controllo e nascondermi dietro il mio ruolo di Mister Hospice.
Quando si ha paura, è comune e perfettamente naturale mettersi sulla difensiva, controllarsi, essere irritabili e indisponibili, e perdere la pazienza con noi stessi e con gli altri. Vogliamo sentirci sicuri e quindi ci attacchiamo ai ruoli con le loro regole e con i loro comportamenti prescritti.
Ma per connettermi con John e servirlo, dovevo capire come la mia paura innescasse un senso di impotenza. Dovevo rallentare tutto, ammorbidirmi e aprirmi al presente, invece di continuare a volere che la situazione si adattasse alle mie preferenze.
Dopotutto, noi non siamo sempre indifesi: è la situazione che dovrebbe mostrarci come agire. Ma non possiamo vedere la strada finché non allentiamo la nostra identificazione con il ruolo che svolgiamo e non permettiamo alla nostra impotenza di farsi avanti.
Siamo animali sociali e, come tali, ognuno di noi svolge nella società molteplici ruoli. A casa sono un marito, un padre e un nonno; quando esco di casa sono un vicino; quando entro in un caffè sono un avventore; nella mia comunità spirituale sono un insegnante; e, nelle mani del mio chirurgo, sono un paziente.
I ruoli non sono né buoni né cattivi; sono essenzialmente delle funzioni che forniscono regole predefinite, soprattutto nelle relazioni interpersonali.
Sviluppandoci, i nostri ruoli cambiano. Fino alla mezza età, generalmente ci focalizziamo sulla nostra realizzazione, sulla creazione della nostra identità, sulla ribellione, sulla carriera, sulla costruzione di una famiglia e delle strutture che ci sono necessarie per prosperare. Quando, nella seconda metà della vita troviamo il coraggio di cambiare, guardiamo spesso dentro di noi. Le capacità che abbiamo sviluppato nella prima metà dell’esistenza non sono più sufficienti o appropriate a sostenerci nel successivo stadio del viaggio. In questo periodo, ci dedichiamo di solito a esplorare il significato della vita, a riflettere sul mistero, a coltivare la saggezza e a rilassare i nostri sforzi: è il comportamento adatto a tale età.
Ogni ruolo arriva completo delle sue regole di comportamento, delle sue funzioni e delle sue responsabilità (batterie non incluse). Ma la situazione si complica quando un ruolo entra in conflitto con un altro. Le madri single che lottano per conciliare il lavoro a tempo pieno con la maternità riferiscono, perlopiù, di sentirsi esauste emotivamente e fisicamente. La notte del fortissimo terremoto di San Francisco, nel 1989, ero diviso tra il mio ruolo di padre che doveva occuparsi delle necessità della famiglia e il mio ruolo di direttore dell’hospice, che doveva salvaguardare la sicurezza dei pazienti e dello staff. La situazione diventa ancora più difficile quando le nostre credenze personali confliggono con i nostri ruoli professionali. Talvolta sappiamo quel che è giusto, ma ci sentiamo impotenti ad agire secondo il nostro giudizio.
I ruoli sono una scelta. Quando ne scegliamo uno, scegliamo anche di non svolgerne un altro. Se una ragazza si impegna in una vita rigorosa e determinata per diventare una ballerina professionista, deve rinunciare a un’istruzione tradizionale o a certi aspetti della sua vita sociale. Se, nel mio ruolo di avvocato, penso che sia importante proiettare un’immagine di uomo forte e ben preparato, calmo in situazioni di crisi, trovo difficile poi svelare la mia debolezza o abbracciare le mie qualità più sensibili.
Quando disconosciamo una parte di noi stessi, tendiamo a giudicare male coloro che mostrano quelle stesse caratteristiche. Rivendichiamo in tal senso una superiorità morale. Quindi, attaccandoci troppo a un ruolo, possiamo creare un abisso rispetto agli altri che sarà difficile colmare.
La vita ci chiede di adattarci continuamente; i ruoli, come molte cose, sono fluidi. Quando padre e madre invecchiano, i ruoli si rovesciano e tocca ai figli assistere i genitori. Se mantengo la mia famiglia e mi ammalo, qualcuno deve occuparsi di me. Se sono colui che prende le decisioni e mi viene l’Alzheimer, qualcun altro dovrà prenderle al mio posto. Se sono un alcolista e mi curo, all’improvviso non sono più la pecora nera della famiglia e posso di nuovo partecipare alle decisioni.
Quando ci identifichiamo troppo con un ruolo, esso ci definisce, ci confina e riduce la nostra capacità di compiere scelte consapevoli. Ci poniamo delle aspettative su come la vita dovrebbe essere. Questo significa più frammentazione, più comportamenti obbligati, più credenze fisse e minor accesso alla nostra innata saggezza. Spesso – specialmente nei ruoli pubblici e professionali – non permettiamo al nostro intero sé di manifestarsi.
Quando vado a un ricevimento, qualcuno inevitabilmente mi domanda che lavoro faccio. Ma, ovviamente, se mi definisco solo per il mestiere che faccio, che cosa sono quando non lo svolgo più? La verità è che noi non siamo ciò che facciamo. Siamo molto di più.
Ram Dass dice: «Non essere un ruolo, sii un’anima».
Noi non siamo i nostri ruoli, non siamo ciò che ci condiziona in un certo momento. Possiamo avere il cancro o essere bipolari, ma non siamo la nostra malattia. Possiamo essere nati nella ricchezza o nella povertà, ma non siamo né ricchi né poveri. Possiamo essere felici o tristi, giovani o vecchi, nella condizione di chi aiuta o in quella di chi è disperato, ma non siamo nessuna di queste cose.
Siamo innanzitutto esseri umani, con tutta la complessità, la fragilità e le meraviglie della nostra condizione. Quando guardiamo il mondo attraverso le lenti del nostro ruolo, restringiamo la nostra prospettiva. Non vediamo le cose e le persone così come sono, ma proiettiamo la nostra psicologia su di loro. E questo, frequentemente, ci porta a interpretare un’esperienza in un certo modo, facendoci perdere il vero significato che sta cercando di emergere.
Troppo spesso nei lavori in cui assistiamo gli altri non guardiamo tanto ciò che serve loro, ma vogliamo confermare la nostra identità sociale: vogliamo essere «quelli che aiutano». Ci diciamo, per esempio: «Io lavoro con i moribondi», mettendo l’accento su io. E quindi ci investiamo più del ruolo che della funzione. Io la chiamo «sindrome dell’assistente» e, secondo me, è un’epidemia più dilagante del cancro e dell’Alzheimer messi insieme.
Sto parlando del modo in cui cerchiamo di separarci dalle sofferenze altrui. Talvolta lo facciamo con la nostra pietà, con la nostra paura, con il nostro calore professionale e perfino con le nostre azioni caritatevoli. Ma tutto ciò altera la maniera in cui prendiamo le decisioni.
Una volta c’era una donna nel nostro hospice, giunta ormai a pochi giorni dalla morte. Riesaminando la sua vita passata, si rammaricava di molte scelte. Di conseguenza si sentiva triste, piuttosto depressa, ma non in senso clinico. Per me questa era una situazione ben nota.
Dopo la visita alla paziente, un infermiere mi prese da parte e mi suggerì di farle iniziare una terapia antidepressiva, una terapia che impiega da quattro a sei settimane per fare effetto.
«Perché dovremmo farlo?» gli domandai.
L’infermiere rispose: «Perché sta così male che è difficile guardarla mentre soffre».
Osservai ironicamente: «Forse sei tu quello che avrebbe bisogno di essere curato».
L’attività di assistenza degli altri può essere motivata sia da interessi egoistici sia da interessi altruistici. Lo psicologo sociale Daniel Batson identificò due distinte emozioni che ci spingono ad aiutare gli altri. Chiamò la prima «preoccupazione empatica», che considerava altruistica in quanto si focalizza sugli altri. In effetti, vedendo soffrire qualcuno, emergono in noi la tenerezza e il desiderio di prenderci cura di lui.
Chiamò la seconda «disagio personale», sostenendo che può essere considerata una motivazione egoistica, poiché è centrata sui nostri bisogni. In tal caso, la motivazione ad aiutare viene dal desiderio di una ricompensa personale, perché vogliamo aumentare il senso di autostima o perché cerchiamo di evitare un senso di colpa, l’autocritica o altri sentimenti spiacevoli. Si tratta dell’opposto dell’empatia, dato che, invece di favorire la connessione, può portare al desiderio di proteggerci, di ritirarci o di fare ancora di più, indipendentemente dal fatto che gli interventi siano voluti dal paziente o abbiano un reale valore.
Non è raro che i medici vogliano respingere i loro sentimenti di paura, di inutilità o di impotenza prescrivendo terapie, droghe o trattamenti che non sono necessari, efficaci o desiderati.
Jackson lavorava in una fabbrica di appendiabiti di filo metallico. Nella sua camera aveva tre televisori, che talvolta teneva accesi contemporaneamente. Ciascuno aveva la propria antenna fatta a mano, perché ovviamente Jackson aveva un’illimitata riserva di fili. La notte gli piaceva guardare film dell’orrore e thriller, spesso tre nello stesso tempo. La mattina si svegliava intontito e si lamentava di aver avuto terribili incubi. Gli suggerii di spegnere i televisori prima di addormentarsi.
Mi guardò come s...