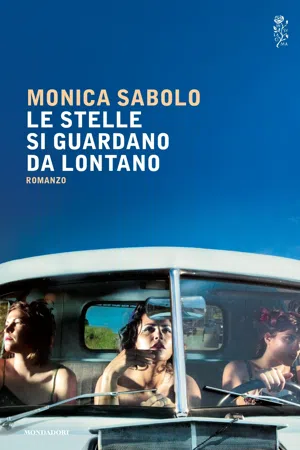A quel tempo, a Crans-Montana, ne eravamo tutti innamorati. Di loro tre insieme, o prima dell’una e poi dell’altra, oppure di una sola, un’ossessione che faceva capolino alla pista di pattinaggio, in panetteria, davanti alle funivie, che ti sorrideva e ti straziava il cuore, in lontananza, con indosso un maglione fatto a mano o una pelliccia di castoro.
Ne conoscevamo i guardaroba, i profumi. I sorrisi, le fossette, i nei – sulla spalla, sull’avambraccio –, i profili tondeggianti dei fondoschiena fasciati nei Levi’s dei fratelli. Conoscevamo i loro chalet, i genitori, gli accessori, i fermagli per i capelli, gli orecchini con i turchesi, i braccialetti di corallo, le calze multicolori che arrivavano a metà coscia. Ne conoscevamo le date di compleanno, gli indirizzi di Parigi o Milano, del collegio nel XVI arrondissement, del convitto a Losanna.
Le conoscevamo come gli investigatori conoscono i sospetti che stanno pedinando, acquattati in automobili grigie, con la chiave inserita. Accumulavamo prove della loro esistenza, sigarette al mentolo, chewing gum Hollywood al limone, caramelle alla violetta, e un anello con un teschio di onice dimenticato sul bordo di un lavandino e infilato febbrilmente in una tasca. Quella sera stessa, allo Sporting, sarebbe passato di mano in mano, esaminato da ciascuno di noi, in silenzio, prova lampante del mistero femminile.
Erano visioni che poi ritrovavamo nei sogni, di ritorno ai nostri appartamenti borghesi, ripercorrendo i ricordi delle vacanze come diapositive in cui loro sfilavano, inondate di luce, sussurrando parole dolci in una lingua segreta. Erano i nostri primi amori, e in seguito tutte le altre donne della nostra vita sarebbero state paragonate a loro, e nessuna avrebbe mai potuto cancellare i loro fantasmi, che riemergevano più reali delle nostre mogli, delle amanti, delle madri dei nostri figli.
La banda delle tre C. Chris, Charlie e Claudia. Le due parigine e l’italiana. Erano sempre insieme, a braccetto o sedute con disinvoltura su una panchina, un polpaccio ripiegato sotto la coscia, così diverse, eppure formavano un’entità perfetta, come una costellazione. Claudia, capelli biondi, colorito pallido, fianchi stretti, sorriso accattivante. Chris, riccioli mori, pelle olivastra, labbra sensuali, unghie lunghe simili ad artigli. Charlie, capelli neri che le arrivavano alle natiche, seno piccolo, gambe lunghe, viso impassibile. Avevano tutta l’aria di divertirsi e di infischiarsene del mondo intorno a loro. Bevevano una Coca-Cola con la cannuccia, o si tenevano per mano pattinando sul ghiaccio, i capelli sciolti sulle spalle, e tutte le volte sentivamo i battiti accelerare, le guance infiammarsi, e c’era sempre qualcuno tra noi che mimava un’agonia, con una mano sul petto, o una pistola immaginaria puntata alla tempia.
Era l’inverno del 1965? L’estate del ’66? Secondo Roberto Alazraki, un italiano di Tripoli che si era rifatto il naso l’anno in cui aveva compiuto diciott’anni, erano apparse per la prima volta fasciate nei loro parei al veglione in stile polinesiano del 1965, al Quatre Cents Coups, sulle sponde del laghetto di Vermala. Serge Chubowska, un parigino che indossava la cravatta anche per andare a giocare a bowling, sosteneva che fosse stato durante le vacanze di Pasqua del 1966 al Club, sotto la Rôtisserie de la Reine dove «ballavano come se avessero il fuoco sotto le chiappe», ma nessuno gli dava retta.
Passavamo tutte le vacanze, o quasi, a Crans-Montana, in Svizzera, o più precisamente a Montana-Crans, come si diceva allora, e non solo d’inverno ma anche d’estate. Con le amiche, le nostre madri evocavano la bellezza delle montagne, l’aria pura, la tranquillità, neanche fossero un’agenzia di viaggi, tutte cose di cui a noi invece non fregava nulla e che ci ricordavano che i nostri genitori non ci avrebbero mai capiti. Anche prima della comparsa delle tre ragazze, Crans-Montana non rappresentò mai un rifugio per noi. La luce era forte, il cielo tagliente, le foreste cupe, inquietanti. Sulle piste da sci o sotto il tessuto di cotone dei piumoni, ci sentivamo dolorosamente vivi, i nostri cuori battevano troppo forte. A Parigi conducevamo vite ordinarie, mentre in quel luogo tutto era selvaggio, la libertà lì era spaventosa. Ragazzi di buona famiglia, per lo più ebrei – anche se questo non aveva alcuna importanza, eravamo un gruppo –, ci trovavamo a scuola di sci o in creperia, e più avanti nei night-club locali, e ogni volta respiravamo più in fretta, il petto oppresso dall’esaltazione e dal pericolo.
In realtà, le tre C erano lì da sempre. Da bambine, avevano trotterellato al Grand-Place, il supermercato moderno in centro, dove i nostri genitori acquistavano quantità assurde di formaggio e cioccolato. Avevano succhiato le Sugus, le caramelle svizzere allo sciroppo di glucosio, nascoste dietro le figure autoritarie dei fratelli. Erano diventate delle preadolescenti scialbe, educate, vestite con cappottini scuri, fatti di un tessuto di lana che sembrava cartone. Come noi, avevano preso lezioni di golf, di sci, avevano nuotato in piscina, corso sulla terrazza dello Sporting dove, come noi, rubavano gli stecchini di plastica arancione per mescolare i cocktail. Ma noi non le avevamo viste. Vivevamo in un mondo parallelo, morbido e vellutato come neve di primavera. Era un tempo privo di ricordi, un tempo di cui conservavamo solo il profumo delle nostre madri, quando ci abbracciavano la sera, vestite di tutto punto, truccate, lasciandoci vagamente inquieti, consapevoli della nostra perfetta inutilità.
Poi, tutt’a un tratto, un’estate, o era forse inverno?, le tre C avevano subito un’inaudita trasformazione biologica, ed erano apparse tutte e tre, con il seno, i capelli cresciuti all’improvviso, un paio di cosce robuste sotto la gonna scozzese, e dei ciondoli appesi al collo e ai polsi.
Come si erano conosciute? Nessuno lo saprà mai.
Il fervore che ci colse fu probabilmente commisurato allo sbalordimento che provammo quando ci apparvero, trasformate. Il mondo stava cambiando, i loro sorrisi sicuri annunciavano una rivoluzione. Da quel momento la vita sarebbe diventata spaventosa, irreale, fatta di solitudine e turbamenti notturni che si sarebbero riversati in noi, come un lago sotterraneo.
Noi non le avevamo viste, ma loro erano lì. Fu Franco Rossetti, i cui genitori erano i proprietari della drogheria di Montana, a raccontarci gli inizi, quel periodo confuso in cui noi eravamo ciechi.
Pur avendo solo due anni più di noi, Franco Rossetti era un uomo. Mentre noi eravamo piccoli, gracili, lui faceva guizzare i muscoli – sembravano vivi – sotto magliette stinte e indossava jeans che lasciavano indovinare un’anatomia seducente. Sghignazzavamo tra noi evocando la “marmotta di Franco”. Indossavamo pantaloni di velluto d’inverno, bermuda d’estate. Eravamo terrorizzati.
I nostri genitori si rivolgevano a Franco come se fosse uno di loro. Lo rispettavano. Mentre a noi vietavano di parlare a tavola, si chiudevano nei loro studi come se la nostra presenza ricordasse loro una realtà sgradevole, ai nostri padri piaceva parlare con Franco. Assumevano un tono complice che noi non gli conoscevamo. Ordinavano carne secca dei Grigioni, champagne, formaggio per la raclette, che Franco riponeva delicatamente negli scatoloni.
Daniel Vidal, al cui padre piaceva colpire la tavola con un martelletto con la scritta “Il capo sono io”,a ricordava una scena che ci raccontava spesso, con gli occhi rossi di collera. «C’è questa foto di Marilyn Monroe, su una rivista, appoggiata lì sul bancone della drogheria, e tutt’a un tratto mio padre dice a Franco: “Non era troppo grosso per lei?”. Avete capito a cosa si riferiva? Al seno! Si riferiva alle sue tette!» Ogni volta che Daniel Vidal ricordava la scena, il suo sguardo si perdeva nel vuoto, poi sogghignava amaramente.
In sua presenza, le nostre madri non erano più loro. Si ripassavano il rossetto sulle labbra nella via principale che portava alla drogheria, si ravviavano i capelli con le mani, e parlavano con un tono di voce soave al padre di Franco, un ometto tarchiato le cui guance cascanti e l’assenza di vivacità ci affascinavano – come aveva potuto un simile individuo generare una discendenza tanto splendida? Era chiaro che non si rivolgevano all’ometto che batteva con vigore sul registratore di cassa: da sotto le palpebre truccate, lanciavano sguardi furtivi ai lati. I loro pigolii da uccellini eleganti erano un canto rivolto a quel ragazzo poco più grande dei loro figli che sistemava la spesa nei sacchetti di carta. Édouard de Montaigne, a cui bisognava sempre pagare l’Ovomaltina non avendo lui mai avuto diritto alla benché minima paghetta, raccontava di aver visto sua madre infilare una banconota da venti franchi svizzeri nella tasca posteriore dei jeans di Franco, ridendo sfacciatamente. «Venti franchi, cazzo!» bofonchiava scuotendo la testa.
Franco Rossetti non sembrava rendersi conto di essere diverso, che noi dormivamo come signorine, rannicchiati sotto i piumoni, mentre lui si alzava alle cinque di mattina per le consegne. Guidava il furgoncino del padre da quando aveva tredici anni, e nessuno se ne preoccupava, come se si trattasse di una creatura a parte, non soggetta alle leggi degli uomini. Aveva una sorta di grazia disinvolta, un’eleganza selvaggia, e ci piaceva. In realtà, volevamo essere Franco Rossetti. Quando fissavamo in preda a un fascino inquieto gli aloni di sudore che gli chiazzavano la schiena, ci sorrideva, o ci faceva l’occhiolino. Gli eravamo grati di considerarci appartenenti alla sua stessa specie.
Anni dopo, quando i funghi allucinogeni si sarebbero mangiati una parte del suo cervello e lui avrebbe indossato bracciali di turchese e giubbotti con le frange, avremmo continuato a guardarlo con un misto di ammirazione e invidia. Emanava effluvi animaleschi, e parlava con un accento vallese che stranamente non intaccava il suo fascino. Malgrado i nostri vestiti su misura, le sigarette senza filtro e le mazzette di banconote che gonfiavano le tasche dei nostri soprabiti, la sua presenza ci riportava alla crudele realtà: saremmo rimasti sempre dei ragazzini.
Franco Rossetti si ricordava delle tre C al tempo in cui non formavano ancora una squadra. Nel magazzino, dove andavamo a trovarlo dopo le lezioni di sci, ci raccontava episodi della loro vita di prima.
Conosceva Charlie (che si chiamava ancora Charlotte) e Chris (che solo la madre chiamava Christine) da sempre. Aveva difficoltà a recuperare i dettagli, a ricordarsi le date, e questo ci innervosiva, in particolare innervosiva Serge Chubowska che sarebbe diventato ingegnere civile e annotava con cura monomaniacale in un quadernone nero le apparizioni di Chris. Franco serviva la famiglia di Chris Breitman al Palma, un residence di lusso sulle alture di Crans, addossato alla foresta, i cui appartamenti, moderni e tutti uguali, erano per lo più di proprietà di parigini, agiati, chic ed ebrei. Boria Tbilissi, il padre di Charlie, ebreo di Vladivostok, aveva fatto costruire uno chalet a Bluche, un paese meno rinomato, su un terreno in pendenza, a qualche chilometro dalla clinica dove era stato internato nel 1942, dopo avere attraversato la frontiera con le mani e le dita dei piedi congelate.
Franco esponeva nei dettagli le ordinazioni con una precisione scientifica: la vodka, l’hummus e i dadi Maggi dei Tbilissi, lo champagne Bollinger (almeno dieci bottiglie alla settimana!) dei Breitman, il formaggio per la fonduta, i panini al latte, la carne secca, il Cacolac (pare che Gilles, il fratello di Charlie, ne ingurgitasse in quantità assurde, a qualsiasi ora del giorno). Quando non si trattava di prodotti di consumo, la sua memoria sembrava infiacchirsi, come se la sua attività cerebrale fosse circoscritta alle funzioni di un registratore di cassa. Per lui Charlie e Chris non erano nient’altro che delle bambine more e timide, delle figure indistinte, contrariamente a quelle dei loro fratelli, che lo prendevano per una spalla o gli stringevano la mano, nei loro originali vestiti di tweed. Ma era chiaro che i suoi veri interlocutori, coloro a cui si rivolgeva con la naturalezza e la sicurezza che lo caratterizzavano da quando aveva scoperto il mondo del commercio, cioè prima di imparare a scrivere, erano i genitori. Boria e Salomé Tbilissi, Maurice e Mara Breitman, che lo baciavano, gli infilavano monete da cinque franchi svizzeri nella tasca della giacca a vento, e lo consideravano con la deferenza riservata agli uomini liberi.
Evocò – cosa che ci provocò qualche turbamento – gli assorbenti Vania, la cui quantità aumentò in modo considerevole nella famiglia Tbilissi intorno al 1962 (o ’63? o ’65?), articolo che non venne mai menzionato dai Breitman in alcuna lista – ma forse le ordinazioni fatte esclusivamente per telefono da Maurice Breitman potevano spiegare tale anomalia. C’era regolarmente lo smalto dal sapore amaro che si doveva far arrivare da Ginevra, per Charlie che si rosicchiava le unghie, cosa che irritava Salomé Tbilissi, un’egiziana dai capelli lucidi. «Come pelo di foca» diceva Franco, la voce roca, quasi si trattasse di una caratteristica erotica, e questo ci provocava dolorosi fremiti nei bermuda.
«Sembra che questa bambina non venga nutrita, è costretta a mangiarsi le dita» ripeteva Salomé Tbilissi, con voce irritata. Era sbalorditivo pensare che Charlie potesse avere la minima compulsione. Avevamo in mente le sue unghie curate, di un rosa delicato, il suo sorriso impenetrabile e gli occhi le cui palpebre non sbattevano mai, come se il suo cuore battesse al ritmo di un tempo geologico.
Possibile che avesse un sistema nervoso? Dei cupi tormenti?
Patrick Saincère, che era il più robusto e sanguigno tra noi, e si azzuffava regolarmente al Club con gli italiani che avevano fatto l’errore di sorridere o offrire da bere alla sua fidanzata, ci confessò anni dopo, la sera in cui fu pronunciata la sentenza del suo divorzio, che aveva fatto arrivare in segreto, oltre alle riviste pornografiche cui destinava la totalità delle sue finanze, il famoso smalto amaro di Ginevra. Franco glielo aveva consegnato in un sacchetto di carta, con la discrezione che era il suo codice d’onore, aggiungendovi una scatola di cioccolatini ripieni. Una volta a casa, Patrick Saincère, che a undici anni pesava sessanta chili e giocava come seconda linea al Rugby Club di Neuilly, aveva accarezzato il minuscolo flacone con le sue possenti mani. Aveva svitato con delicatezza il tappo e, catturato dagli effluvi che evocavano la farmacia, o l’obitorio, aveva sentito la testa girargli, catapultato in un mondo clandestino.
Quella sera, a Parigi, dopo avere ordinato delle magnum di champagne, allungando in modo rozzo banconote da cinque franchi a cameriere dallo sguardo assente, ci confidò, con la camicia su misura chiazzata di sudore, che durante tutti quegli anni non aveva potuto liberarsi delle sue reminiscenze. «Quel sapore di metallo, o di malattia, non ti abbandona mai. È qui! È qui!» ripeteva colpendosi la fronte con il palmo della mano. «Non mi ricordo niente, l’incontro con mia moglie, il nostro matrimonio, le vacanze, i weekend, non rimane niente. Ma quell’odore! È come un fottuto fantasma.»
A Franco Rossetti di Chris e Charlie non importava nulla. O meglio, gli ispiravano quella tenerezza mista a indifferenza che si prova per le sorelline, questi esseri così familiari che diventano, se non proprio insignificanti, comunque privi di mistero. Più tardi, quando sarebbero diventate quelle bellezze abbaglianti, e gli avrebbero buttato le braccia al collo, facendo aderire innocentemente il seno contro il suo petto, lui avrebbe sorriso, magnanimo, ma saremmo stati noi, gli osservatori impietriti della scena, a percepire la morbidezza della lana pregiata sulla nostra pelle – costretti a chiudere gli occhi, mentre un oceano infuocato ci si riversava nei polmoni.
Ma c’era Claudia. Anche se Franco considerava la vita con tranquillo pragmatismo, era sempre di buon umore e ci guardava senza capire quando noi lo interrogavamo come poliziotti fuori di testa riguardo a Chris e Charlie, aveva un lato debole segreto, una punta fredda piantata nel cuore: Claudia. Probabilmente non ne fu mai consapevole, ma in presenza di lei il suo corpo inviava segnali di angoscia, iniziava a rabbrividire, o si ripiegava su se stesso come se lo avesse colpito una palla di neve.
Franco ricordava la Maserati verde scuro che si era fermata proprio davanti alla drogheria, con un cauto ronzio, nel dicembre del ’62. Il cielo era coperto, quel giorno, e sulla neve ridotta a fanghiglia l’automobile sembrava fuori luogo quanto un pavone in...