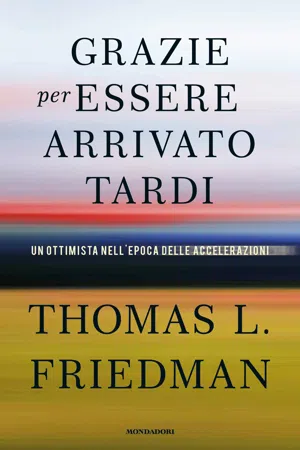Adesso che abbiamo definito quest’Epoca delle Accelerazioni, ci si pongono due domande, una d’istinto e una ragionata. La prima è: le cose stanno andando maledettamente troppo veloci? La seconda: dal momento che le forze tecnologiche che inducono questo cambiamento non hanno l’aria di voler rallentare, come adattarsi?
Se avete risposto sì alla prima domanda, vi assicuro che non siete i soli. Ecco la mia storia preferita nel libro di Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee La nuova rivoluzione delle macchine: al campione di scacchi olandese Jan Hein Donner fu chiesto come si sarebbe preparato a una partita contro un computer come il Deep Blue di IBM.
Lui aveva risposto: «Mi porterei un martello».
Donner non è il solo a fantasticare di fare a pezzi alcuni recenti sviluppi nel software e nell’intelligenza artificiale (ia) che stanno soppiantando gli uomini non solo nei lavori manuali, ma anche in compiti più intellettuali, perfino quelli dei campioni di scacchi. I lavori sono sempre andati e venuti, grazie alla distruzione creativa. Se i cavalli avessero potuto dire la loro, non ci sarebbero mai state le automobili. Oggi, però, gli sconvolgimenti sono più rapidi, perché i progressi tecnologici si autoalimentano, trascinandoci da una piattaforma all’altra e invadendo sempre più il mondo del lavoro.
Lo so bene, perché in quanto giornalista sessantatreenne ho vissuto in prima persona parecchi di questi cambiamenti di piattaforma, e li ho visti arrivare sempre più in fretta. Mi sto già preparando al giorno in cui avrò dei nipoti e uno di loro mi chiederà: «Nonno, che cos’è una macchina da scrivere?».
Ecco una breve storia di come io personalmente ho vissuto l’impatto del mutamento nel ritmo di cambiamento della tecnologia. Sono sicuro che molti lettori ci si riconosceranno.
Subito dopo la specializzazione in arabo e storia moderna del Medio Oriente a Oxford, nella primavera del 1978 sono stato assunto dalla United Press International (UPI), l’agenzia di informazioni giornalistiche, presso la sede di Londra a Fleet Street. Per scrivere i miei articoli in quella redazione londinese usavamo sia macchine da scrivere manuali sia i primi programmi di scrittura. Per quelli troppo giovani per potersela ricordare, About.com spiega che una «macchina da scrivere» era «una piccola macchina, elettrica o manuale, con tasti che riproducevano caratteri uno alla volta su un foglio inserito su un rullo». Wikipedia afferma che «le macchine da scrivere furono inventate negli anni Sessanta dell’Ottocento» e «ben presto divennero strumenti indispensabili praticamente per ogni scritto a eccezione della corrispondenza personale. Erano largamente usate da scrittori professionisti, negli uffici e per la corrispondenza d’affari nelle case private» fino alla fine degli anni Ottanta del Novecento, quando «i programmi di scrittura e i personal computer ... soppiantarono in larga misura le macchine da scrivere ... in Occidente».
Pensateci un attimo: scrittori, uomini d’affari e amministrazioni statali hanno usato fondamentalmente lo stesso strumento – la macchina da scrivere – per oltre un secolo, ossia per tre generazioni. Così lento era il ritmo del cambiamento tecnologico, pur essendo molto ma molto più rapido rispetto a prima della rivoluzione industriale. Ovviamente allora non lo sapevo, ma stavo iniziando la mia carriera nel giornalismo proprio agli sgoccioli della rivoluzione industriale – alla fine dell’era della macchina da scrivere – e alla vigilia della rivoluzione informatica.
E, una volta arrivati in fondo al XX secolo, quel progresso ha cominciato a investirci sempre più in fretta. Visto che avevo iniziato quand’eravamo ancora nella rivoluzione industriale, però, prima dovevo imparare a battere in fretta a macchina! Così, dopo essere stato assunto all’UPI nel 1978, per prima cosa mi iscrissi a un corso serale di stenografia e dattilografia, frequentato per lo più da giovani donne che aspiravano a un posto di segretaria.
A quel tempo non esistevano nemmeno i cellulari. Per questo ricevetti la mia prima grande lezione di giornalismo proprio in occasione del primo vero servizio giornalistico che l’UPI mi affidò dopo essere entrato nella redazione londinese. E quella lezione era: Non chiedere mai a un concorrente di reggerti il telefono.
In Iran era appena iniziata la rivoluzione islamica. A Londra, un gruppo di studenti iraniani favorevoli all’ayatollah Khomeini aveva assalito l’ambasciata iraniana, buttato fuori i diplomatici dello scià, e si era asserragliato nell’edificio principale. Ero riuscito a convincere i giovani rivoluzionari a lasciarmi entrare per parlare con alcuni di loro. Non ricordo ciò che mi dissero, ma qualunque cosa fosse ero così eccitato che dopo aver riempito il mio taccuino mi precipitai alla cabina telefonica accanto all’ambasciata per dettare il mio servizio alla redazione. Era una di quelle classiche cabine telefoniche inglesi tutte rosse. C’era una coda di sei o sette giornalisti – brizzolati veterani di Fleet Street – che aspettavano di poter usare il telefono per dettare i loro servizi. Attesi pazientemente il mio turno. Quando, dopo aver fatto la fila per una ventina di minuti, entrai nella cabina, raccontai tutto eccitato ai miei redattori ciò che avevo visto e sentito dagli studenti iraniani asserragliati nell’ambasciata, sfogliando le pagine del mio taccuino per non dimenticare nemmeno un dettaglio. A un certo punto il redattore a cui stavo dettando mi domandò un particolare, relativo all’edificio dell’ambasciata, che non sapevo. Così risposi: «Aspetta un attimo, vado a controllare».
Aprii la porta di quella cabina rossa e dissi al giornalista di Fleet Street in coda dopo di me: «Per favore, reggimi il telefono». Poi sfrecciai fuori per verificare quel dettaglio di poco conto.
Prima che avessi fatto due passi, il tizio in coda dopo di me s’infilò nella cabina, sbatté giù il ricevitore interrompendo la mia telefonata e, mentre componeva il numero del suo giornale, si girò a guardarmi e mi rivolse due parole che non dimenticherò mai: «Spiacente, amico».
Da allora non ho mai più chiesto a un concorrente di reggermi il telefono.
Ovviamente, in quest’epoca in cui i cellulari sono onnipresenti, nessun giornalista al mondo dovrà mai imparare – o insegnare – quella lezione.
Un anno dopo, nel 1979, l’UPI mi inviò a Beirut, durante la guerra civile, come corrispondente in seconda. La mia piattaforma tecnologica consisteva in una grossa macchina da scrivere manuale sulla quale battevo gli articoli, che poi inviavo alla sede di Londra via telex. Di nuovo, per quelli troppo giovani per poterselo ricordare, un telex è definito dal Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary come «un servizio di telecomunicazione costituito da una telescrivente connessa via cavo a centralini automatici». Ecco come trasmettevamo i nostri servizi: prima li battevamo a macchina su normali fogli bianchi per dattilografia, spaziatura doppia, tre soli paragrafi alla volta. Poi affidavamo quei tre paragrafi all’operatore del telex, il quale li codificava in un nastro perforato che veniva immesso in una grossa macchina sferragliante nel nostro ufficio. Da lì passava per le reti telefoniche globali da quel capo del mondo, attraversava l’oceano e fuoriusciva da un altro telex, all’altro capo del mondo, nel mio caso la sede londinese dell’UPI, prima, e poi la sede del «New York Times» a Manhattan.
Scrivere un articolo tre paragrafi alla volta, senza poter cambiare l’ordine delle frasi, cancellare o verificare l’ortografia, può essere un’impresa. Provare per credere! Io facevo così: scrivevo il mio servizio o commento dall’inizio alla fine, poi lo battevo a macchina una seconda volta, e da ultimo, quand’ero soddisfatto dei paragrafi e del loro ordine, e convinto di aver detto ciò che volevo, lo ricopiavo una terza volta, in pezzi di tre paragrafi ciascuno e lo consegnavo all’operatore perché lo trasmettesse. A Beirut il sistema telex passava per le Poste e Telecomunicazioni libanesi, ubicate al centro della città, proprio lungo la linea di demarcazione tracciata dalla guerra civile.
Nel 1981 andai a lavorare al «New York Times», dove per un anno mi occupai di economia e poi, nel 1982, fui mandato di nuovo a Beirut come caporedattore. Ci tornai con una macchina da scrivere portatile. La ricordo bene. Era una Adler tedesca con la custodia bianca. A quel tempo era la macchina migliore che si potesse acquistare, e mi costò la bellezza di trecento dollari. Quando ne entrai in possesso ricordo di aver pensato: «Adesso sono un vero corrispondente estero!». Ero così fiero di quella macchina, con i suoi tasti che ti davano un senso di solidità quando li battevi per produrre una lettera.
Così, mentre scrivevo questo libro, ho cercato con Google «macchina da scrivere portatile Adler» per rinfrescarmi la memoria circa il suo aspetto. Mi è caduto l’occhio sulla terza voce: rara piccola adler portatile vintage, d’antiquariato, germania, in vendita su eBay.
Ahi! Incredibile che la macchina su cui ho iniziato la mia carriera giornalistica quasi quarant’anni fa sia ora un oggetto «raro, vintage, d’antiquariato». Sembra si stia parlando di qualcosa risalente al 1878. Mi piacerebbe potervi mostrare una foto della mia, ma, ahimè, non ce l’ho più. È saltata in aria, con il resto del mio appartamento, a Beirut nei primissimi giorni della guerra israelo-palestinese del giugno 1982, quando due gruppi di rifugiati del Libano meridionale si contendevano gli appartamenti vuoti nel palazzo dove abitavo su Rue Bliss. Il gruppo che aveva perso distrusse l’intero edificio, uccidendo disgraziatamente la moglie e due figlie del mio autista, che si trovavano nel mio studio.
Ero nel Sud del Libano quando Israele lo invase nel giugno del 1982, e rimasi a Beirut per tutta l’estate. Il mio accordo con il «New York Times» prevedeva che mi sarei fermato lì fino alla partenza dal porto di Beirut dei combattenti dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina di Yasser Arafat, negoziata per il 21 agosto 1982. Volevo che quei due titoli a tutta pagina – «Israele invade» e «Arafat se ne va» – segnassero l’inizio e la fine del mio lavoro di corrispondente in Libano. Bene, quel giorno arrivò. Era una splendida mattina. Mi trovavo al porto con Peter Jennings di ABC News e insieme osservavamo la scena: guerriglieri palestinesi sui camion, che sparavano in aria con i loro kalashnikov, ricoprendoci di bossoli, mentre lasciavano Beirut alla volta dell’Algeria e della Tunisia, verso un futuro ignoto. Era uno spettacolo drammatico, toccante e incredibilmente pittoresco. Alla fine corsi alla sede della Reuters a Beirut, dove avevo una mia scrivania, tirai fuori la macchina da scrivere portatile e iniziai a raccontare tutto, tre paragrafi alla volta, riversando in quel capitolo conclusivo la passione e l’energia di un’intera estate.
Quando terminai l’articolo, lo consegnai all’operatore del telex. Lui lo trascrisse sul nastro perforato, ma, prima che potesse inviarlo agli uffici del «New York Times» negli Stati Uniti, le comunicazioni tra Beirut e il resto del mondo s’interruppero. A quel tempo, tutto passava per un unico cavo in una scatola di commutazione presso le Poste e Telecomunicazioni, e, per un qualche motivo, quel cavo era venuto giù. Rimasi tutta la notte vicino al telex, aspettando che resuscitasse per poter inviare il mio articolo a New York, ma l’attesa fu vana. Sì, ragazzi, c’erano un tempo e un luogo in cui accadevano cose del genere. Niente telefoni, niente telex, niente cellulari, niente Internet, niente di niente. Conservo ancora quel nastro perforato in una scatola da scarpe in cantina. La mattina dopo, il 22 agosto 1982, il «New York Times» uscì con un titolo a tutta pagina sulla partenza di Arafat da Beirut, autore «the Associated Press», che aveva inviato il suo servizio molte ore prima di me e prima che le Poste e Telecomunicazioni smettessero di funzionare.
Quando lasciai Beirut nel 1984, era appena iniziata la rivoluzione informatica digitale e il «New York Times» mi aveva mandato una cosa chiamata TeleRam Portabubble: un elaboratore di testi delle dimensioni di una valigia, con un minuscolo schermo e due coppette in cui inserire la cornetta del telefono, che trasmetteva il tuo servizio mediante onde sonore ai computer di prima generazione del «Times» a Times Square. Da Beirut passai a Gerusalemme, dal 1984 al 1988. Dapprima lavorai sul TeleRam anche lì e poi, più o meno nel mio ultimo anno in Medio Oriente, mi fu dato il primo computer da tavolo IBM con grossi floppy disk. Il ritmo del cambiamento stava iniziando ad accelerare un po’. Le mie piattaforme tecnologiche progredivano più in fretta.
Dopo Gerusalemme mi trasferii alla redazione di Washington, dove, a partire dal 1989, fui corrispondente diplomatico per il «New York Times». Ebbi un posto in prima fila nei viaggi con il segretario di Stato James A. Baker III in occasione della caduta del muro di Berlino e della fine della guerra fredda. Durante quelle trasferte usavamo portatili Tandy per scrivere e trasmettere utilizzando linee telefoniche a lunga distanza. Noi giornalisti diventammo esperti nello smontare i telefoni delle camere d’albergo di tutto il mondo per fissarvi i cavi dei nostri Tandy. Insieme al taccuino, dovevi sempre portarti appresso un piccolo cacciavite.
Quando passai a seguire la Casa Bianca con un nuovo presidente, Bill Clinton, nel 1992, nessuno che conoscessi aveva una email. Alla fine del suo secondo mandato, quasi tutti quelli che conoscevo ne avevano una. Il mio ultimo lavoro da corrispondente fu come esperto di economia internazionale per il «New York Times» dal 1993 a tutto il 1994. Iniziai a fare l’editorialista nel gennaio del 1995. Quello stesso anno, il 9 agosto, una startup chiamata Netscape si quotò in Borsa vendendo una cosa chiamata browser, che avrebbe portato Internet, le email e infine il World Wide Web sullo schermo di un computer come niente prima di allora. L’offerta pubblica di Netscape – il prezzo delle cui azioni era stato fissato a 28 dollari, era già salito a 74,75 a mezzogiorno e aveva chiuso a 58,25 – avrebbe avviato il boom e la bolla di Internet.
Da allora sono passato per una rapida successione di computer da tavolo e portatili Dell, IBM e Apple, con una connettività sempre più veloce al web. Da un decennio a questa parte ho assistito alla rapida riduzione delle opportunità di lavoro nel mondo della stampa, a mano a mano che sempre più quotidiani chiudevano, sempre più inserzioni pubblicitarie passavano sul web e sempre più persone leggevano il giornale su dispositivi mobili. Osservavo i giornalisti che passavano dallo scrivere un servizio al giorno per l’edizione cartacea del «New York Times» a doverne scrivere molti per tenere aggiornata l’edizione web, e intanto intervenire su Twitter e Facebook e commentare video. Mi ha ricordato esattamente il periodo in cui lavoravo a Beirut per l’agenzia di stampa e le cose che dovevo freneticamente fare tutte insieme – trasmettere ultime notizie, fotografie e spot radiofonici – che mi facevano tanto desiderare di essere un giornalista con un unico incarico alla volta. Adesso i reporter dei giornali, proprio come quelli che lavorano per le agenzie di stampa, hanno un incarico al secondo.
Col passare degli anni, vedo il mio settore, i miei strumenti e gli strumenti di altri lavoratori di concetto cambiare più in fretta che mai, grazie alla Supernova. Nel maggio del 2013 ero in fila per il controllo passaporti all’aeroporto londinese di Heathrow. A un certo punto l’uomo davanti a me si è girato, mi ha detto di essere un mio lettore e ci siamo messi a conversare amabilmente. Gli ho domandato cosa facesse. Mi ha risposto di chiamarsi John Lord e di lavorare nel campo dei software.
«Che tipo di software?» ho voluto sapere. Mi ha spiegato che l’obiettivo della sua società era quello di rendere «obsoleti gli avvocati» ovunque possibile, creando applicazioni software che permettessero sempre più agli individui di svolgere operazioni legali senza dover ricorrere a un avvocato. In effetti, Neota Logic, la sua società, ha come obiettivo quello di migliorare l’accesso alle consulenze e alla giustizia per «l’oltre 40 per cento degli americani che non si possono permettere un avvocato quando ne hanno bisogno», per scrivere testamenti e documenti legali elementari e perfino per gestire eventi cruciali come pignoramenti della casa, abusi domestici o tutela dei minori.
L’attività di Neota Logic rientra in un nuovo f...