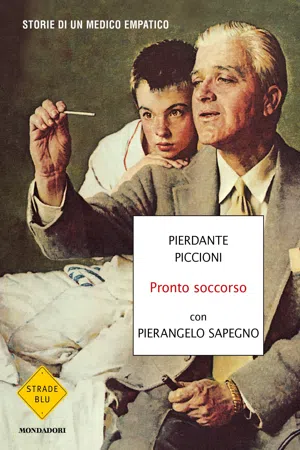Guardo la finestra. I vetri sono come imburrati da questa luce quasi fisica che si rovescia sullo scrittoio davanti a me, con le buste aperte, i fogli composti su due pile, una penna grigia e il computer spento. Sullo scaffale laccato ci sono altri faldoni ammucchiati, e le pareti hanno lo stesso odore della tinta, di gheriglio di noce, come di vaniglia, o di vernice da davanzale. Sono tornato dov’ero quando non sono esistito, a fare tutto quello che ho fatto senza sapere d’averlo fatto. Eccolo, il dottor Amnesia, il dottore senza memoria, che vive la stessa pena delle persone che visita.
Ho perso la memoria in un incidente d’auto, risvegliandomi dodici anni prima. Cioè, ho avuto l’incidente il 31 maggio 2013 e sono tornato alla vita dopo sei ore di coma, convinto che fosse il 25 ottobre 2001. Dodici anni della mia vita erano stati cancellati. Ci ho messo del tempo ad accettare il fatto che vivevo nel presente e non nel passato, ma quando ci sono riuscito ho deciso di tornare a fare quello che facevo, il medico del pronto soccorso, con tutte le mie forze, contro tutto e tutti. Ho dovuto studiare di nuovo, da capo, ho dovuto lottare. E ho dovuto soffrire. Ma adesso sono qui.
Mi sono chiesto tante volte perché sono tornato. Il presente è molto diverso dal passato, e ho dovuto abituarmi. Certe volte guardo il mondo ancora con gli occhi di un estraneo, tentando di ricucire i fili interrotti della mia vita perduta, come se provassi a farmi tornare in mente il sogno che stavo facendo. Alla fine, però, tutte le volte il senso di disagio mi artiglia, lasciandomi prigioniero del mio destino.
Non so neppure dire se questa sia l’unica cosa che so fare. È quello che mi piace fare, però, in questo posto di frontiera, fra la vita e la morte, il male e la salvezza. Un medico ama la vita. Io sto cercando la mia perché la amo.
Questo è il mio ufficio. È strano come lo guardo, come se ci dovessi parlare.
Sono le 7.40 del 20 febbraio 2015, e ho ricominciato a lavorare da pochi giorni. Mi levo il soprabito grigio tutto stazzonato, che ho da più di quindici anni, da quando ho vissuto senza poter trattenere i ricordi, la mia vita, dentro di me.
Perdere la memoria è una condizione surreale: ti senti come una pianta, un oggetto, un mobile, perché non sei esistito, se non per gli altri. Posso aver salvato una vita o posso averla anche tolta, ma quel che ho fatto è rimasto solo negli occhi delle persone che mi guardano, sulle loro rughe, sui giorni che hanno passato vicino a me senza che io lo sapessi, su tutto questo tempo che ha riempito altro tempo lasciando tracce sul mio corpo, ma non nella mia anima.
Posso essermi anche innamorato, in quei dodici anni. Ma per me non è successo, io non sono esistito. Quando ero ricoverato in ospedale dopo l’incidente, una donna se n’è andata via in lacrime perché non la riconoscevo. Piangeva disperata. Ancora adesso non so se c’era stato qualcosa fra noi.
Ogni tanto ci penso, quando ascolto della musica. A me piace Guccini: lo sento se mi devo rilassare, ho tutti i suoi cd in macchina. Ma Guccini viene dal 2001, tutte le sue canzoni più famose appartengono al passato. A me piace la musica degli anni Novanta, e quella ancora precedente. O meglio, di ieri. Per me è come se avessi appena spento la radio prima di andare a letto.
In molte cose sono rimasto un uomo del passato. Forse è normale, avendo perso un pezzo così grande del presente. Ma per un medico del passato è difficile curare le malattie di oggi. Eppure io ho studiato di nuovo tutto, come un perfetto secchione. Ho affrontato nuovi esami, colloqui, test. Sono stato trattato come una cavia, un matto, un mendicante. Ma ce l’ho fatta, e sono qui.
Solo che ogni tanto vado in apnea. Se mi prende una crisi, salgo in auto e faccio un giro ascoltando La locomotiva o Piccola città. Le crisi mi vengono, appunto, tutte le volte che non sopporto questa mia diversità. La gente non capisce. Nessuno lo capisce, forse nemmeno mia moglie. E nemmeno i miei figli. Con loro ho ricucito il rapporto, adesso ci vado a correre insieme. Devo farlo perché mi è rimasta una leggera zoppia dopo l’incidente: avevo un’emiparesi, che è guarita quasi del tutto. Vado a correre la sera, quando torno dal lavoro, oppure al mattino presto. Poi mi metto in macchina e vengo qui in pronto soccorso. Vestito sempre con questo cappotto sdrucito e in jeans. In auto ascolto Rtl 102.5 e Guccini. Altrimenti, cerco qualche stazione che trasmetta rigorosamente musica di qualche anno fa. La musica è l’arte più grande, fa parte dei nostri sensi. E io non riesco a adattarmi a quella nuova.
In ospedale, però, ho una sensazione strana: amo i miei malati, ma ne ho paura. È il mio buco nero che mi ha lasciato questo senso di insicurezza. Eppure, quando ci penso, non mi so dare una risposta. È questa la mia angoscia: su di me non so rispondere.
Adesso mi hanno chiamato dalla sala antishock. Nel pronto soccorso che dirigo è la prima struttura che incontri uscendo dagli studi dei medici. Se non c’è nessuno la porta è aperta. Quando la porta è chiusa significa che i sanitari sono impegnati a curare qualche persona in condizioni gravi. Per me è una specie di luogo sacro, il mio sancta sanctorum, dove i sacerdoti e le sacerdotesse del pronto soccorso riescono a dare il meglio di sé, in termini sia umani sia professionali. È il posto dove si trova la tecnologia più sofisticata: i ventilatori polmonari, l’ecografo, il defibrillatore. È il posto dove salvi la pelle alla gente, quando va bene. E quando va male, diventa la camera o l’anticamera della morte.
Percorro pochi metri e apro la porta scorrevole.
«Cos’ha il paziente?» chiedo.
Davanti a me c’è la dottoressa Gabriella Delfini. È giovane, alta, ha lunghi capelli rossi naturali e occhi verdi pieni di energia, nascosti in parte da occhiali leggeri. È una bella ragazza. È l’ultima arrivata, in servizio da pochi giorni, e professionalmente è ancora acerba. In fondo si è specializzata solo da pochi mesi, è al suo primo vero lavoro. Ma ha stoffa e carattere. E poi è una donna, diventerà sicuramente un ottimo medico.
Quando mi risponde sembra che gli occhi le si assottiglino. «Lo hanno appena portato con il 118 per insufficienza respiratoria acuta» dice.
Ho guardato di sfuggita il malato steso, un uomo anziano, con radi capelli bianchi e le braccia allungate in maniera informe sulla barella, come se fossero staccate dal corpo. Il suo sguardo svela una specie di patina, una vitrea impenetrabilità.
«Sto leggendo la documentazione per capirci meglio» aggiunge lei, porgendomi un foglio bianco, di quelli piccoli, dove si scrivono le ricette ripetibili. «Ma c’è questa lettera del medico curante che mi ha lasciata molto perplessa.»
Ho preso il foglio e ho iniziato a leggere: «Si richiede ricovero urgente per il signor Bernardi Sandro (attualmente in Adi-Cp) per insufficienza respiratoria acuta con silenzio funzionale polmone sx (metastasi da Hcc), deficit totale di forza arto inferiore dx, tachicardia (168) alternata a bradicardia (54) con ipotensione grave».
Al pronto soccorso, così come in medicina più in generale, tra gli operatori si parla un proprio linguaggio interno. Spesso si usano acronimi, ovviamente condivisi, che vanno spiegati ai non addetti ai lavori. Adi sta per assistenza domiciliare integrata, ed è una delle modalità di gestione dei pazienti a domicilio. Cp vuol dire cure palliative e credo non ci sia molto da spiegare: sono le terapie per alleviare le sofferenze a quei pazienti che non hanno nessuna possibilità di guarigione. Hcc indica un epatocarcinoma, un tumore maligno del fegato.
In sostanza, il medico curante aveva mandato a morire in ospedale un paziente con un tumore al fegato allo stadio terminale, che in più aveva avuto un ictus.
Da quando sono tornato al lavoro poteva essere la prima morte alla quale assistevo, da medico del presente. Nei primi mesi dopo il mio risveglio con il buco nero, avevo perso mio padre. L’avevo visto andarsene fra le mie mani, e con lui avevo perso anche l’ultimo aggancio che mi era rimasto con il mio passato, perché i vecchi, alla fine, sono un po’ uomini di ieri che sopravvivono nel tempo, tenendoci legati alla vita che viene da lontano.
Questa volta, però, è diverso. Dopo quello che mi è successo, vivo la morte come una condizione naturale ed emotiva insieme. Non è il corpo che si spegne a lasciarmi nella disperazione, ma le emozioni che perde, il senso della vita di quella persona che smette di esistere. I corpi, in fondo, sono tutti uguali, possono essere più o meno belli secondo i parametri del tempo, ma hanno tutti due polmoni, un cuore, un cervello, due gambe, due braccia, le vene, le arterie e il fluire del sangue. Sono le nostre sofferenze e le nostre gioie che ci rendono unici e irripetibili, così diversi fra noi. Da quando quei dodici anni della mia memoria sono morti dentro di me, so che il dolore è questo: la mancanza di ciò che rappresenta quel corpo. Quell’uomo in barella stava lasciando per sempre le emozioni che io sto cercando.
Certo, l’ospedale non è un bel posto per morire.
Al contrario, quando attivi l’Adi-Cp, significa che hai già deciso che il paziente, qualunque cosa succeda, finirà i propri giorni a casa sua. Lo hai spiegato bene, concordandolo con il malato stesso, e soprattutto con i familiari.
«Il paziente risponde agli stimoli e tenta di parlare, ma escono solo parole incomprensibili. Ha un Gcs tra 8 e 9» mi sta dicendo Gabriella. Poi, quasi mi avesse letto nel pensiero, aggiunge: «I parenti non sono ancora arrivati».
Per tutti gli operatori sanitari il Gcs è il Glasgow Coma Scale, un sistema rapido per capire se hai problemi neurologici urgenti. Valuta tre parametri, assegnando un punteggio crescente: se apri gli occhi spontaneamente, come rispondi alle domande e come muovi braccia e gambe. Più sei normale più punti prendi. Se in totale fai 15 punti non hai problemi neurologici urgenti. Se fai 3 punti sei in coma profondo. Se ne fai 8 bisogna decidere se metterti un tubo in gola per aiutarti a respirare. Ecco perché Gabriella precisa: «È un codice rosso e ho già chiamato il r...