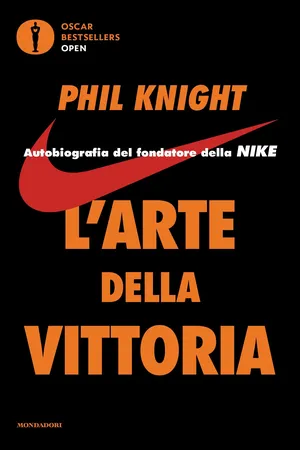Quando sollevai l’argomento con mio padre, quando trovai il coraggio di parlargli della mia Idea Folle, pensai bene di farlo la sera subito dopo cena. Era sempre il momento migliore, con papà. Era rilassato, sazio, allungato sulla sua poltrona reclinabile in vinile nell’angolino della tv. Se butto indietro la testa e chiudo gli occhi, sento ancora il pubblico che ride, le colonne sonore da quattro soldi delle sue serie preferite, Carovane verso il West e Gli uomini della prateria.
Il suo beniamino era Red Buttons. Ogni episodio cominciava con Red che cantava: Ho ho, hee hee… strange things are happening.
Portai vicino a lui una sedia con lo schienale diritto, gli sorrisi debolmente e aspettai la pubblicità. Mi ero ripassato mentalmente la parte, ancora e ancora, soprattutto la battuta d’inizio. Alloooora, papà, ricordi quell’Idea Folle che avevo a Stanford…?
Era uno degli ultimi corsi, un seminario sull’imprenditorialità. Avevo fatto una ricerca sulle scarpe che si era trasformata, dal solito compito, in un’ossessione totale. Essendo un podista, avevo una certa conoscenza delle scarpe da corsa. Essendo un patito di economia, sapevo che le macchine fotografiche giapponesi erano riuscite a penetrare un mercato dominato un tempo dai tedeschi. Perciò, nel mio studio sostenevo che le scarpe da corsa giapponesi avrebbero potuto fare lo stesso. L’idea m’interessava, poi m’ispirò, infine mi catturò. Sembrava così ovvio, così semplice, così potenzialmente enorme.
Passai settimane e settimane su quello studio. Mi trasferii in biblioteca e divorai tutto ciò che riuscii a trovare su import ed export, su come si avvia un’impresa. Alla fine, come richiesto, tenni una presentazione formale ai miei compagni di corso, che reagirono con formale noia. Nessuno fece domande. Accolsero la mia passione e il mio fervore con sospiri afflitti e sguardi vacui.
Il professore pensò che la mia Idea Folle meritasse: mi diede il massimo. Ma la cosa finì lì. O almeno, sarebbe dovuta finire lì. Io però non avevo mai smesso di pensarci. Per tutto il tempo che rimasi ancora a Stanford, durante ogni corsa mattutina e fino a quel momento nell’angolo della tv, avevo ponderato di andare in Giappone, trovare un’azienda che produceva scarpe, decantare a loro la mia Idea Folle, nella speranza che reagissero con più entusiasmo dei miei compagni, che volessero entrare in affari con un ragazzino timido, pallido, magro come un chiodo del sonnacchioso Oregon.
Mi ero trastullato anche con l’idea di fare una deviazione esotica andando e tornando dal Giappone. Come posso lasciare il mio segno nel mondo, pensavo, se prima non ci vado e lo vedo? Alla vigilia di una corsa importante vuoi sempre vedere la pista. Un viaggio zaino in spalla intorno al globo avrebbe potuto essere la cosa giusta, ragionavo. Non si parlava di «101 cose da fare…» a quel tempo, ma immagino che assomigli a ciò che avevo in mente. Prima di morire, di diventare troppo vecchio o logorato dalle inezie di ogni giorno, volevo visitare i posti più belli e fantastici del pianeta.
E i più sacri. Naturalmente volevo assaggiare cibi diversi, ascoltare lingue diverse, immergermi in culture diverse, ma quello che davvero volevo con tutto il cuore era un contatto con la C maiuscola. Volevo sperimentare ciò che i cinesi chiamano Tao, i greci Logos, gli indù Jñāna e i buddisti Dharma. Ciò che i cristiani chiamano Spirito. Prima di cominciare il mio personale viaggio nella vita, pensavo, fatemi capire il grande viaggio dell’umanità. Fatemi esplorare i templi, le chiese e i santuari più belli, le vette e i fiumi più sacri. Fatemi sentire la presenza di… Dio?
Sì, mi dissi, sì. In mancanza di una parola migliore, Dio.
Ma prima mi serviva l’approvazione di mio padre.
Non solo, mi servivano i suoi soldi.
Avevo già accennato al mio desiderio di fare un lungo viaggio, l’anno prima, e non mi era parso contrario. Ma di certo se n’era dimenticato. E di certo mi stavo allargando, aggiungendo alla proposta originaria la mia Idea Folle, la richiesta sfacciata di una deviazione fino… in Giappone? Per fondare una società? Quando si dice lavoro sprecato.
Di certo l’avrebbe considerato un passo troppo lungo.
E un passo maledettamente costoso. Avevo qualche soldo messo da parte quand’ero nell’esercito e dai vari lavori part-time delle ultime estati. Soprattutto, avevo in mente di vendere la mia macchina, una MG bialbero del 1960 rosso scuro con pneumatici da corsa. (La stessa guidata da Elvis in Blue Hawaii.) Il che ammontava a 1500 dollari, del tutto insufficienti, stavo dicendo a mio padre. Lui annuiva, faceva «ha ha, mm mm», con gli occhi che guizzavano dalla tv a me, e viceversa, mentre io gli spiegavo tutto.
Ti ricordi che ne avevamo parlato, papà? Che ti avevo detto che volevo vedere il Mondo?
L’Himalaya? Le piramidi?
Il Mar Morto, papà? Il Mar Morto?
Be’, ehm, pensavo di fare anche un salto in Giappone, papà. Ti ricordi la mia Idea Folle? Le scarpe da corsa giapponesi? Sì? Sarebbe grandioso, papà. Grandioso.
Ci stavo dando sotto, avevo adottato una tattica di vendita aggressiva, molto aggressiva, perché avevo sempre odiato vendere e le possibilità di quella vendita, in particolare, erano pari a zero. Mio padre aveva già sborsato centinaia di dollari per l’università dell’Oregon, e altre migliaia per Stanford. Era il proprietario dell’«Oregon Journal», un lavoro sicuro che bastava a pagare tutte le comodità di cui godevamo, compresa la nostra spaziosa casa bianca in Claybourne Street, nel quartiere periferico più tranquillo di Portland, Eastmoreland. Ma i soldi mica li fabbricava.
E poi eravamo nel 1962. A quel tempo la Terra era più grande. Benché gli esseri umani stessero cominciando a percorrere l’orbita del pianeta in navicelle spaziali, il 90 per cento degli americani non era mai salito su un aereo. La donna o l’uomo medi non si erano mai avventurati a più di 100 chilometri dalla porta di casa, per cui parlare di un giro del mondo in aereo avrebbe innervosito qualunque padre, e tanto più il mio, visto che il suo predecessore al giornale era morto in un incidente aereo.
A parte i soldi, a parte le preoccupazioni per la mia sicurezza, l’intera faccenda era totalmente campata in aria. Ero consapevole che ventisei nuove imprese su ventisette fallivano, e anche mio padre lo era, e l’idea che ci si potesse assumere un rischio così colossale andava contro tutte le sue convinzioni. Per molti versi mio padre era un conformista episcopaliano, credeva in Gesù Cristo. Ma venerava anche un’altra divinità segreta: la rispettabilità. Una casa in stile coloniale, una bella moglie, figli obbedienti, a mio padre piaceva possedere queste cose, ma quello che davvero apprezzava era che amici e vicini sapessero che le possedeva. Gli piaceva essere ammirato. Gli piaceva nuotare ogni giorno a vigorose bracciate seguendo la corrente. Girare il mondo per diletto, quindi, semplicemente non avrebbe avuto senso per lui. Non era cosa da farsi. E di sicuro non da figli rispettabili di uomini rispettabili. Erano cose che facevano i figli degli altri. Roba da beatnik e hipster.
Forse il principale motivo della fissazione di mio padre per la rispettabilità era la paura del suo caos interiore. Lo intuivo, visceralmente, perché di tanto in tanto quel caos si sprigionava. Senza preavviso, a tarda sera, il telefono in anticamera squillava e, quando rispondevo, all’altro capo c’era sempre la stessa voce cavernosa. «Vieni a recuperare il tuo vecchio.»
M’infilavo l’impermeabile – chissà perché, quelle sere cadeva sempre una pioggia fina fina –, salivo in macchina e andavo in città, al club di mio padre. Lo ricordo con la stessa chiarezza con cui ricordo la mia camera, quel club. Centenario, con le librerie di rovere fino al soffitto e quelle vecchie poltrone con lo schienale alto e i poggiatesta laterali, sembrava il salotto di una casa di campagna inglese. In altre parole, assai rispettabile.
Trovavo mio padre sempre allo stesso tavolo, nella stessa poltrona. Lo aiutavo gentilmente ad alzarsi in piedi. «Stai bene, papà?» «Ovvio che sì.» Lo guidavo fuori, alla macchina, e per tutta la strada del ritorno facevamo come se niente fosse. Sedeva perfettamente eretto, quasi regale, e parlavamo di sport, perché parlare di sport era il mio modo di distrarmi, di calmarmi nei momenti di stress.
Lo sport piaceva anche a papà. Era sempre rispettabile, lo sport.
Per questi e per decine di altri motivi mi aspettavo che accogliesse il mio imbonimento nell’angolo della tv con un’alzata di sopracciglia e una fulminea mortificazione. «Ah ah, l’Idea Folle. Neanche a pensarci, Buck». (Il mio nome era Philip, ma mio padre mi chiamava sempre Buck. In effetti, mi chiamava così da prima che nascessi. La mamma mi raccontava che le accarezzava il ventre chiedendo: «Come sta il piccolo Buck, oggi?».) Ma quando smisi di parlare, di perorare la mia causa, mio padre si raddrizzò sulla poltrona reclinabile in vinile e mi lanciò una strana occhiata. Disse che aveva sempre rimpianto di non aver viaggiato di più da giovane. Disse che un viaggio avrebbe potuto essere il tocco finale alla mia istruzione. Disse un sacco di cose, tutte incentrate più sul viaggio che sull’Idea Folle, ma non avevo nessuna intenzione di correggerlo. Non mi sognavo di protestare, perché in fin dei conti mi stava dando la sua benedizione. E i suoi soldi.
«Okay» disse. «Okay, Buck. Okay.»
Lo ringraziai e mi allontanai di gran carriera, prima che cambiasse idea. Solo più tardi mi resi conto, con una fitta di rimorso, che il fatto che mio padre non avesse viaggiato era un ulteriore motivo, forse il principale, per cui volevo andare. Questo viaggio, questa Idea Folle, era un modo sicuro di diventare diverso da lui. Meno rispettabile.
O forse non meno rispettabile. Forse soltanto meno ossessionato dalla rispettabilità.
Il resto della famiglia non fu altrettanto solidale. Quando la nonna venne a conoscenza del mio itinerario, una tappa in particolare la fece inorridire. «In Giappone!» gridò. «Ma perché, Buck, soltanto pochi anni fa i giapponesi ci volevano morti! Non ti ricordi? Pearl Harbor! Quei musi gialli hanno provato a conquistare il mondo! Qualcuno di loro nemmeno sa che hanno perso! Se ne stanno ancora nascosti! Potrebbero farti prigioniero, Buck. E cavarti gli occhi. Si sa che lo fanno: gli occhi.»
Volevo bene alla madre di mia madre, che chiamavamo nonna Hatfield. E capivo la sua paura. Il Giappone era il posto più lontano che potesse esistere da Roseburg, Oregon, la cittadina agricola dov’era nata e aveva sempre vissuto. Ci avevo passato molte estati, con lei e nonno Hatfield. Quasi ogni sera sedevamo in veranda, ad ascoltare il gracidio delle rane toro che facevano a gara con la radio a mobile, all’inizio degli anni Quaranta sempre sintonizzata sui notiziari di guerra.
Che davano sempre cattive notizie.
I giapponesi, ci veniva ripetuto, non perdevano una guerra da duemilaseicento anni, e pareva proprio che non avrebbero perso nemmeno quella. Una battaglia dopo l’altra subivamo una sconfitta dopo l’altra. Alla fine, nel 1942, Gabriel Heatter della Mutual Broadcasting aprì il radiogiornale della sera con un grido penetrante. «Buonasera a tutti. Buone notizie stasera!» Gli americani avevano finalmente vinto una battaglia decisiva. I critici stigmatizzarono quel tifo spudorato, l’abbandono di ogni pretesa di obiettività giornalistica, ma l’opinione pubblica odiava a tal punto il Giappone che i più salutarono Heatter come un eroe popolare. E da allora lui aprì ogni trasmissione in quel modo. «Buone notizie stasera!»
È uno dei miei primi ricordi. Nonna e nonno Hatfield accanto a me sulla veranda, il nonno che sbucciava una mela Gravenstein con il suo temperino e me ne porgeva una fetta, poi ne mangiava una lui, poi ne porgeva una a me, e così via, finché la distribuzione della mela rallentava marcatamente. Haetter stava per cominciare. Sssh! Zitti! Ci vedo ancora che mastichiamo mele e fissiamo il cielo notturno, talmente ossessionati dal Giappone da aspettarci quasi di vedere gli Zero giapponesi sfrecciare davanti a Sirio. Non stupisce che la prima volta che salii su un aeroplano, proprio in quel periodo, avessi domandato: «Papà, i giapponesi ci abbatteranno?».
Sebbene nonna Hatfield mi avesse fatto drizzare i capelli sulla nuca, le dissi di non preoccuparsi. Sarei stato benissimo. Le avrei anche portato un kimono.
Le mie sorelle, le gemelle Jeanne e Joanne, di quattro anni più piccole di me, non parevano preoccuparsi proprio di dove andassi o cosa facessi.
E la mamma, per quel che ricordo, non parlò. Di rado parlava. Ma stavolta c’era qualcosa di diverso nel suo silenzio totale. Esprimeva consenso. E perfino orgoglio.
Trascorsi settimane a leggere, pianificare e prepararmi per il viaggio. Feci lunghe corse, meditando ogni dettaglio mentre gareggiavo con le oche selvatiche che volavano sopra la mia testa nella loro compatta formazione a V. Avevo letto da qualche parte che le oche in coda alla formazione, che veleggiano nella scia, devono fare uno sforzo pari solo all’80 per cento di quello compiuto dalle compagne che volano davanti. Qualunque podista lo capisce. Chi tira la volata fatica sempre di più e corre maggiori rischi.
Molto prima di parlare con mio padre, avevo già deciso che sarebbe stata una buona cosa avere un compagno di viaggio, e che quel compagno doveva essere il mio amico di Stanford, Carter. Benché fosse stato una star del basket al William Jewel College, non era il tipico atleta tutto muscoli. Portava occhiali spessi e leggeva libri. Bei libri. Era uno con cui era facile parlare, e anche stare zitti: due qualità altrettanto importanti in un amico. Essenziali in un compagno di viaggio.
Ma Carter mi rise in faccia. Quando gli sciorinai l’elenco dei posti che volevo vedere...