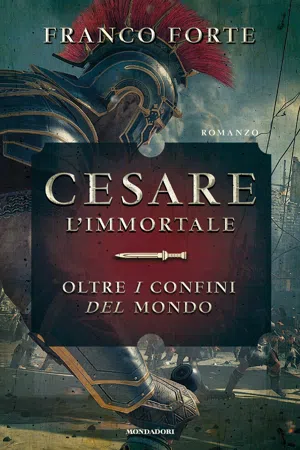Nonostante il mare piatto come una lastra di bronzo, su cui il sole si rifletteva spandendo raggi infuocati, le navi della piccola flotta di Gaio Giulio Cesare procedevano a gran velocità, sospinte dal movimento ritmico e poderoso impresso dai vogatori, che seguivano una progressione di colpi scandita dai tamburi dei capivoga.
Decimo aveva dato ordine perché gli scafi solcassero il mare in modo rapido e sicuro, ma senza costringere i rematori a uno sforzo troppo elevato, anche perché a bordo non c’erano schiavi ma soldati della legione, e per quanto vogare fosse un esercizio importante per mantenere in forma gli uomini, sarebbe stato insensato portarli oltre i limiti e rischiare che crollassero per la fatica.
Cesare era sceso già diverse volte nei ponti inferiori dell’esareme per osservare la perfetta sincronia dei vogatori, che, seduti praticamente uno sopra l’altro negli spazi angusti di solito riservati agli schiavi, versavano sudore mentre tendevano i muscoli delle braccia, della schiena e delle gambe. Per orinare avevano a disposizione delle anfore, una per ogni fila di tre rematori, ma fin troppi di loro preferivano farla per terra, dove l’urina si mischiava al sudore sollevando nel ventre della nave un odore acre e pungente, che si insinuava nelle narici fino ad arrivare al cervello.
Nonostante il puzzo, Cesare aveva portato il conforto della sua presenza a tutti quegli uomini che si affaccendavano intorno ai remi, e sapeva che altrettanto avevano fatto i comandanti delle altre navi.
«È importante che capiscano che non stanno scontando una punizione» gli aveva spiegato Decimo, «ma che stanno operando per il bene di tutta la flotta.»
Adesso Gaio si trovava sul castello di comando dell’esareme, insieme ai suoi ufficiali, e osservava il profilo della costa disegnato a poche miglia da dove le imbarcazioni filavano agili e sicure sull’acqua. Avevano individuato solo un paio di piccoli porti di pescatori, e ormai da diverso tempo si scorgevano unicamente grandi foreste che raggiungevano il mare, arrestandosi su contrafforti rocciosi che non consentivano l’approdo.
«Secondo le carte dovremmo essere in prossimità dei territori dei Pictones» disse Decimo battendo il dito su alcune pergamene. «Dovrebbe essere il posto giusto per fermarci e fare razzia.»
Cesare annuì. Dopo avere navigato lungo le coste iberiche, avevano affrontato un tratto di oceano aperto, per poi deviare ancora verso nordest e raggiungere i litorali della Gallia celtica, territori che conosceva bene e che avevano fatto da palcoscenico alle sue più grandi vittorie.
«Perché dobbiamo fermarci ancora?» chiese Cicerone dallo sgabello su cui era seduto, un poco in disparte rispetto a tutti loro, con una coppa di vino in mano.
Cesare lo studiò per qualche istante, poi fece un cenno a Decimo, perché rispondesse lui al laticlavius.
«Dobbiamo fare rifornimenti» spiegò questi raddrizzandosi. «E, dato che non possiamo contare sulle leggi di Roma per sequestrare beni alle popolazioni locali senza sollevare le loro proteste, saremo costretti a combattere.»
«E se dobbiamo farlo» intervenne Cesare, «allora preferisco attaccare una città celtica, come già ho fatto in passato. So come sono fatte le loro fortificazioni, e so come possiamo conquistare le loro città.»
Cicerone restò a guardarli con un mezzo sorriso, poi scosse la testa.
«La situazione è paradossale, non convenite?» disse rivolgendosi a tutti i presenti nella sala, fra cui il sempre silenzioso Bruto, che ostentava una smorfia accigliata mentre disdegnava il vino e se ne stava in un angolo a braccia conserte.
«Perché dici questo?» gli chiese Decimo.
«Perché se i celti Pictones non vi fanno paura, di certo dovrebbero inquietarvi le guarnigioni della Repubblica di stanza da queste parti. Sarà loro dovere difendere le popolazioni conquistate proprio da te, Cesare, e che ormai appartengono alla giurisdizione dell’Urbe.»
Per un attimo vi fu silenzio, poi Cesare scoppiò a ridere.
«Hai ragione» concordò raggiungendo il tavolino accanto a Cicerone, dove c’era la brocca di vino da cui il suo vice attingeva con encomiabile parsimonia. Se ne versò una coppa abbondante, l’assaggiò, convenne che non era davvero niente male, poi riprese a parlare, rivolgendosi a tutti: «Noi non attaccheremo le nostre legioni e non uccideremo soldati di Roma» assicurò. «Individueremo un oppidum dei Pictones, una delle loro città fortificate, e faremo in modo che si arrendano prima ancora di dare battaglia. A quel punto prenderemo ciò che ci serve per continuare il viaggio e torneremo a imbarcarci prima che uno dei loro messaggeri arrivi a qualche castrum di stanza in queste regioni per chiedere soccorso.»
«Come fai a sapere che si arrenderanno?» intervenne bruscamente Bruto, fissandolo torvo. Era chiaro che qualcosa di torbido si agitava dentro di lui, e Cesare ancora non riusciva a capire di che cosa si trattasse. «Potrebbero decidere di combattere, perché quei popoli sono stati sottomessi, ma mai davvero domati, e tu lo sai bene.»
Cesare inspirò profondamente, prima di rispondere, ma Cicerone fu più rapido e lo anticipò.
«Io credo che il nostro comandante sappia benissimo che i galli si difenderanno. E anzi, direi che è proprio lo scontro che Cesare cerca, come ai bei tempi. O dico male?»
Cesare sostenne lo sguardo pieno di sarcasmo del suo laticlavius solo per una manciata di secondi, poi sorrise apertamente.
«Abbiamo bisogno di vedere operativa la legione, o almeno la parte che è con noi» confessò. «E di capire se le macchine da guerra che abbiamo elaborato dai disegni di Archimede saranno davvero utili, quando ci troveremo in territorio ostile.»
«Perché consideri queste terre come territori non ostili?» lo incalzò Bruto, che sembrava essersi schierato con Cicerone per fargli da interlocutore critico. «Sono galli, e il loro valore lo hai celebrato tu stesso nelle tue opere.»
«Non dico che siano senza valore» ribatté Cesare, che adesso cominciava a stancarsi di quella discussione. «Anzi, li ritengo i più formidabili nemici che abbia mai combattuto. Ma ormai sono stati asserviti, e da troppo tempo non lottano per difendere le loro città. La protezione di Roma li ha infiacchiti, e dunque non credo che avranno voglia di combattere per qualche cavallo e le loro scorte di cibo.»
«E per le donne» gli ricordò Decimo con un sogghigno. «Ricorda che agli uomini non possiamo negare la possibilità di sfogarsi un po’, dopo tutti questi mesi di vita in solitudine.»
Cesare sventolò una mano in aria, mentre beveva un’altra sorsata di vino.
«Per questo vedremo» affermò. «Forse non ci sarà bisogno di prendere con la forza le donne dei Pictones. Dopo che li avremo sconfitti, capiranno che un sacrificio minore potrebbe salvaguardarli da altri ben peggiori.»
Decimo scoppiò a ridere, e persino Cicerone sollevò la coppa verso di lui, approvando con un cenno della testa la sua strategia.
Solo Bruto se ne restava rincagnato in se stesso, lo sguardo lontano da quello di Cesare, come se avesse vergogna del confronto con lui.
E questo bastò a inquietarlo profondamente, perché ancora non riusciva a capire quali sentimenti contrastanti si stessero facendo strada dentro colui che riteneva fosse suo figlio. Sentimenti che, di certo, lo riguardavano in prima persona. E di cui non poteva più restare all’oscuro.
In sella al cavallo che lui stesso aveva scelto, fra quelli ancora disponibili per gli ufficiali della legione, Gaio Giulio Cesare raddrizzò la schiena e dilatò le narici. Nell’aria c’era l’odore inconfondibile della battaglia, fatto di tensione, sudore, eccitazione, paura di morire e voglia di conquistare la gloria a cui ogni guerriero ambiva.
Tutte sensazioni che gli circolavano nel corpo come un torrente impetuoso, e che lo facevano sentire vivo, giovane e più forte di quanto fosse mai stato negli ultimi anni.
Il nemico era là davanti, rintanato dietro il recinto fortificato posto sulla cima di una bassa collina, ai cui piedi scorreva un torrente di modeste dimensioni che fungeva a sua volta da difesa naturale per l’oppidum, il villaggio che i suoi esploratori avevano individuato e che era stato deciso di attaccare.
«Mi sembra una città piuttosto grande» commentò Publio Licinio Crasso, che lo affiancava come comandante della cavalleria. «Non sarebbe meglio razziare i villaggi circostanti? Sono prede facili, e possono darci tutto quello che ci serve per proseguire il viaggio.»
Cesare non si voltò a guardarlo. Restò agganciato con gli occhi al possente murus gallicus che cingeva l’oppidum in un abbraccio protettivo all’apparenza insuperabile.
«Ho chiesto io agli esploratori di trovare una città abbastanza grande e fortificata da impegnare la legione» spiegò poi, mentre attorno a lui Bruto, Giunio Scribonio e Cassio Longino si giravano a fissarlo. Solo Spartaco, presente in virtù del suo grado di primus pilus, taceva e guardava dritto davanti a sé, scrutando i loro soldati schierati in una riproduzione in miniatura di una legione al completo. «O almeno quello che abbiamo a disposizione per combattere.»
«Gli uomini sono pronti» grugnì il gladiatore. «E quella città non sarà certo un ostacolo difficile da abbattere.»
Cesare annuì compiaciuto, poi tornò a rivolgersi agli altri ufficiali, sui cui volti vedeva smorfie scettiche.
«Dobbiamo verificare l’efficienza dei nostri uomini, prima di portarli a combattere a nord» disse. «I selvaggi che troveremo in Britannia saranno ben altra cosa, rispetto a questi galli ormai domati e sottomessi.»
«Credi che rinunceranno a combattere quando vedranno che siamo romani?» chiese Bruto. «O che almeno ci assomigliamo?»
«Esiteranno quanto basterà per farci avvicinare» rispose Cesare. «E per predisporre le nostre macchine da guerra.»
«Poi lotteranno» affermò Spartaco con la sua voce dura e piena di terra, come se il vecchio gladiatore fosse ancora abituato a mettere in bocca una manciata del terreno su cui avrebbe combattuto, prima di versare il sangue degli avversari. «Sono galli, ce l’hanno nelle vene.»
«E non vanno sottovalutati» mise in chiaro Cesare. «Attacchiamoli, distruggiamo la loro città fortificata e deprediamo tutto quello che possiamo. Ma risparmiamo i civili, per quanto possibile. Voglio solo capire se i nostri uomini sanno muoversi con l’efficienza che mi aspetto dalla mia legione.»
«Lo faranno» ringhiò Spartaco battendo il braccio contro il petto. «Chiedo il permesso di raggiungere lo schieramento.»
Cesare gli fece cenno di andare, e il vecchio gladiatore si allontanò a passo di marcia per raggiungere il primo manipolo della prima coorte di cui era al comando.
«Andate anche voi» ordinò poi a Publio Crasso e Giunio Scribonio, che in qualità di comandanti della cavalleria avevano i loro uomini schierati in prossimità dell’ala orientale della legione.
«Le macchine da guerra sono pronte» gli fece notare Bruto, indicando i carri che si stavano avvicinando scortati dai soldati addestrati al funzionamento di quelle armi, posti sotto il comando diretto di Cicerone.
Cesare cercò a lungo, ma non vide il suo laticlavius da nessuna parte. Stava per gridare un ordine ai suoi attendenti, perché trovassero il vecchio oratore e lo scortassero da lui, quando Bruto si allungò e gli strinse un braccio, facendo poi un cenno con la testa in direzione del primo dei carri, che era anche il più grande, trainato da due buoi che gli esploratori avevano confiscato ad alcuni contadini di un villaggio in prossimità della costa.
Provvisto di sei ruote per reggere il peso considerevole della macchina da guerra che vi era stata allestita sopra, il carro era anche molto alto, perché Cesare vi aveva fatto costruire...