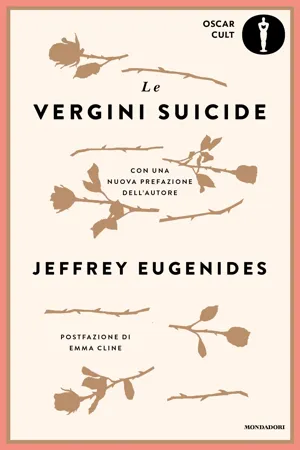La mattina che si uccise anche l’ultima figlia dei Lisbon (stavolta toccava a Mary: sonniferi, come Therese) i due infermieri del pronto soccorso entrarono in casa sapendo con esattezza dove si trovavano il cassetto dei coltelli, il forno a gas e la trave del seminterrato a cui si poteva annodare una corda. Scesero dall’ambulanza, con quella che come al solito ci sembrò una lentezza esasperante, e il più grasso disse sottovoce: «Mica siamo in TV, gente: più presto di così non si può». Stava spingendo a fatica le apparecchiature per la rianimazione accanto ai cespugli cresciuti a dismisura, sul prato incolto che tredici mesi prima, all’inizio di quella brutta storia, era perfettamente curato.
Ad aprire la serie era stata Cecilia, la minore, di tredici anni appena, che si era tagliata le vene nella vasca da bagno come uno Stoico. Quando la trovarono, a galla in quella pozza rosea, gli occhi gialli di un’invasata e il corpo minuto che emanava l’odore di una donna adulta, aveva un’aria così placida che i due soccorritori, spaventati, erano rimasti immobili, come stregati. Ma poi la signora Lisbon aveva fatto il suo ingresso, gridando, e la realtà concreta della stanza aveva ripreso il sopravvento: c’era del sangue sul tappetino, e il rasoio del signor Lisbon chiazzava l’acqua del water in cui era immerso. I due infermieri estrassero Cecilia dal bagno caldo, che aggravava l’emorragia, e le applicarono un laccio emostatico sul braccio. I capelli bagnati le ricadevano sulla schiena; mani e piedi erano già cianotici. Non pronunciò nemmeno una parola, ma nel disgiungerle le mani si scoprì che stringevano su quel seno in boccio un’immagine plastificata della Vergine.
Era giugno, la stagione delle crisope, l’epoca dell’anno in cui le spoglie di quegli insetti effimeri ricoprono la città. Levandosi a nugoli dalle alghe che vivono nelle acque inquinate del lago, vanno ad annerire finestre, ad ammantare automobili e lampioni, a tappezzare i docks municipali e a ornare di festoni il sartiame delle barche a vela: una schiuma volante, brunastra, con il dono perenne dell’ubiquità. La signora Scheer, una vicina, ci disse di aver visto Cecilia il giorno precedente al tentativo di suicidio. La ragazza era ferma sul bordo del marciapiede, con il solito vestito da sposa: un modello antiquato con l’orlo sfrangiato. Stava contemplando una Thunderbird avviluppata in un manto di insetti. «Faresti meglio a prendere una scopa, cara» le aveva detto la signora Scheer. Cecilia l’aveva fissata con quel suo sguardo penetrante da asceta. «Sono morti» aveva risposto. «Vivono soltanto ventiquattr’ore. Nascono, si riproducono e schiattano. Non hanno neanche il tempo di nutrirsi.» E cacciando una mano in quella cortina schiumosa di insetti aveva tracciato le proprie iniziali: C.L.
Anche se dopo tutti questi anni non è un’impresa semplice, abbiamo tentato di disporre le foto in ordine cronologico. Alcune sono sfocate, ma non per questo meno significative. Il reperto n. 1 è un’immagine dell’abitazione dei Lisbon, e risale a poco prima che Cecilia tentasse di togliersi la vita. La foto era stata scattata dalla signora Carmina D’Angelo, un’agente immobiliare a cui il signor Lisbon aveva affidato l’incarico di vendere la casa, che già da tempo risultava troppo angusta per la sua numerosa famiglia. Nell’istantanea le tegole in ardesia del tetto sono tutte al loro posto, la veranda non è ancora del tutto nascosta dai cespugli, le finestre non sono ancora rattoppate da strisce di nastro adesivo. La bella casa accogliente di un quartiere residenziale. La finestra d’angolo del primo piano, a destra, inquadra una macchia confusa in cui la signora Lisbon riconobbe Mary. «Aveva l’abitudine di cotonarsi i capelli: era convinta che fossero troppo piatti» disse, a distanza di anni, rievocando quello che era stato l’aspetto fisico della figlia nel corso della sua breve stagione terrena. La foto coglie Mary nell’atto di asciugarsi i capelli con il phon. Sembra che abbia la testa in fiamme, ma è soltanto un gioco di luce. Era il tredici giugno: fuori c’erano ventotto gradi e un cielo pieno di sole.
Quando furono certi di aver ridotto l’emorragia a un rivoletto di sangue, i due soccorritori adagiarono Cecilia sulla barella e si diressero verso l’ambulanza che li attendeva sul vialetto. Lei sembrava una Cleopatra in miniatura distesa su una lettiga imperiale. A uscire per primo fu l’infermiere allampanato con i baffi alla Wyatt Earp, lo stesso che, dopo averlo conosciuto meglio nel corso di quelle tragedie familiari, avremmo soprannominato “lo sceriffo”; quindi apparve il grassone, che reggeva l’altra estremità della barella e calpestava l’erba a passettini circospetti, sbirciandosi le scarpe da poliziotto quasi volesse scansare eventuali cacche di cane, anche se in seguito, acquisita una maggior dimestichezza con quegli strumenti, avremmo compreso che stava controllando l’indicatore della pressione sanguigna. Sudando e annaspando i due avanzarono in direzione dell’automezzo che vibrava con i lampeggianti e il motore accesi. Il grassone inciampò in un archetto solitario da croquet. Si vendicò assestandogli un calcio: l’archetto schizzò via, sollevando una sventagliata di terriccio, e piombò sul vialetto con un suono metallico. In quel mentre la signora Lisbon uscì di corsa sulla veranda, strascicando la camicia da notte di flanella di Cecilia, e proruppe in un gemito prolungato che arrestò il tempo. Sotto gli alberi che cambiano veste, su quell’erba infuocata, sovraesposta, le quattro figure si immobilizzarono in un tableau: i due schiavi che recavano la vittima all’altare (alzando la barella per infilarla nell’ambulanza), la sacerdotessa che brandiva la torcia (sventolando la camicia di flanella) e la vergine stordita da una pozione che si sollevava sui gomiti, le labbra esangui segnate da un sorriso ultraterreno.
La signora Lisbon prese posto nel retro dell’ambulanza; il marito invece la seguì a bordo della station wagon, rispettando il limite di velocità. Due ragazze erano lontane da casa: Therese era a Pittsburgh per un congresso scientifico, Bonnie a un corso estivo di musica dove tentava di studiare il flauto, visto che aveva rinunciato al pianoforte (aveva le mani troppo piccole), al violino (le doleva il mento), alla chitarra (le sanguinavano i polpastrelli) e alla tromba (le gonfiava il labbro superiore). Mary e Lux, che si trovavano dal signor Jessup, lì di fronte, per la lezione di canto, nell’udire la sirena erano corse a casa. Precipitandosi nel bagno affollato di gente, erano rimaste sconvolte, non meno dei genitori, dalla vista di Cecilia: una nudità pagana con gli avambracci imbrattati. Fuori si abbracciarono su un riquadro di erba alta sfuggita a Butch, il ragazzotto muscoloso che il sabato falciava il prato. Sull’altro lato della strada l’equipaggio di un camion del Dipartimento Verde Pubblico si occupava di alcuni dei nostri olmi morenti. La sirena dell’ambulanza si allontanò lacerando l’aria; il botanico e gli aiutanti ritrassero dai rami gli erogatori di insetticida per meglio osservare la partenza del veicolo. Quando scomparve ripresero il lavoro. L’albero, l’olmo maestoso visibile anch’esso in primo piano nel reperto n. 1, in seguito si arrese al fungo trasmesso dall’insetto che infestava le cortecce, e venne abbattuto.
Gli infermieri trasportarono Cecilia al Bon Secours Hospital, all’incrocio tra Kercheval e Maumee Street. Nella sala del pronto soccorso Cecilia osservò gli sforzi di chi tentava di salvarle la vita con inquietante distacco. Quegli occhi gialli non perdettero la loro fissità; e lei non trasalì nemmeno quando le infilarono un ago nel braccio. Il dottor Armonson suturò le ferite dei polsi. Dopo cinque minuti di trasfusione dichiarò che la ragazza era fuori pericolo. Le diede un buffetto sotto il mento: «Che ci fai qui, piccola? Non puoi sapere quanto è brutta la vita, giovane come sei».
Fu allora che Cecilia espresse verbalmente ciò che doveva rappresentare l’unica parvenza di una lettera d’addio, superflua, tra l’altro, dato che non era morta. «Dottore» disse, «è evidente che lei non è mai stato una ragazza di tredici anni.»
Le figlie dei Lisbon avevano rispettivamente: tredici (Cecilia), quattordici (Lux), quindici (Bonnie), sedici (Mary) e diciassette anni (Therese). Statura bassa, glutei rotondi nei jeans, guance pienotte che evocavano come un’eco quella morbidezza posteriore. I loro visi, le volte che riuscivamo a posarvi lo sguardo, ci colpivano come una sorta di rivelazione impudica, quasi fossimo avvezzi a vedere soltanto donne coperte da un velo. Nessuno sapeva spiegarsi il fatto che i Lisbon avessero messo al mondo quelle splendide creature. Lui insegnava matematica alle superiori: corporatura esile, il tipo adolescenziale che stentava a credere alla realtà della sua chioma grigia. Parlava con una vocetta stridula, e quando Joe Larson ci raccontò che il signor Lisbon aveva pianto nei momenti di panico in cui Lux fu portata di corsa all’ospedale la volta che si temette il suo, di suicidio, non ci fu difficile immaginare il suono di quelle lacrime da ragazzina.
Ogni volta che vedevamo la signora Lisbon tentavamo senza successo di ravvisare su quel volto le tracce della bellezza che doveva aver posseduto in passato. Senonché le braccia grassocce, il taglio squadrato dei capelli ispidi e gli occhiali da bibliotecaria ci disorientavano puntualmente. La si vedeva solo di rado, al mattino, quando usciva in fretta a ritirare i cartoni del latte umidi di rugiada, vestita di tutto punto anche se il sole non era sorto, o la domenica, quando la famiglia al gran completo si recava alla chiesa cattolica di St Paul on the Lake a bordo della station wagon con i pannelli di legno. In quelle occasioni la signora Lisbon ostentava una freddezza regale. Prima di lasciarle salire in macchina esaminava le figlie una per una, la borsetta buona stretta fra le mani, per controllare se si fossero truccate, e più di qualche volta rispediva Lux dentro casa perché indossasse una maglietta meno trasparente. Dato che nessuno di noi frequentava la chiesa, potevamo osservarli con comodo: padre e madre scoloriti, simili a un negativo fotografico, e poi la luce abbacinante delle cinque figlie negli abiti di fattura casalinga, carichi di pizzi e crespe, che scoppiavano su quei corpi in rigoglio.
La loro casa era sempre stata un territorio precluso ai ragazzi, con un’eccezione. Peter Sissen aveva aiutato il signor Lisbon a installare nella sua aula un modello funzionante del sistema solare, e lui per sdebitarsi l’aveva invitato a cena. Peter ci raccontò che le ragazze non avevano smesso neanche un attimo di appioppargli calci sotto il tavolo, da tutte le direzioni, per impedirgli di capire da chi gli arrivavano. Gli piantavano in faccia quegli occhi azzurri, febbrili e sorridevano scoprendo i denti accavallati, l’unica caratteristica fisica delle sorelle Lisbon su cui fu mai possibile avere delle riserve. Bonnie era stata la sola che non lo aveva degnato né di uno sguardo né di una furtiva pedata. Aveva recitato la preghiera di ringraziamento e aveva mangiato in silenzio, nient’altro, assorta nella devozione di una quindicenne. Dopo cena Peter Sissen aveva chiesto di poter andare in bagno, e visto che Therese e Mary, fra risatine e bisbigli, occupavano insieme quello a pianoterra, gli era toccato salire nel bagno delle ragazze. Di nuovo fra noi, raccontò storie di camere che traboccavano di mutandine sgualcite, di animali di pezza stritolati dagli abbracci impetuosi delle ragazze, di un reggiseno che ornava un crocifisso, di antri nebulosi dentro letti a baldacchino e degli effluvi di tutte quelle ragazzine che diventavano donne insieme, chiuse in uno spazio angusto. In bagno, Peter Sissen aveva aperto il rubinetto per dissimulare i rumori dell’indagine e aveva trovato il nascondiglio dei cosmetici di Mary Lisbon, stipati dentro un calzino sotto il lavabo: tubetti di rossetto scarlatto, la seconda pelle di fard e fondotinta e la ceretta che ci rivelò l’esistenza dei baffetti che non avevamo mai notato. A dire il vero non si seppe di chi erano i cosmetici finché, due settimane dopo, non vedemmo Mary sul molo, la bocca dipinta di un rosso acceso che corrispondeva perfettamente alla sfumatura descritta dal nostro amico.
Peter Sissen aveva inventariato deodoranti, profumi, spugne abrasive destinate a rimuovere la pelle secca, e apprendemmo con sorpresa che non c’era nemmeno l’ombra di un dispositivo per lavande vaginali: credevamo che le ragazze se ne facessero una ogni sera, che fosse un’abitudine come quella di lavarsi i denti. Ma il moto di delusione fu prontamente dimenticato quando Sissen ci riferì una scoperta che superava persino le nostre fantasie più sfrenate. Nel cestino dei rifiuti c’era un Tampax usato, ancora caldo del corpo di una delle sorelle Lisbon. Avrebbe voluto portarcelo, dichiarò Sissen, niente di volgare, no, un bellissimo oggetto, era da vedere, faceva pensare a un quadro moderno o a qualcosa di simile; e poi ci disse che nell’armadietto aveva contato dodici scatole di Tampax. Era stato solo allora che Lux aveva bussato alla porta, chiedendo se per caso fosse morto, e lui si era affrettato ad aprire. I capelli di Lux, che durante la cena erano appuntati con un fermaglio, ora erano sciolti sulle spalle. Lei, invece di entrare, l’aveva guardato dritto negli occhi. Poi, scoppiando nella sua risata da iena, l’aveva spinto da parte dicendo: «Il bagno non è mica di tua proprietà, sai? Mi serve una cosa». Si era avvicinata all’armadietto e si era fermata, congiungendo le mani dietro la schiena. «È una faccenda privata, se non ti dispiace» aveva detto. Peter Sissen, avvampando, si era lanciato giù per le scale, e ringraziati i padroni di casa se n’era andato di gran carriera per venire a raccontarci che in quell’esatto momento Lux Lisbon perdeva sangue in mezzo alle gambe, proprio mentre le crisope insozzavano il cielo e i lampioni si accendevano.
Dopo aver udito il racconto di Peter Sissen, Paul Baldino giurò che sarebbe penetrato nella dimora dei Lisbon e che avrebbe visto cose ancora più incredibili. «Guarderò le ragazze mentre si fanno la doccia» promise. A quattordici anni Paul Baldino aveva già il coraggio di un gangster e una faccia da assassino prezzolato, come suo padre, Sammy Baldino detto lo Squalo, e come tutti gli uomini che andavano e venivano dalla grande casa dei Baldino, quella con i gradini dell’ingresso presidiati da due leoni di pietra. Si muoveva con la tracotanza indolente dei predatori urbani che sprigionano aromi di colonia e sfoggiano unghie manicurate. Ci facevano paura, lui e i suoi cugini dall’aria pomposa e il colorito terreo, Rico Manollo e Vince Fusilli, e non era solo perché ogni tanto la sua casa compariva sul giornale, o per via delle limousine nere blindate che risalivano silenziosamente il vialetto circolare fiancheggiato da alberi di alloro importati dall’Italia: erano le sue occhiaie scure, e i suoi fianchi da gigante, e le scarpe nere, lucidissime, che calzava anche per giocare a baseball. Inoltre non sarebbe stata la prima volta che si intrufolava in qualche luogo proibito, e per quanto le informazioni che ne riportava non fossero sempre attendibili, su di noi l’ardimento di quelle esplorazioni non aveva smesso di esercitare il suo fascino. In sesta, quando le ragazze erano andate a vedere un film di argomento particolare, era stato Paul Baldino a introdursi di soppiatto nella sala, nascondendosi nella vecchia cabina elettorale, per raccontarci di che cosa si trattasse. Noi lo aspettavamo in cortile, tirando calci alla ghiaia, e quando finalmente comparve, masticando uno stuzzicadenti e rigirandosi intorno al dito l’anello d’oro, lo spasmo dell’attesa ci aveva tolto il respiro.
«L’ho visto, il film» aveva detto. «Ho capito tutto. State a sentire. Le ragazze, circa all’età di dodici anni» aveva continuato, facendosi più vicino, «perdono sangue dalle tette.»
Benché nel frattempo le nostre cognizioni fossero diventate più precise, Paul Baldino continuava a incuterci timore e rispetto. I fianchi da ippopotamo erano ancora più possenti, e i cerchi sotto gli occhi avevano assunto una tonalità più cupa, cenere e fango, conferendogli l’aria di uno per cui la morte non era un mistero. Era più o meno l’epoca in cui erano iniziate le chiacchiere a proposito della galleria segreta. Un mattino di qualche anno prima, dietro la recinzione dei Baldino, sormontata da punte acuminate e sorvegliata da una coppia di pastori tedeschi bianchi, identici, era apparso un gruppo di operai. Avevano steso alcuni teloni impermeabili sulle scale per proteggersi da sguardi indiscreti; e tre giorni dopo, quando i teloni scivolarono via, in mezzo al prato si ergeva un tronco artificiale. Era di cemento, dipinto con una vernice che voleva imitare la corteccia, completo di un buco finto e di un paio di rami potati che additavano il cielo con lo slancio fervido di due moncherini. Al centro dell’albero, un cuneo tagliato con la sega a motore formava l’alloggiamento di una graticola metallica.
Paul Baldino disse che era un barbecue, e noi gli credemmo. Ma con il passar del tempo ci si avvide che non lo usava nessuno. Secondo i giornali l’installazione del barbecue era costata cinquantamila dollari, ma sulla griglia non si videro mai neanche un hamburger o un hot dog. Ben presto qualcuno mise in giro la voce che il tronco era una galleria segreta che conduceva a un rifugio, sulle rive del fiume, dove Sammy lo Squalo teneva un motoscafo superveloce, e che i teloni stesi dagli operai erano serviti a occultare i lavori di scavo. Qualche mese dopo Paul Baldino cominciò a far capolino nei seminterrati altrui, uscendo dai collettori dell’acqua piovana. Era apparso in casa di Chase Buell coperto da una polvere grigia che puzzava vagamente di merda; si era aperto un varco nella cantina di Danny Zinn, equipaggiato con una torcia elettrica, stavolta, un berretto da baseball e un sacchetto contenente due ratti morti; e per finire era sbucato dietro la caldaia di Tom Faheem, e aveva battuto tre colpi sonori.
Anche se ci aveva sempre raccontato di essersi perduto esplorando il collettore che passava sotto casa sua, ci venne il sospetto che stesse giocando nella galleria segreta di suo padre. Quando si vantò di poter vedere le sorelle Lisbon sotto la doccia, pensammo tutti che avesse intenzione di penetrare in casa loro ricorrendo allo stesso sistema. Non si seppe mai con precisione come andarono le cose, anche se la polizia interrogò Paul Baldino per più di un’ora. Lui non riferì nulla di più di quello che aveva detto a noi. Dichiarò di essersi infilato strisciando nel condotto fognario che si apriva sotto il seminterrato di casa sua e di essersi messo a camminare, avanzando di un mezzo metro alla volta, lentamente. Descrisse l’ampiezza inaspettata delle condutture, le tazze da caffè e i mozziconi di sigaretta abbandonati dagli operai, le donne nude disegnate a carboncino, simili a graffiti rupestri. Raccontò di come avesse scelto le gallerie a caso, e di come, passando sotto le abitazioni, avesse indovinato dall’odore quel che bolliva sui fornelli. Alla fine era riemerso nel seminterrato dei Lisbon attraverso la grata di scarico. Si era ripulito alla meglio e aveva gironzolato per il pianterreno in cerca di qualcuno, ma la casa era vuota. Passando da una stanza all’altra, aveva continuato a chiamare e poi era salito su per le scale che portavano al primo piano. Dal fondo del corridoio proveniva un rumore d’acqua. Si era avvicinato alla porta del bagno. Aveva bussato, così almeno sosteneva. Dopodiché Paul Baldino raccontò che, varcata la soglia, aveva visto Cecilia, nuda, i polsi che grondavano sangue, e che, dominato lo spavento, era corso giù a chiamare la polizia, perché suo padre gli aveva sempre insegnato che quella era la prima cosa da fare.
Ovviamente erano stati i due soccorritori a trovare l’immaginetta plastificata, e nell’urgenza del momento il grassone se l’era cacciata in tasca. Fu solo all’ospedale che pensò di consegnarla ai signori Lisbon. Ormai Cecilia era fuori pericolo, e i suoi genitori sedevano nella saletta d’attesa, sollevati ma confusi. Il signor Lisbon ringraziò l’infermiere per aver salvato sua figlia. Poi voltò il santino e vide il messaggio stampato sul retro:
La Vergine si è manifestata nella nostra città
per offrire la sua pace a un mondo in sfacelo.
Come a Lourdes e a Fatima, Maria ha donato
la sua presenza proprio a voi. Per informazioni
chiamate il 555 - MARY
Il signor Lisbon lo lesse tre volte. Quindi, con un tono sconsolato, disse: «È stata battezzata, ha fatto la cresima e adesso crede a queste fesserie».
Fu l’unico commento blasfemo che uscì dalle sue labbra nel corso di tutta quella penosa vicenda. La signora Lisbon reagì accartocciando l’immagine (un danno non irreparabile: noi ne conserviamo una fotocopia).
Il quotidiano locale non menzionò il tentato suicidio: Baubee, il direttore, era del parere che una notizia così lugubre stonasse fra la prima pagina, dedicata alla mostra floreale della Junior League, e le spose radiose ritratte nell’ultima. Quel giorno l’unico articolo degno di nota riguardava lo sciopero dei necrofori (salme ammonticchiate una sull’altra, nessun accordo in vista), e oltretutto era in quarta pagina, sotto i risultati della Little League.
Al ritorno dall’ospedale i Lisbon si chiusero in casa, figlie comprese, e non fecero nessun commento sull’accaduto. Fu solo quando la signora Scheer la mise alle strette che la signora Lisbon accennò all’“incid...