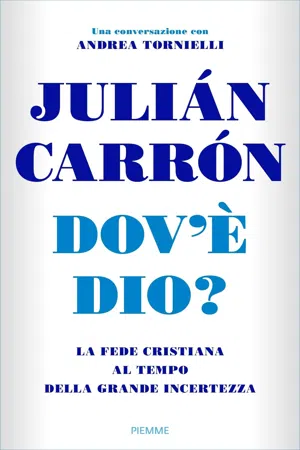Don Julián, viviamo in un mondo squassato da guerre, terrorismo, fame, migrazioni… Come guarda al futuro un cristiano di fronte a un panorama come quello attuale?
Un cristiano guarda al futuro con realismo e con speranza. Due termini che sembrano quasi in conflitto tra di loro: per alcuni, infatti, nutrire speranza significa avere uno sguardo edulcorato sulla realtà; per altri, essere realisti comporta necessariamente non avere speranza. Invece è proprio la speranza che consente un autentico e radicale realismo, in cui non si ha bisogno di cancellare nulla di quello che c’è, in un senso o nell’altro. Per questo l’unico sguardo realista è quello cristiano. San Paolo ha offerto forse la descrizione più apocalittica del mondo a lui contemporaneo, all’inizio della Lettera ai Romani, non perché fosse un osservatore più accanito di altri, ma perché la speranza che aveva suscitato in lui l’incontro con Cristo risorto gli consentiva di non indietreggiare davanti ai fatti e ai problemi, di rendersi conto di ciò che non andava attorno a lui. Non aveva bisogno di edulcorare la realtà.
Vediamo oggi lo stesso atteggiamento in papa Francesco, che parla con grande realismo della situazione che stiamo vivendo: terza guerra mondiale a pezzi, traffico di armi, violenze, scarto di persone, fenomeni migratori, ingiustizie, fame, corruzione. Interessato tanto alle vicende particolari delle persone quanto agli scenari globali, è diventato un leader mondiale riconosciuto da tutti, proprio per il suo sguardo pieno di quel realismo che nasce dalla speranza cristiana. Se un cristiano vive veramente un’esperienza di fede, la certezza che essa porta con sé si estende fino al futuro: fonda cioè una speranza che fa affrontare tutto con uno sguardo nuovo.
Sta dicendo che il cristiano non è pessimista, ma nemmeno ottimista?
Fondamentalmente, alla fin fine, è ottimista, non per ingenuità, ma perché l’ultima parola sulla vita e sulla realtà è l’avvenimento di Cristo, un fatto che è accaduto e che ha introdotto nella storia una speranza altrimenti impossibile. Lo dice bene una frase di Charles Péguy: «Per sperare […] bisogna […] aver ricevuto una grande grazia»1.
Che cosa significa «una grande grazia»? Può spiegarlo brevemente?
È la grazia dell’incontro con Cristo. Come l’incontro – umanissimo – dei primi due, Andrea e Giovanni, con Gesù, sulle rive del fiume Giordano, che cambiò tutta la loro vita. O l’incontro sconvolgente di san Paolo sulla via di Damasco, che capovolse lo sguardo che egli aveva avuto fino a quel momento. L’incontro con Cristo vivo determina il loro modo di guardare tutto, li apre a cogliere l’irriducibile positività del reale. Il punto ultimo che definisce il reale, cioè, non è più il male, la sofferenza, ma la vittoria di Cristo risorto. Chi riceve la grazia – il dono gratuito, non meritato, che non dipende dalla nostra bravura – dell’incontro con Cristo e lo accoglie vive con la Sua presenza negli occhi, in ogni fibra del suo essere, ed essa plasma la modalità con cui guarda il reale.
In fondo la stessa parola «conversione» richiama proprio questo guardare tutto con un altro sguardo, da un’altra prospettiva…
Sì, la parola greca metànoia (“conversione”) vuol dire cambiamento del nous, della mente, del modo di concepire, per l’introdursi di un fattore nuovo, imprevisto – una presenza –, che è sorgente di una conoscenza nuova.
Che cosa ha da dire la fede cristiana agli uomini e alle donne di oggi, in un mondo così frastagliato e problematico, nella società che viene definita «liquida», nella quale sono venute meno certe evidenze riconosciute da tutti? Il suo libro La bellezza disarmata inizia proprio con la domanda se sia possibile un nuovo inizio per la fede oggi che sono crollate le convinzioni di fondo create dal cristianesimo…
Sono convinto che la fede possa dire e dare tanto agli uomini di oggi, se essi la incontrano incarnata nella vita, nell’esperienza di altre persone. Quella generata dalla fede è infatti una vita che porta dentro di sé un’attrattiva: quanti, avendola incontrata, non vogliono più perderla! Purtroppo non di rado tanti nostri contemporanei vengono in contatto con una fede ridotta in senso moralistico o nozionistico. Penso a quanto ha inciso sulla nostra mentalità la versione kantiana di un cristianesimo “etico”. Oppure all’identificazione del cristianesimo con un elenco di dottrine astratte, delle quali non si percepisce la convenienza umana per la vita di ciascuno. Si resta così non toccati, non si vede il nesso della fede con la vita. Quando invece si incontrano persone che, in forza di una fede vissuta, affrontano le circostanze di tutti − difficoltà, stanchezze, delusioni, malattie − in un modo diverso, testimoniando un “di più” di intensità umana, un’ultima letizia, allora tutto cambia: si rimane stupiti, colpiti, interessati. Da quell’impatto nasce una attrattiva, una curiosità, che può diventare un interrogativo esplicito sull’origine di ciò che si vede. È questo il cristianesimo che accade di nuovo, che non ha bisogno di alcun requisito preliminare per destare l’attenzione dell’uomo di oggi. Basta anche solo vedere il modo con cui una certa persona va a lavorare per provare una curiosità imprevista: «Come mai, alle otto del mattino, entri sempre in sala operatoria cantando?». Sto parlando di un caso concreto, con nome e cognome. Se una persona che arriva appesantita al lavoro ne vede un’altra che affronta la sua stessa circostanza in modo totalmente diverso, più umano, è difficile che non domandi: «Come mai? Cosa ti è capitato?». Quando ci imbattiamo in un altro modo di stare in quella quotidianità che, come diceva Cesare Pavese, «taglia le gambe»2, ci possiamo rendere conto che la fede riguarda la vita nella sua concretezza e nella sua interezza.
In fondo il cristianesimo, lo vediamo nella storia, è riuscito a trasformare la realtà quando non si è diffuso per la conversione e il Battesimo del re che obbligava i suoi sudditi a fare lo stesso, ma quando si è comunicato poco a poco, come per osmosi, da persona a persona, da famiglia a famiglia, soprattutto grazie alle donne, alle madri.
Nei primi secoli il cristianesimo ha avuto forse il più grande momento di diffusione grazie ai mercanti, agli schiavi, alle madri di famiglia. Persone normalissime che, vivendo la vita di tutti, documentavano, come si legge nella Lettera a Diogneto, quella diversità cui ho appena accennato. Non a motivo di un loro sforzo o di una loro bravura. Non per qualche merito acquisito o per qualche superiorità intellettuale. Non perché avessero qualcosa di speciale. Non perché fossero perfetti. No, avevano i limiti di tutti, ma era accaduto loro un incontro che li aveva trasformati.
È quel che afferma Emmanuel Carrère nel suo libro Il Regno a proposito della reazione che suscitavano i primi cristiani: «All’inizio nessuno ne afferra la ragione. […] Poi qualcuno comincia a vederci chiaro. Comincia a capire a cosa giova, ossia quanta gioia, quanta forza, quanta intensità guadagna la vita da quella condotta apparentemente insensata. E allora non ha più che un unico desiderio, fare come loro»3.
Probabilmente testimoniavano una capacità di volersi bene gli uni gli altri, una capacità di condivisione… proprio come si legge negli Atti degli Apostoli.
È proprio questo il punto. Dicevo spesso ai ragazzi della scuola di Madrid dove ho insegnato per anni: «Cristo dovrebbe interessarvi proprio perché le cose più belle della vita possano durare». L’innamorarsi è una di queste. Ma l’impeto di quando uno si innamora spesso non tiene nel tempo. Chi può farlo durare? Amare la persona che si è tanto desiderata, volerle bene veramente, senza piegarla a sé, alle proprie pretese, si rivela una impresa impossibile. E quello che succede nell’amore capita nel resto della vita: nel lavoro, nei rapporti con le persone, in tutto. C’è una mancanza di tenuta, cui non riusciamo a porre argine. Che cosa permette che le esperienze più belle del vivere durino? Dobbiamo riconoscere che tutti i nostri sforzi, i nostri tentativi, non sono sufficienti. C’è una frase di T.S. Eliot che mi piace molto: «Dov’è la Vita che abbiamo perduto vivendo?»4. Spesso, infatti, si ha la sensazione di perdere la vita vivendo. È come se non riuscissimo a evitare che ciò che pure inizia in modo fresco, attraente, nel tempo non diventi routine, non si logori, perdendo il suo fascino. Occorre qualcosa d’altro da noi, più grande. Questo è, per l’uomo, Cristo presente.
Che cosa significa allora vivere l’esperienza cristiana in un contesto come quello della società occidentale, segnata dalla secolarizzazione?
Direi anzitutto, come ho già avuto modo di osservare, che il contesto della secolarizzazione nel quale tutti siamo immersi ci rende paradossalmente più facile cogliere e vivere ciò in cui consiste l’esperienza cristiana. Proprio in questo contesto, infatti, per contrasto, si può percepire con più nettezza, là dove accade, quella intensità umana, quel “di più” di capacità di affezione, di libertà, di possibilità di affrontare con speranza anche circostanze avverse, di usare la ragione in un modo non ridotto, che nasce dall’avvenimento cristiano. Sono venuti meno ideali e ideologie, sono crollati valori ed evidenze che ci hanno accomunato per secoli, ma il cuore dell’uomo continua a desiderare: perciò la secolarizzazione può trasformarsi veramente in una grande occasione di testimonianza per noi cristiani.
Come definirebbe il fenomeno della secolarizzazione? Che cosa significa vivere in un contesto secolarizzato?
La secolarizzazione è un fenomeno molto complesso, di cui tutti constatiamo gli effetti: molto di ciò che il cristianesimo aveva contribuito a costruire è venuto meno. Per capirlo bisogna risalire alle soglie della modernità: nelle società di allora molto, se non tutto, era in qualche modo permeato e determinato dalla fede cristiana. Poi la rottura dell’unità dei cristiani con la Riforma protestante creò le condizioni delle cosiddette “guerre di religione”. Se non si condivideva più la religione, che cosa restava come possibile collante? La ragione. Il titolo di una nota opera di Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, fa capire bene (a posteriori) quale fosse la direzione intrapresa. In un famoso intervento a Subiaco, l’allora cardinale Ratzinger spiegava in modo molto sintetico quale fu l’intuizione dell’illuminismo. «Nell’epoca dell’illuminismo […] nella contrapposizione delle confessioni […] si tentò di tenere i valori essenziali della morale fuori dalle contraddizioni e di cercare per loro un’evidenza che li rendesse indipendenti dalle molteplici divisioni e incertezze delle varie filosofie e confessioni. Così si vollero assicurare le basi della convivenza e, più in generale, le basi dell’umanità. A quell’epoca sembrò possibile, in quanto le grandi convinzioni di fondo create dal cristianesimo in gran parte resistevano e sembravano innegabili.»5 Il riconoscimento comune di questi valori permise di superare le divisioni e le contrapposizioni derivate dallo scontro tra le religioni, ma staccandoli da esse.
Si è cioè cercato di separare i valori dalla loro origine?
Sì, il tentativo dell’illuminismo fu in un certo senso quello di preservare il frutto dell’esperienza storica precedente, ma senza i legami con la storia determinata e concreta in cui esso aveva avuto origine. È interessantissimo leggere al riguardo una frase di Kant, che lo chiarisce molto bene: «Si può infatti tranquillamente credere che, se il Vangelo non avesse insegnato prima le leggi etiche universali nella loro integra purezza, la ragione non le avrebbe conosciute nella loro compiutezza». Dunque Kant riconosce che il Vangelo è l’origine di certi valori. Ma subito aggiunge: «Sebbene adesso, dato che ormai esistono, ognuno può esser convinto della loro giustezza e validità mediante la sola ragione»6. Ecco il punto nevralgico. I valori essenziali resi noti dal Vangelo potevano ormai godere di una evidenza autonoma: non c’era bisogno d’altro per riconoscerli che la ragione, tanto sembravano innegabili. Anche questo tentativo illuministico – non diversamente da ogni altro tentativo umano – ha dovuto però fare i conti con la storia.
Che cosa è successo da allora, dall’illuminismo fino a oggi? Queste grandi convinzioni hanno resistito ai cambiamenti della storia? A conclusione della sua traiettoria, Ratzinger afferma: «La ricerca di una tale rassicurante certezza, che potesse rimanere incontestata al di là di tutte le differenze, è fallita»7. Quei valori, che prima erano condivisi e riconosciuti da tutti, oggi non lo sono più. È ciò che ho chiamato «crollo delle evidenze». Pensiamo al valore della persona, che subisce restrizioni di vario genere (quanto a libertà espressiva e associativa, diritto a professare pubblicamente la propria fede, tutela del lavoro e della famiglia ecc.) in molti paesi occidentali, quando non viene negato del tutto, come in certe parti del mondo. O al valore della solidarietà, messa in questione dall’innalzamento di nuovi muri, dopo che avevamo assaporato la gioia di veder finalmente cadere il Muro di Berlino. E ancora...