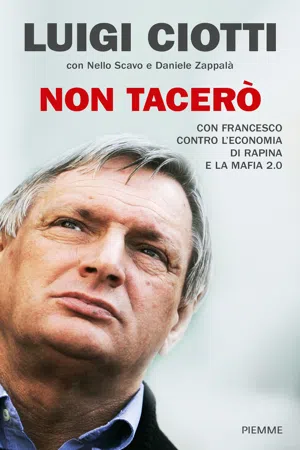Il suo impegno contro le mafie è seguito a quello molto precoce, già in gioventù, di impegno accanto agli “ultimi”, a quelli che vivevano sulla strada. Può raccontarci cosa la spinse, in origine, in questa direzione? È una scelta che, almeno oggi, non sembra essere consueta per un adolescente.
Credo siano state determinanti alcune esperienze vissute da bambino. Sono arrivato in Piemonte da Pieve di Cadore, Dolomiti venete, all’inizio degli anni Cinquanta. Con la mia famiglia ho vissuto prima ad Alba, poi a Cherasco e infine a Torino, dove papà, che faceva il muratore, contribuì alla costruzione del Politecnico. Soldi per affittare una casa non ne avevamo, e allora, per un certo periodo, grazie alla disponibilità dell’impresa costruttrice, abitammo in una baracca del cantiere. Sembrerà strano, ma di quella baracca conservo bei ricordi. Mamma faceva di tutto per renderla dignitosa, pulita, ospitale: una casa. E gli operai del cantiere, che certo non se la passavano meglio di noi, si adoperarono per farci sentire accolti. Non trovai lo stesso clima amichevole in altri ambienti: ad esempio, a scuola. Subivo sguardi di diffidenza, pregiudizi, toccate di gomito… Agli occhi degli altri ero il “diverso”, quello “venuto da fuori”, senza il grembiule con il fiocco, divisa prevista dal regolamento, perché i miei genitori non avevano potuto acquistarlo. Non voglio enfatizzare alcuni episodi sgradevoli, perché hanno segnato la storia di tanti migranti, ma certo hanno in parte determinato l’indirizzo della mia vita, facendomi capire quanto sia importante l’accoglienza nelle relazioni e nella vita sociale.
I miei genitori sono stati figure molto importanti nella mia crescita. Mi hanno amato, insegnato la dignità e l’integrità, mi hanno sempre incoraggiato e sostenuto nelle mie scelte. La mamma se ne è andata tanti anni fa, papà è rimasto invece fra noi fino al 17 ottobre 2010. E quando dico “noi” intendo che la sua casa è stata il Gruppo Abele, dove, finché gli è stato possibile – è morto a 99 anni – ha continuato a occuparsi delle mansioni più umili. Parlava poco, era un uomo verticale e autentico come le sue montagne, ma si faceva benvolere da tutti.
Ogni incontro mi ha lasciato qualcosa, mi ha arricchito. Certamente devo molto a una persona incontrata da ragazzo. All’epoca, era l’inizio degli anni Sessanta, frequentavo un corso di radiotecnica e ogni giorno, andando a scuola, vedevo un signore seduto su una panchina, avvolto in due cappotti: aveva sempre un libro in mano e lo sottolineava con una matita metà rossa e metà blu.
Una mattina, vincendo la timidezza, mi avvicinai e gli chiesi se avesse bisogno di qualche cosa: senza sollevare lo sguardo mi fece capire di no. La scena si ripeté un po’ di volte, finché un giorno, forse incuriosito dalla mia timida testardaggine, mi fece cenno di sedermi e cominciò a raccontare. Era un medico chirurgo che aveva scelto la vita di strada dopo un incidente sul lavoro che aveva sconvolto la sua vita. Cominciammo a vederci ogni giorno, diventammo amici, e fu durante uno di questi incontri che m’indicò un gruppo di ragazzi davanti a un bar, giovani che all’epoca “sballavano” mischiando alcol e anfetamine. «Io sono stanco e malato» mi disse «ti ringrazio della tua amicizia, ma se vuoi fare qualcosa di utile occupati di loro.» Qualche giorno dopo, passando dalla piazza, trovai la panchina vuota: il mio amico era morto. Avevo diciassette anni. Il Gruppo Abele nascerà tre anni dopo, nel Natale del 1965, e la sua storia deve molto a quell’incontro.
Non tutti quelli che scelsero la strada in quegli anni hanno abbracciato poi il sacerdozio. Quella sua prima opzione per gli “ultimi” ispirò la sua vocazione sacerdotale? Riconosce un legame fra la prima e la seconda?
Sono convinto che ogni vocazione sia ben più di una scelta, ma sia piuttosto un “essere scelti”. La vocazione è “convocazione”: è una voce che chiama e che attende una risposta. È dunque responsabilità. È possibile che io sia stato prete ancor prima di diventarlo a tutti gli effetti. Poi, ovviamente, c’è modo e modo d’interpretare e vivere l’essere preti, l’incontro con Dio e con gli altri, e lì contano i fattori caratteriali, conta il contesto, l’epoca; contano anche molto le persone che hai incontrato e ti hanno accompagnato su quella strada. Personalmente ho avuto la fortuna di poter contare su due grandi vescovi, Michele Pellegrino, che mi ha ordinato, e Anastasio Ballestrero. Così come su altre grandi figure della Chiesa: padre David Turoldo, don Tonino Bello, don Franco Peradotto…
La seconda cosa è che la strada e il Vangelo sono indissolubili, sono un’unica realtà. Per questo non mi piace l’espressione “prete di strada” (come pure “prete antimafia” o “prete antidroga”). Nell’essere prete è insita la dimensione della strada, ma anche quella del cammino spirituale, dell’incontro con le persone, della ricerca.
Non dimentichiamo che la strada è citata 109 volte nel Vangelo! È un luogo di incontro e di festa, ma anche di solitudine e di disperazione. La strada pone, in fondo, sempre la stessa domanda: come fare – anzi cosa posso fare – affinché tutte le persone siano accolte, abbiano una casa, un lavoro, una dignità, siano chiamate per nome, non siano un numero, un rifiuto dimenticato, una merce? Questa è la domanda della strada. Ed è una domanda che ci trova spesso impreparati, o peggio sordi, indifferenti, altrimenti le nostre strade non sarebbero sempre così popolate di disperazione, di smarrimento, di bisogni non raccolti.
L’aspetto che più balza all’occhio, da quando ho iniziato la mia storia di sacerdote, è che allora la strada era segnata soprattutto dall’emarginazione, dalla fatica esistenziale, dalla malattia e dalle dipendenze, mentre oggi ci sono interi pezzi di società che non dispongono dei mezzi materiali per vivere dignitosamente. Interi pezzi di società sono stati letteralmente “sfrattati”, non hanno più casa e hanno perso il “diritto di cittadinanza”. Non è un segno di progresso. Siamo progrediti nel campo delle tecnologie e della scienza, ma sul versante dell’etica, dell’accoglienza, dei diritti, dell’uguaglianza, c’è stato un regresso. Se leggiamo la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, scritta nel dopoguerra, non possiamo guardarci attorno senza provare un senso di smarrimento e di vergogna.
E riguardo al sacerdozio, come arrivò a fare quel passo?
Ogni vocazione è un percorso difficile da raccontare e sempre un po’ misterioso. È Dio che ti chiama, sono le circostanze della vita che ti scelgono. Avevo fatto la scelta di “lasciarmi mangiare” dai poveri. Perché non proseguire? Nei primi anni Sessanta si era aperto a Torino, per iniziativa del cardinale Maurilio Fossati, il primo corso sperimentale per vocazioni adulte. Decisi d’istinto di iscrivermi, nonostante il mio rapporto con il mondo ecclesiale fosse stato, in quegli anni giovanili, un po’ turbolento. Ebbi la fortuna di trovare, in quei frangenti, persone di grande valore. Mi ricordo in particolare un viceparroco: intuì la mia “crisi”, i miei dubbi, ma non m’inseguì né mi giudicò. Seppe aspettarmi.
C’era poi un altro ostacolo. All’epoca già vivevo intensamente la strada: passavo le notti con i giovani emarginati a Porta Nuova, la stazione ferroviaria di Torino, nei vagoni che usavano per ripararsi dal freddo nella stagione invernale. Facevo insomma quelle cose che poi, in modo più organizzato, avrei fatto con il Gruppo Abele.
Non volevo lasciare quel mondo e si pose quindi il problema di conciliare la dimensione del seminario con quella della strada. A quell’epoca, studiare in seminario significava essere liberi solo a Natale e a Pasqua. Avrei potuto restare lacerato, intrappolato, e invece il Padreterno e figure profetiche come Michele Pellegrino mi permisero di percorrere questa via tra Terra e Cielo. Via percorribile in due sensi: perché si può incontrare Dio attraverso le persone e le persone attraverso Dio. Ho fatto insomma da “ponte”, da tramite…
Il mio percorso sacerdotale si è totalmente plasmato sulla vita degli altri, sui loro bisogni e le loro speranze. Sono diventato quello che i rapporti umani hanno fatto di me come persona, come prete e come cittadino. Non la si pensi però una privazione, una rinuncia. Nel servizio, nella spoliazione di sé, si può scoprire la più alta forma di libertà.
Lei è stato “adottato” da una città, Torino, dove si è da poco celebrato il bicentenario della nascita di don Giovanni Bosco. Quanto ha contato per lei il fondatore dell’ordine dei salesiani? E gli altri “santi sociali” piemontesi?
Mi capita di frequentare spesso realtà e luoghi salesiani. Di don Bosco mi ha sempre affascinato lo sguardo a un tempo stesso pratico e profetico. Visse e operò in una Torino – in un’Italia – segnata da tremende disuguaglianze, dove il destino delle persone che non appartenevano a minoranze agiate era segnato alla nascita. Storie di ieri e storie di oggi… La fame aveva spinto migliaia di ragazze e ragazzi a lasciare le valli e le campagne per raggiungere la città. Per un piatto di minestra e un letto, una ragazza accettava di diventare cameriera a tempo pieno presso famiglie aristocratiche o altoborghesi. I ragazzini erano destinati ai lavori pesanti, spesso vittime di imbroglioni e sfruttatori. Don Bosco si ribellò a questo stato di cose e, facendo leva sulla formazione professionale – che in quell’epoca stava facendo i primi passi – costruì con gli oratori un’alternativa. Pensando a lui non posso che sentirmi piccolo, una formica al cospetto di un gigante. È stato un grande uomo di Chiesa, che ha saputo mettere la dottrina al servizio del Vangelo e non viceversa, facendo del Vangelo uno strumento di libertà e di dignità. Devo anche molto alla visione salesiana della cultura e della formazione delle coscienze. Il Gruppo Abele è in fondo tre cose: accoglienza, cooperazione e cultura. E una delle nostre riviste, «Animazione sociale», destinata a educatori e operatori sociali, è stata fondata nel 1971 da un salesiano, don Aldo Ellena, uomo di grande profondità che è stato con noi fino alla morte, nel 1999.
Quella dei cosiddetti “santi sociali” è stata senza dubbio, per Torino e per il Piemonte, una stagione spirituale straordinaria. Negli stessi anni di don Bosco, un prete che quasi nessuno più ricorda, don Giovanni Cocchi, nel quartiere allora periferico di Borgo Moschino, oggi i Murazzi del Po, accoglieva quelle ragazze che, non riuscendo a farsi assumere come cameriera o lavapiatti, finivano nel giro della prostituzione. Fu una meraviglia la Chiesa torinese della metà dell’Ottocento! Figure come Cafasso, Murialdo, Cottolengo… Ma anche laici come la marchesa di Barolo o Faà Di Bruno, alto ufficiale di nobili origini, ingegnere e matematico, divenuto poi sacerdote e amico di don Bosco. A lui si deve, tra l’altro, nel quartiere di San Donato, la costruzione di un campanile visibile all’epoca da gran parte della città. Lo volle perché le lavandaie del Po e della Dora potessero controllare l’ora e non farsi ingannare sulla durata dei turni di lavoro.
Prima lei ha accennato alla LILA, la Lega Italiana per la Lotta all’AIDS, di cui per un periodo fu presidente. Cosa le ha lasciato l’impegno per i malati di AIDS? Suscitò polemiche la presenza di un prete in quel ruolo?
Ho presieduto la LILA nella seconda metà degli anni Ottanta, quando non c’erano farmaci in grado di curare, o quantomeno rallentare, la malattia. Chi ha vissuto quell’epoca non può dimenticare il senso di angoscia, d’impotenza ma pure l’allarme diffuso, che spesso degenerava in forme di discriminazione e persino di superstizione. C’era chi vedeva nella malattia un effetto della libertà dei costumi, chi addirittura un castigo divino… Il Gruppo Abele non restò inerte. Aprimmo a San Vito, sulla collina torinese, una casa di accoglienza. In quella struttura immersa nel verde e nel silenzio, arredata sobriamente ma con cura, non potendo fare nulla contro la malattia, cercammo di fare qualcosa per i malati: riconoscerli nella loro dignità, accompagnarli nei momenti bui e in quelli più sereni, vivere le loro ansie e le loro speranze, farli sentire meno soli di fronte al destino. Il tavolo dove mangiarono, parlarono e vissero in comunità è diventato oggi l’altare della Certosa, un convento risalente al 1515 che ospita le attività di formazione del Gruppo Abele. Non conosco al mondo altare più bello… Mi chiedete cosa mi ha lasciato quell’esperienza? Ricordi indelebili. Volti e voci che ho ancora davanti a me, dentro di me. Come il volto e la voce di Franco.
Era un figlio dell’immigrazione degli anni Sessanta, vittima, come tanti, dell’impatto con la grande città. Risucchiato da vicende dure e dolorose, era anche finito, come spesso accade, sulle pagine di cronaca dei giornali, più interessati ai “guai” che aveva combinato che alle ragioni che lo avevano condotto a una vita segnata dal carcere e dalla droga. Lo andavo a trovare spesso in ospedale, come facevo con altri. Parlavamo molto. Franco aveva un’intelligenza acuta, svelta, allenata dalle difficoltà della strada. Era consapevole della sua condizione, sapeva che gli restava poco da vivere e quando capì che anche quel poco si stava esaurendo, fece chiamare la madre, donna del Sud profondamente devota. Fui presente al colloquio. «Mamma, ti chiedo un favore: quando muoio non voglio essere portato in chiesa.» «Ma che dici, Franco! Non bestemmiare!» Allora Franco raccolse le forze e con un filo di voce continuò: «No, mamma, dico sul serio. Per tutta la vita ho preso in giro il Padreterno e non voglio essere portato in chiesa solo per fare bella figura con i parenti e con gli amici. Chiedo però che Luigi porti la benedizione di Dio sulla mia bara e legga il passo del figliol prodigo». Quel giorno mi fu più che mai chiaro che noi non salviamo nessuno, non convertiamo nessuno. Quello che facciamo è dare una mano a Dio a fissare i suoi appuntamenti.
A quell’epoca ci furono incomprensioni nel mondo ecclesiale a fronte del suo impegno sociale?
Sono episodi da leggere nel contesto di quegli anni, dove il clima non favoriva certo la ragionevolezza, la lucidità o il semplice buon senso. Come presidente della LILA, avevo firmato, insieme ad altri, un appello che si rifaceva a un documento dell’Organizzazione mondiale della sanità, che raccomandava, tra le misure di prevenzione dell’AIDS, l’uso del preservativo.
Uscì su un giornale cattolico un editoriale molto critico che generò un acceso dibattito nell’opinione publica. Nel frattempo, la Congregazione per la dottrina della fede aprì in Vaticano un fascicolo su di me. A difendermi, in quell’occasione, fu il cardinale di Torino, Anastasio Ballestrero. Ricordo bene il nostro incontro. Non sapevo nulla di quel fascicolo e fu Ballestrero a informarmi. Gli spiegai di aver firmato quel documento pensando alla sofferenza delle persone, a quelle vite che si spegnevano inesorabilmente. «Non ti preoccupare,» disse «finché ci sarò io nessuno ti toccherà.» Andò a Roma e spiegò che don Ciotti accoglieva i malati di AIDS e, dunque, aveva avuto le sue buone ragioni per firmare il documento. Ballestrero si era preso a cuore la situazione, con la lungimiranza e la generosità di un grande pastore.
Non fu quello il primo caso d’incomprensione in quel periodo?
C’era n’era stato, in effetti, un precedente. Il giorno del giuramento di Sandro Pertini a presidente della Repubblica – 9 luglio 1978 –, la RAI, la nostra televisione pubblica, mi contattò per chiedermi di celebrare la messa della domenica. Accettai e decisi di usare, visto che la diretta si faceva da una nostra comunità per ragazzi con problemi di droga, la “liturgia dei giovani” di Annibale Bugnini, il “padre” della riforma liturgica voluta da Paolo VI. Apriti cielo! Ci fu chi si offese, perché a un certo punto del rito usai come altare un carro agricolo; chi arrivò a paragonare il Gruppo Abele a un covo di eretici dediti a celebrare “messe nere”. A difendermi, quella volta, fu padre Michele Pellegrino. Interpellato sulla vicenda, disse che «Il valore di una messa non si misura dal numero dei candelabri».
Per parte sua, Ballestrero, appena nominato vescovo di Torino, in segno di solidarietà, impedì per un lungo periodo che altre messe fossero trasmesse da luoghi della diocesi. Come dimenticare quei gesti?
Torneremo a Libera e alla sua nascita nel 1995, ma per venire a tempi più recenti, tutti i giornali hanno pubblicato le foto con papa Francesco che, il 21 marzo 2014, le prende la mano durante la giornata di commemorazione delle vittime innocenti della mafia. Come ha vissuto quel gesto affettuoso e la presenza del papa in una simile occasione? Com’è nata e come vive questa vicinanza con Francesco?
Pensavo di trovare un padre, ho trovato un fratello. Papa Francesco è un uomo di straordinaria cultura e intelligenza, ma è anche una persona umile, immediata, affabile. È tutto questo a renderlo tanto amato. Uno s...