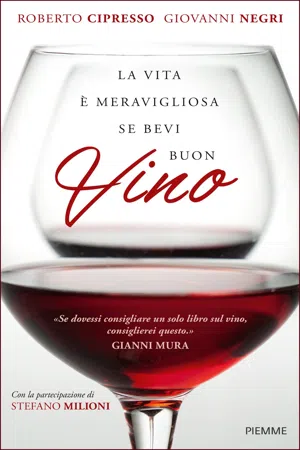Roberto Cipresso non parla molto bene l’inglese e io non mastico molto l’italiano. Quando ci incontriamo per parlare di vino, discutiamo spesso in termini di cifre.
Roberto, da produttore di vini qual è, tratta di alcol, acidità, ph, grammi per litro e tante altre misure. Io, in qualità di critico, mi occupo del numero totale di bottiglie prodotte, della quantità del raccolto, del costo del vino, e di quella che, per qualcuno, è probabilmente la cifra più fredda di tutte: il punteggio che assegno ai vini quando li esamino. Ma le cifre sono una forma di comunicazione del tutto elementare.
Il vino non è solo cifre. La sua magia risiede nella capacità di comunicare a un livello superiore e ben più profondo di quello dei numeri. Roberto produce vini in diverse tenute, e hanno tutti una personalità ben distinta. Non imponendo ai suoi vini uno stile predominante, Roberto consente alla terra di parlare, di comunicare davvero.
Da questa comunicazione risulta la narrazione di una storia, che non riguarda soltanto la somma delle componenti chimiche del vino. La vera storia di un vino racconta delle condizioni climatiche della stagione in cui è stato prodotto; di quanto tempo è trascorso da quando sono stati piantati i vigneti, o della gente che lavora la terra da generazioni. Roberto sa che tutti i grandi vini raccontano una storia simile, una storia che si arricchisce sempre più. Quando oggi il consumatore beve un vino, che se ne renda conto o meno, entra in contatto diretto con quella storia.
Ed ecco da dove viene questo libro: racconta ciò che sta dietro ad alcuni dei vini più importanti del mondo. In parte fantasia e in parte storia, ci stimola a pensare al significato di un vino, e a come ci lega alle altre persone che l’hanno bevuto.
In fondo, nonostante il nostro gap linguistico, Roberto e io ci capiamo benissimo, grazie al vino e alle storie che è in grado di raccontare. Ed è questa la vera cifra distintiva dei grandi vini.
JAMES MOLESWORTH
Questo libro è dedicato a quanti hanno compreso che si beve per ricordare, non per dimenticare. Ciò che rende unico il vino ancora così misterioso, ancora tutto da esplorare, è la sua capacità di evocare, parlare, tradurre, narrare.
È scritto per quanti sanno o intendono capire che il vino è storia, fatica, amori, sogni, dolori, speranze. In una parola vita. Per quanti intuiscono che l’uomo e il vino sono l’uno lo specchio dell’altro.
Attraverso il vino noi uomini di vigna tentiamo di svelare il mistero delle profondità della terra. Attraverso il vino vogliamo ricordare l’antico e immaginare il futuro. O, se preferite, immaginare l’antico e ricordare il futuro.
L’opera si compone di trentotto bicchieri, divisi in otto capitoli. Ogni bicchiere apparentemente non ha un nome, occorre entrarci, apprezzarne vita e storia, per svelarne l’identità.
Così come ogni bicchiere di vino si innalza in controluce per coglierne il colore, si offre al naso per svelarne i misteri e solo infine concede il suo frutto, allo stesso modo i nostri bicchieri di libro si apriranno poco a poco.
L’identità di ogni bicchiere sarà perciò nota solo alla conclusione di ogni viaggio. Immaginabile attraverso il suo narrare. Comprensibile attraverso i suoi aneddoti. Scontato per chi nel bicchiere saprà entrare, capire, decifrarne la Vinosofia.
Vinosofia. La giusta temperatura della vita. Il giusto frutto, nella giusta occasione.
Chissà che non sia questa la più autentica quanto imperfetta, imprecisa quanto appropriata Guida dei Vini. Una Guida errante, fatta anche di errori. Una Guida che non sa, perché vuole solo capire. Perché di fronte al vino vuole, soltanto e ancora, ricercare.
Buona lettura, buona degustazione.
L’impiegato dell’hotel La Perla sbuffò per il caldo afoso di luglio. Insopportabile. Sentì un rumore lungo la scala e si girò svogliato. Eccone un altro. L’americano scese lentamente, gli consegnò la chiave della 205 e gli si parò davanti. Era un ragazzo, poco più di vent’anni. Convinto che il mestiere imponesse precauzioni, si spinse a osservarlo. Siccome non spettava a lui placare le fantasie degli ospiti distratti e curiosi, ripeteva senza slancio quello che volevano sentirsi dire. Lo inquadrò subito, un altro che non sa niente di tori, di corride, di sangue e di vino. Un altro imbecille attirato lì dal furore popolare che ogni anno accende Pamplona, per assistere allo spettacolo della grande tradizione. Non li sopportava e ripeteva le solite parole, avvolgendoli in una bolla d’aria dove fiorivano paure, sogni, avidità. Prese la chiave, sospirò annunciando lo scenario. Per la feria di San Firmin giri a sinistra, fa cento metri e prosegue diritto, lì incomincerà a incontrare gente ma attento, lei non conosce i tori, l’impeto della loro corsa, la pazzia popolare che trasforma questa festa in un rito insieme sacro e pagano, di vita e di morte… insomma può essere anche pericoloso. Era quello che ’sti coglioni volevano sentirsi dire, e lui lo diceva. Rincarò la dose: attento, mi raccomando, in quella furia c’è gente che ci muore, che finisce calpestata, che non capisce più cosa accade. Attento ai tori, attento alla calca, attento al vino… Lo doveva sempre ripetere, ma l’altro se n’era già andato. E chi se ne frega, posso mica fare io la parte dei suoi genitori.
L’americano non conosceva Pamplona, né la Spagna. Quel caldo giallo, quella parlata intensa, quelle ombre cupe e improvvise lo avevano piacevolmente stupito. Passò oltre le guglie di una grande chiesa, girò, gettò l’occhio in un cortile riempito di un silenzio surreale, rotto all’improvviso dal grido di un bambino che pareva morire e invece giocava, giocava… era solo un gioco. Continuò. Fu un attimo. Cominciarono a piovergli incontro uomini dai capelli neri e lucidi, scanzonati e abbronzati, e donne dalle gonne ampie, svolazzanti, che lasciavano intuire gambe sode e cosce profonde, ammiccanti. Si raddrizzò. Gli piaceva, gli piaceva quella Spagna chiassosa. Tirò diritto nel sole, al centro del rumore, della calca, al centro di tutto… Come se poi vi potesse essere un centro di qualcosa, in quella piccola città. Ma cosa mai era destinato ad accadere?
Per ora non accadeva null’altro che il bianco e il rosso. Bianco, bianco come la calce sulle case, bianco come il sole neppure più giallo ma accecante, bianco come tutti i vestiti del popolo in festa, donne e uomini nel giorno del Signore e per festeggiare il Santo, turisti in bianco di pantaloni e magliette. Rosso, rosso come i gerani che inondano ogni balcone, rosso come i foulards al collo e alla vita di quel popolo in festa, umanità pronta a celebrare il rosso del vino e il rosso del sangue che presto avrebbero colorato di lucido rosso le strade. Il ragazzo fremette. Gli piaceva, Dio come gli piaceva tutto questo.
L’americano capì che qualcosa stava per accadere. L’aria si era fatta tesa, elettrica, prendeva lo stomaco e la testa. Gli uomini, giovani e vecchi, muti o già urlanti si accalcavano lungo i marciapiedi, preparando il rito violento. Alcuni scattanti, virili, con gli sguardi orgogliosi verso la propria donna o sprezzante verso gli amici. Altri maturi, gonfi, vogliosi di rinnovata gioventù. Altri ancora ebbri di passione e di vino, vacillanti, malfermi sulle gambe chiamate a dimostrare la forza. Bianchi e rossi anche loro, puliti e sporchi, lieti e disperati, tutti insieme in attesa della belva. E infine la belva arrivò.
E anche lui, quando arrivò, si ritrovò lì in mezzo, in quel turbinìo di amore e di morte, di santità e di bestemmia, di profumo e di vomito. I tori correvano all’impazzata, spinti da urla di scherno e violenza. Simboli del potere animale umiliato e vilipeso prima di essere ucciso, occupavano tutta la strada inseguiti da uomini che li rincorrevano, scansavano, superavano, gettandosi ai loro fianchi con grida grottesche. E le donne, ancor più mostruose dei tori e degli uomini, deformate nel volto e nelle bocche che urlavano parole volgari, aggressive, abbandonate a un rito collettivo liberatorio e crudele… Non conosceva la loro lingua ma ne intuiva il senso profondo guardando quei fianchi che si agitavano, quelle mani che salivano al cielo, le labbra e gli occhi dilatati dalla voglia, dal piacere, dalla paura.
Era estasiato. Travolto. Ubriaco di folla, di vita, di violenza, d’amore. Si gettò su quel piccolo otre di cuoio che qualcuno gli offrì, bevette e ribevette, bevette ancora quel caldo sangue di vite che era un vino, mentre davanti ai suoi occhi in un turbinio di zoccoli, corna, gambe, urla già il primo sangue correva sulla strada, o forse il primo vino, o forse insieme il sangue e il vino…
Era madido, madido di sudore ed ebbro quando arrivò alla Plaza de toros. E ancora bevendo ammirò il Rito Giusto e Antico. Morte, ai tori spettava la morte. Senza pietà. Ma rispettando la belva, il suo sangue, il suo vino. Fu trascinato infine fuori, sospinto dalla folla che già tornava a invadere le piccole vie del borgo. Vagò per trattorie, locali, botteghe. Mangiò con le mani, afferrò carni e verdure, bevve e ribevve. Ballò, ballò fino all’alba e poi fu preso dalla furia. Doveva. Ora doveva, doveva. Doveva lasciare qualcosa di quella Fiesta. E scrisse: «... a un tratto gente cominciò a venir giù per la strada. Correvano vicini. Passarono e sparirono verso l’arena, poi dietro di loro altri uomini corsero più veloci, poi vennero pochi isolani che davvero correvano. Dietro di loro c’era un piccolo spazio libero, poi i tori venivano al galoppo e roteando le corna. Il tutto scomparve alla vista dietro l’angolo. Un uomo cadde e si tirò da parte, rimase immobile disteso. Ma i tori passarono oltre e non badarono a lui. Tutti uniti correvano».
Ora, solo ora era davvero stremato. Raccolse le mani, le ossa, i fogli di carta. Non seppe neanche come gli si parò di fronte l’hotel La Perla. Chiese la 205, salì, vomitò. Poi prese sonno. Quando scese era perfetto, impeccabile nella camicia azzurro cielo, e sorrise. La cuenta, por favor. L’impiegato sbuffò, prese nota della stanza, aprì il registro dei clienti. Il tuo nome, ragazzo? Hemingway. Ernest Hemingway.
«… Ora bevo in ogni piacere la sofferenza, e veleno in ogni vino; mai avrei immaginato che fosse tanto amaro essere solo, essere solo e senza di te» (Federico Garcia Lorca).
Don Camilo Hurtado de Amezaga, marchese di Riscal, passeggiava al tramonto per le vie di Bordeaux. Di quella città amava quasi tutto, e invidiava il resto. Latina era latina, e morbida come la parlata francese. Dolce era dolce, come i suoi vini rinomati nel mondo. Eppure sapeva esser fredda come le sue acque, rigida come i suoi prezzi, furba come i suoi affari. Città colta e doppia, di vino e di mare, francese e inglese. Ma a che valeva, pensare tutto ciò? Anche oggi, ultimo giorno della grande fiera, avrebbe ricomposto i bauli, caricato i vini, imballato la merce e spedito tutto laggiù. Così vicino, così lontano.
Vicino perché le sue terre spagnole giacevano poco oltre i Pirenei, in quella Rioja che tanto anelava. Lontano perché lui viveva in esilio a Parigi: la famiglia di proprietari terrieri non era riuscita a imporsi sulla sua sfrenata passione civile. Giornalista e scrittore controcorrente, fondatore del giornale madrileno «El Dia», aveva pagato un prezzo assai caro per le sue idee, troppo moderne e incendiare agli occhi delle grigie stanze del potere. Ma Bordeaux era così lontana anche per un’altra ragione. Mai e poi mai – persino adesso che forse si apriva uno spiraglio e forse avrebbe potuto rimettere piede in patria – sarebbe riuscito a riprodurre nella sua Rioja un nettare divino come quello che nei giorni amari dell’esilio aveva prima conosciuto, poi apprezzato e infine adorato. Anche se in cuor suo, da autentico e tenace gentiluomo di Spagna, a quella ambizione non avrebbe rinunciato per tutta la vita.
La svolta, come sempre nella vita, fu improvvisa. Correva l’anno 1850, e Don Camilo tutto poteva sospettare fuorché di trovarsi in un limpido mattino nella sua Rioja. E questa volta – solo per questa volta, si disse – ci resterò. Tenacia, pazienza, tempo. E poi tempo, tenacia, pazienza. Don Camilo programmò il futuro, che volle legare a quello del vino e che finì per legare entrambi alla gloria della regione destinata a far grande la Spagna.
Guardando a Bordeaux, pensando a Bordeaux e inseguendo Bordeaux, il marchese intraprese un’opera colossale. Non solo una grande cantina e un possedimento più vasto di ogni lontano parente di Francia, ma lungo un decennio Don Camilo fece scavare un sistema di cantine sotterranee che – uniche – avrebbero preservato i vini dall’infuocato sole iberico, cucendo insieme quel frutto unico al mondo e una nuova, pionieristica tecnica di invecchiamento e affinamento. Al solerte marchese, tuttavia, non era sufficiente una tecnologia analizzata e riconcepita a tavolino, capace di dare ai suoi vini ciò che nessun vino di Spagna aveva avuto in dote. Occorreva anche la scelta giusta, per dare sulla terra giusta il giusto frutto, capace di cogliere il più ambizioso dei suoi obiettivi.
Fu questa la vittoria di Don Camilo. Che dalla Francia amava tutto, anche gli enologi, come quel tal maestro Jean Pineau, bordolese ovviamente, che al servizio del marchese mise tutta la propria perizia e l’indiscusso fiuto. Eppure il marchese seppe dire di no anche all’amico enologo, quando giunse il momento della grande scelta. Già: quali viti piantare sulla terra dei propri sogni? A quale vitigno affidare la scommessa di un grande campione di Spagna, capace di eguagliare e sfidare la Francia? Fu contro tutto e tutti che Don Camilo impose la sua volontà. E su oltre duecento ettari stabilì di destinarne soltanto un quarto agli uvaggi bordolesi, un fazzoletto all’amato Pinot Noir e tutto il resto a quel vigoroso vitigno di Spagna che sin da bambino aveva conosciuto e amato. Così, come Don Chisciotte e Sancho Panza, Don Camilo e il suo vino si misero per strada e affrontarono il viaggio. A tutti pareva un’ennesima battaglia contro i mulini a vento, scatenata in un turbinio di nulla da quell’hidalgo presuntuoso.
La singolar tenzone durò quindici anni. Quindici vendemmie, centinaia di contadini, quintali di uva, migliaia di botti. E migliaia di giorni e di notti spesi inseguendo la perfezione e la grandezza di un vino. Infine, alla vigilia del fatidico 1865, Don Camilo compì il grande passo. Avrebbe iscritto uno dei propri vini al concorso internazionale di Bordeaux. Sissignori, una sfida a viso aperto. Irremovibile davanti ai lavoranti, all’enologo, agli amici che in umile processione provavano a scambiare parola cogliendo il migliore dei suoi umori, Don Camilo opponeva un gelido rifiuto. Mai e poi mai presenterò al concorso un vino fatto con il francese Cabernet. Non sarebbe leale. Quello che andrà a Bordeaux sarà il mio vino, il nostro vino, il vino di Spagna.
E fu così che in quel freddo 1865, con stupore generale in Francia e in Spagna e nell’incredulità degli esperti, il concorso internazionale di Bordeaux assegnò il primo posto a uno strano vino, sconosciuto ma inequivocabilmente iberico nell’appellativo, nell’assonanza, ma anche nel gusto e nel calore. Fu il trionfo del Marchese di Riscal. Era nata la grande Rioja del vino. E Don Camilo entrò a far parte dei grandi che seppero dare gloria imperitura al vino di Spagna.
Fernando VII regni pure sulla Spagna, ma nella Sierra il re sono io. Sì, sono io l’eroe di Andalusia. Io, uno dei banditi più popolari di Spagna. Fiero nell’animo quanto lesto di mano. Spietato con i prepotenti e generoso con i deboli. Mattiniero, svelto o prematuro come l’orgoglioso frutto dell’uva, e forse per questo soprannominato dal popolo proprio con il nome di quel vino buono, forte, orgoglioso. Io, il bandolero José María Hinojosa, nacqui nel 1800 a Jauja, lindo borgo della provincia di Cordoba. Il mio volto ancora oggi non posso raccontarlo, perché è giusto che resti avvolto nel mito. Per il piacer vostro, comunque, fui biondo e dai fini lineamenti, benché secondo un ordine di cattura emesso dallo spregevole Vicente Quesada – capitano generale di Siviglia – venni descritto come di bassa statura, tarchiato e di robusta costituzione. Mai il re, comunque, né Quesada né alcuno dei suoi sbirri furono come me sulla bocca di tutto il popolo d’Andalusia. Le mie gesta fecero sognare e parlare gli uomini sino a oscurare la malattia e la sorte del sovrano di Spagna, mentre le donne andaluse non mancavano di favoleggiare – e con quanta ragione – sul mio spirito galante. No, non temete, non richiamate i bambini accanto a voi quando si parla di me, perché mai feci del male a un giusto, o a un povero. Il mio torto fu quello di vigilare sulle gole nella Sierra, e lì talvolta pretendere un’oncia d’oro per ogni carro che attraversava quelle contrade. Oro per il popolo affamato, non per me. Oro per l’Andalusia, non per i miei uomini. Fu contro di me e gli altri bandoleros – uomini di cuore e di coltello, mai banditi come poi ci vollero raccontare – che il re istituì la Guardia Civil nel 1844, obbligandoci ad abbandonare la via delle montagne ed esponendoci al pugnale dei traditori. Perché io – ricordatevelo bene – non caddi certo per mano dell’autorità o in un leale duello, ma solo per mano di un vil traditore. Per questo, anche per questo, il mio nome è ancor oggi cantato in tutta la Spagna. Insieme a quello – altrettanto amato e buono anch’esso – del più grande fra i vini di Spagna.
Tempranillo
Zorro. Affabile, orgoglioso fino alla sorpresa, fiero sino alla testardaggine. Classico ma originale, agile, imprevedibile. Se per la serata avete spiritualmente indossato un ampio mantello nero, un cappello a falda larga e una mascherina per celare (ma anche esaltare) uno sguardo forte, intenso, quasi insostenibile, ebbene siete perfetti per la Vinosofia del Tempranillo. Vino da portare in omaggio quando si riceve un invito. Vino per le occasioni curiose, vino di una galanteria cavalleresca, non erotica ma distaccata. Vino di carattere terroso, animale. Vino toro, che può maturare presto e lanciarsi in una giovanile corsa sfrenata oppure invecchiare per lustri in botte. Solenne come un toro al centro dell’arena, o come Zorro che irrompe in uno stucchevole salone delle feste, può stupire, lasciare interdetti, persino intimorire. Ma di Zorro ricordatevi sempre l’allegra risata, il sorriso smagliante, l’ironia elegante. Zorro è anche tutto questo. Certo, fossimo Sacerdoti del Vino, sul Tempranillo vi avremmo indottrinati così: colore rosso rubino intenso, al naso esprime note floreali di viola, fruttato di ciliegia e mora, espressioni di spezie dal cuoio ai chiodi di garofano, al palato è caldo, secco e morbido… Ma noi che Sacerdoti non siamo, ve ne diciamo anche un’altra a bassa voce (che non ci sentano altrimenti saranno guai per la vita). Pssss…: una bella bottiglia di Tempranillo, due stecche di cannella, un baccello di vaniglia, due pesche gialle sode, un’arancia, un limone, dieci chiodi di garofano e un po’ di cognac. Ah, il Tempranillo che si fa Sangria! Non sarà enologicamente corretto… Ma che Fiesta!